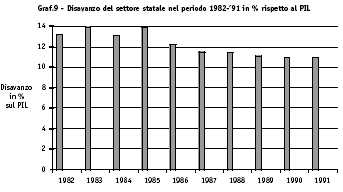1. Gli anni ‘80 e il forte impulso ai processi di privatizzazione
Generalità
Dagli inizi degli anni ’80, si è verificato in tutti i paesi a modello capitalista, anche dove più marcata era la scelta per l’economia mista, un processo di assestamento della presenza pubblica in economia; questo è avvenuto, almeno nelle intenzioni dichiarate, soprattutto per tentare di adeguare la gestione produttiva pubblica alle nuove condizioni della concorrenza internazionale. Le motivazioni principalmente addotte, erano quelle, in sostanza, più legate a ragioni politico-formali che a reali esigenze di efficienza economico-produttiva; pertanto la motivazione di rendere maggiormente competitive le imprese pubbliche si è poi necessariamente legata alle purtroppo reali lungaggini e controlli burocratici che spesso non sono riuscite a consentire alle aziende pubbliche un funzionamento più snello ed innovativo.
Il diverso ruolo assunto dallo Stato nelle regole della gestione delle imprese pubbliche ha visto il rafforzarsi dei processi a ritmi intensi di “privatizzazione”; sottolineando con questo termine un maggior ricorso al privato anche per la soddisfazione dei bisogni collettivi prioritari. [1] Si giunge così ad una conseguente riduzione del potere dello “Stato-imprenditore” e allo stesso tempo a forzare il processo di privatizzazione dello stesso Welfare State, imponendo un restringimento delle sue caratteristiche di universalismo delle prestazioni pubbliche fondamentali (incentivando, così, un sempre maggior ricorso alla sanità privata, all’istruzione e formazione a connotati aziendali, al ricorso a forme pensionistiche integrative private, ecc.).
Il modello di capitalismo italiano prima delle privatizzazioni degli anni’80
L’Italia si è caratterizzata, all’interno del contesto europeo, per la diversa e variegata posizione che ha assunto fin dagli anni trenta nei confronti dell’intervento pubblico nell’economia.
E’ così che si viene a creare un “via italiana al capitalismo” del tutto peculiare.
L’economia italiana si è sviluppata con delle caratteristiche particolari che comportano dei paradossi e delle contraddizioni.
Il boom economico degli anni ’50 ha visto la nascita di grandi famiglie capitalistiche che, passate indenni al processo di trasformazione economica-sociale post-conflitto mondiale, hanno inciso profondamente nelle modalità dello stesso sviluppo complessivo. L’industrializzazione che caratterizza questi anni ha comportato un divario tra il nord e il sud del paese, determinato soprattutto dal fatto che mentre per il Settentrione si sono adoperate politiche di integrazione con gli altri stati europei, il Mezzogiorno è invece rimasto sempre più isolato economicamente e socialmente. Ed è stata quindi la famiglia padronale, sia essa fondata su aristocrazie cittadine sia essa caratterizzata da un congiunzione solidale, ad essere la principale protagonista dello sviluppo economico del nostro paese. Si è passati dall’affermazione della piccola e media impresa familiare allo sviluppo della grande impresa familiare che hanno rappresentato la colonna portante del nostro sistema economico.
Lo scenario che si presenta nella realtà italiana è, quindi, caratterizzato in primo luogo dalla presenza di grandi holding private (a carattere familiare con il supporto del manager); ci sono poi le imprese pubbliche che hanno sostenuto lo sviluppo ed infine un numero elevato di piccole e medie imprese le quali per la loro innovatività si caratterizzano per un elevato livello di efficienza. [2]
Il nostro Paese è comunque a tutt’oggi caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese, mentre le grandi aziende restano ancora in numero molto ristretto; questa situazione è dovuta in gran parte a problemi di natura politico-economica e storico-culturale. L’Italia, infatti è uno Stato ancora giovane con alle spalle una storia molto frantumata e di conseguenza, a differenza di altri paesi quali la Germania, l’Inghilterra caratterizzate da sempre da burocrazie molto centralizzate, non ha acquisito una “cultura dell’organizzazione” ed ha accentuato solo processi di sviluppo individualistici basati sulla creatività e l’intraprendenza personale di alcuni componenti le grandi famiglie italiane.
E’ chiaro quindi che, per entrare a pieno titolo nei processi di globalizzazione che ormai caratterizzano il sistema economico mondiale è necessario adoperarsi affinchè si effettui una giusta conciliazione fra “famiglie e clan manageriale”; è quindi necessario superare il conflitto esistente fra famiglia e management per consentire una cooperazione tra queste due forze che permettano all’Italia di ottenere uno sviluppo unitario e strutturale.
Si assiste in sostanza a tutt’oggi ad una forma di imprenditoria di élite tipica delle grandi aziende, all’imprenditoria della piccola e media impresa ed infine all’imprenditoria assistita. Questa situazione fa risaltare lo storico problema delle “tre italie imprenditoriali”, in quanto gli imprenditori d’élite sono concentrati nell’Italia settentrionale, al centro troviamo un tipo di imprenditorialità diffusa, mentre al sud si trova il cosiddetto “imprenditore assistito” legato in maniera più diretta e dipendente al sistema politico.
Considerando che l’Italia fino alla seconda guerra mondiale era un paese basato su un’economia prevalentemente agricola, va segnalato che lo sviluppo industriale avutosi tra gli anni ‘50 e gli anni ‘70 si è concentrato solo su alcune zone senza estendersi alle aree più depresse.
Accanto alle imprese pubbliche tradizionali (Ferrovie, Monopoli, Poste) sono sorti nella prima metà del secolo una serie di enti di gestione (IRI,EFIM,ENI, ecc.) riuniti nel 1956 sotto il controllo del Ministero delle Partecipazioni Statali e del Ministero dell’Industria; se si aggiungono poi le varie imprese municipalizzate (gas, elettricità, trasporti) e le finanziarie regionali si ha un quadro completo del vastità dei settori economici controllati dallo Stato.
Le imprese a partecipazione pubblica sono state raggruppate quindi in holding: ad esempio l’IRI controllava le partecipazioni industriali, bancarie e altri servizi; l’EFIM controllava le partecipazioni nei settori metallurgico e meccanico; l’ENI quelle petrolifere, tessili e petrolchimiche, l’EAGG le imprese del settore cinematografico, l’EAGAT nel settore termale e l’EGAM nel settore minerario. [3]
Negli anni ‘70 si attua il cosiddetto “decentramento produttivo” che scorporando alcune fasi del processo produttivo le indirizza verso imprese di minore dimensione; in questo senso la piccola impresa si caratterizza sempre più per una elevata indipendenza dalla grande azienda committente, in quanto si specializza e si caratterizza per la sua innovatività. Si realizza in sostanza una forma di industrializzazione diffusa che ha il vantaggio di associare i benefici della piccola dimensione con quelli della grande. [4]
L’intervento dello Stato nell’economia è derivato dalle esigenze contingenti di compensare, integrare, ed in alcuni casi sostituire la gestione privata in settori in difficoltà con lo scopo di tutelare l’interesse collettivo. Va ricordato, infatti, che l’origine del sistema delle partecipazioni statali risale al 1933, anno in cui è stata costituito provvisoriamente l’IRI (divenuto nel 1936 un ente permanente) con l’obiettivo di acquisire parte delle tre banche miste italiane in evidente difficoltà e garantire quindi i depositi e il risparmio dei cittadini.
Nella situazione italiana che realizza quel sistema di gestione aziendale, chiamato da alcuni studiosi di tipo “padronale”, sono presenti forti limiti finanziari; il management deve tener conto delle risorse finanziarie già immediatamente disponibili prima di effettuare gli investimenti a meno di ricorrere a forti indebitamenti. Vi sono inoltre limiti economici perché si verifica un alto costo del capitale dovuto alle esigue possibilità degli azionisti di diversificare il proprio portafoglio di investimenti; infine anche la classe manageriale sovente è poco dotata di professionalità in quanto i ricambi del vertice seguono logiche dinastiche, politico-clientelari e non professionali.
Gli obiettivi di redditività di breve periodo hanno portato a scarsi investimenti nello sviluppo tecnologico e quindi a una limitata competitività delle imprese italiane nei confronti delle altre aziende europee.
L’impresa familiare ha sempre frenato lo sviluppo della cultura manageriale e quindi lo sviluppo competitivo dell’impresa stessa; questo accade perché ereditare un’azienda non presuppone la continuità dello sviluppo della stessa. Un’azienda non può fondarsi su fattori di continuazione genetica ma deve invece avere uno management attivo, dinamico, capace di promuovere strategie efficienti. La famiglia padronale ha sempre condizionato la vita stessa dell’azienda non riuscendo quasi mai a operare in sintonia con i managers.
La gestione dell’azienda in Italia, sempre avvenuta nell’interesse di pochi soggetti economici, sta portando sicuramente ad un sua perdita di importanza per le strategie di globalizzazione finanziaria del capitale internazionale. Il capitalismo italiano non è stato in grado di realizzare imprese con caratteristiche nuove, dotate di dinamismo, di autonomia, con facile accesso ai finanziamenti e soprattutto tali che non siano guidate da vertici ristretti ma piuttosto da una varietà di soggetti economici. [5]
E’ in tale contesto che per il capitalismo italiano, e per le stesse modalità di uno sviluppo equilibrato dell’economia del Paese, che si è reso fondamentale, addirittura indispensabile, l’intervento dello Stato; ciò per realizzare quel modello di “economia mista” in grado di compensare le inefficienze strutturali tipiche del capitalismo familiare italiano, e di garantire nel contempo una salvaguardia minima di quegli interessi collettivi che un modello di tal genere a caratterizzazione oligopolistica avrebbe senz’altro trascurato e compresso.
Sempre con tali finalità, e con lo scopo di salvare le imprese più deboli non in grado di reggere all’impatto oligopolistico delle grandi famiglie, evitando nel contempo la costituzione di monopoli in settori economici strategici del Paese, si capisce il ruolo fondamentale ed irrinunciabile assunto dall’ENI, dall’ENEL e dall’EFIM.
Per meglio comprendere l’importanza di questi enti di gestione basti ricordare che nel decennio 1971-1981 l’IRI, l’ENI e l’EFIM erano, in termini di occupazione, ai primi posti nell’elenco dei dieci più importanti gruppi industriali italiani (Cfr. Graf.1)
Si noti anche nelle rispettive Tab.1 e Graf.2 l’importante apporto occupazionale offerto dalle Partecipazioni Statali (dati 1960-1980), e le significative percentuali nel Mezzogiorno.
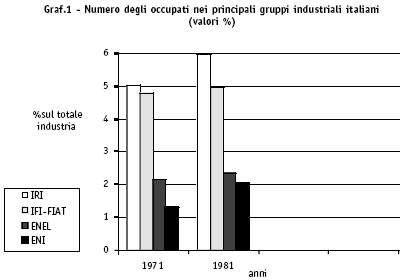

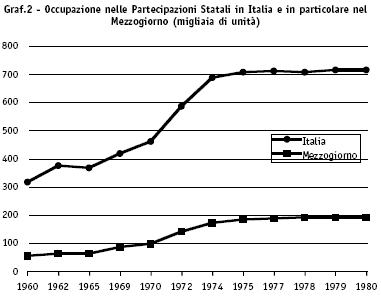
-----
Negli anni ‘70 l’importanza di questi enti di gestione è cresciuta ancora, soprattutto in relazione alla necessità di arginare la crisi che ha colpito la maggior parte delle imprese private e alla volontà di concentrare gli sforzi pubblici a favore delle aree depresse del Mezzogiorno. Basta riflettere a questo proposito sull’alta incidenza degli investimenti nelle Partecipazioni Statali in Italia e la percentuale nel Sud; in particolare si osservi l’alta percentuale rispetto al totale degli investimenti realizzati tra il 1970 e il 1972 da questi enti. (Cfr. Tab.2 e Graf.3)

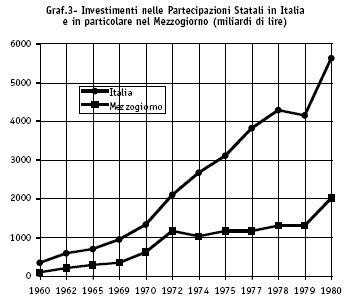
Va ricordato che in tale situazione, fino a inizio anni ‘80, l’unico azionista di questi enti di gestione è lo Stato; il capitale sociale, chiamato fondo di gestione, finanzia le società delle partecipazioni statali attraverso l’acquisto delle azioni o attraverso la concessione di prestiti.
La massiccia quantità di investimenti che questi enti hanno realizzato nel corso degli anni ha portato spesso a una carenza del fondo che, pur essendo stata risolta attraverso l’emissione di obbligazioni o l’ottenimento di prestiti da parte delle banche, ha portato a lungo andare a una situazione di sottocapitalizzazione ed alla crescita del rapporto tra indebitamento e fatturato. Si è avuta in tal modo una sempre maggiore dipendenza dal flusso di trasferimenti monetari da parte del Ministero del Tesoro e quindi un indebolimento dell’autonomia gestionale degli enti di gestione.
La crisi finanziaria del sistema, le discipline dei prezzi imposti che vincolavano la redditività delle imprese a partecipazione statale e la sempre maggiore dipendenza verso il potere politico che ha creato il perverso intreccio tra economia, affari e partitocrazia, e la decisa spinta verso un modello liberista puro, da “capitalismo selvaggio”, ha portato a prendere in seria considerazione l’idea di attuare un vasto programma di privatizzazioni.
Il programma di privatizzazioni prende definitiva forma nel nostro Paese negli anni ‘80 e si realizza seguendo tipologie diverse, soprattutto per tentare di rispondere a logiche macro di politica-economica a connotati di liberismo puro, e a logiche micro legate a modalità produttive e finalità gestionali adatte al tipo di azienda considerata.
In Italia, a differenza degli altri paesi europei, non è stata promulgata inizialmente alcuna legge, né si è svolto alcun tipo di dibattito politico o sindacale sul processo di privatizzazione. L’unica forma di controllo che si è stabilita è stata quella che prevedeva di informare il Ministero delle Partecipazioni Statali della possibile vendita e il CIPI (Comitato Interministeriale per la Politica Industriale) della possibilità offerta al fine di ottenere l’approvazione per la privatizzazione. Questa situazione ha permesso ai grandi gruppi privati di diventare i maggiori acquirenti delle imprese da cedere ed ha relegato i piccoli risparmiatori al ruolo di spettatori ai margini del processo di privatizzazione.
Guardando alla storia dei paesi moderni, soprattutto agli ultimi 150 anni, si può rilevare come processi di nazionalizzazione e di privatizzazione della proprietà si siano succeduti nel tempo un pò in tutto il mondo.
Le spinte sottostanti a queste ripetute inversioni di tendenza possono essere ricondotte a:
- motivazioni in merito alla scelta dei principi che devono presiedere al funzionamento del contesto economico - politico - sociale di un paese, ed alla loro evoluzione, nonché al ruolo dello Stato nell’economia. Le nazionalizzazioni sono spesso nate dall’esigenza di raggiungere obiettivi socialmente rilevanti. Di converso, le privatizzazioni rispondono, nelle apparenze, a obiettivi di miglioramento della competitività dell’economia e dell’efficienza del sistema;
- motivazioni legate a “patologie” del sistema economico - sociale, e a compatibilità del capitale internazionale.
In merito alle privatizzazioni, lo spunto é stato - soprattutto negli ultimi dieci anni - la necessità di risanare le finanze pubbliche, anche a seguito delle pressioni derivarti dai processo di unificazione europea, e dei conseguneti parametri di Maastricht di vero “soffocamento di ogni comaptibilità sociale”
Le privatizzazioni sono processi complessi che comportano, tra l’altro, la definizione degli obiettivi ultimi dell’operazione, la verifica dei presupposti giuridico-economici e delle compatibilità di politica economica, la selezione dei beni oggetto di privatizzazione, la definizione dell’entità, delle modalità e dei tempi della cessione ai privati. In particolare, la scelta degli obiettivi è un’operazione di carattere essenzialmente politico e, in quanto tale, implica metodi che variano da un paese all’altro, senza però trascurare il mantenimento, per quanto possibile, occupazionale.
Ciò premesso, gli obiettivi finali di un programma di privatizzazione, sono riconducibili, in primo luogo, al ridimensionamento dell’intervento dello Stato nel settore economico, in secondo luogo, ad un ipotizzato, ma la realtà fattuale dimostra il contrario, miglioramento della struttura organizzativa, economica e finanziaria delle imprese pubbliche; infine, ma non da ultimo, all’ampliamento del numero degli investitori nel mercato finanziario (obiettivo conosciuto sotto il nome di “azionariato popolare” o “diffuso”), che di fatto significa contributo alla “bolla finanziaria”, alla finanziarizzazione dell’economia.
Per contro, la scelta degli strumenti destinati a perseguire questi obiettivi dipende sia dalla considerazione di ciò che sembra possibile ad un dato momento, tenuto conto dell’ambiente sociale e politico, sia delle teorie economiche di chi decide le misure di politica economica.
Dal punto di vista tecnico, le fattispecie operative sono riconducibili alle seguenti:
- vendita diretta ad un unico acquirente;
- management employee buy-out;
- trattativa privata (private placing) ovvero vendita ad investitori istituzionali;
- vendita ad asta (asta pubblica) od a prezzo fisso (offerta pubblica di vendita - OPV - a prezzo fisso).
La scelta dipende da considerazioni che possono concernere sia il particolare tipo di attività che si intende smobilizzare sia il mercato in cui si intende effettuare la vendita.
Vi è una profonda specificità delle politiche e dei programmi di privatizzazione, a seconda dei paese e dei periodi.
E’ stato molto interessante ad esempio, seguire l’opera della apposita commissione tedesca che ha praticamente, in poco tempo, partecipato, venduto o riconvertito tutto il patrimonio statale della ex Germania dell’est.
Per quanto riguarda l’Italia, dopo un lungo dibattito il Governo presieduto da Giuliano Amato ha dato ufficialmente il via ad un processo di privatizzazione di imprese pubbliche mediante l’emanazione del Decreto Legge 11 luglio 1992, n° 333, convertito nella Legge 8 agosto 1992, n° 359, contenente “misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, il Governo ha redatto un piano di politica economica e sociale nel quale sono stati indicati gli strumenti - alcuni di natura tipicamente congiunturali, Atri volti a modificare la struttura del nostro sistema economico e sociale - ritenuti più idonei.
Nella categoria degli strumenti di intervento strutturale, rientrano le proposte di privatizzazione di parte delle imprese attualmente in mano pubblica, previste dalla Legge 23 ottobre 1992, n° 421. Il provvedimento prevede, fra l’altro, la trasformazione in S.p.A. di IRI, ENI, INA ed ENEL e l’attribuzione al Ministero del Tesoro delle azioni della Cassa Depositi e Prestiti nel capitale dell’IMI.
Le direttive fissate dal CIPE, con delibera del 30 dicembre 1992, stabiliscono che le dismissioni dovranno essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita a prezzo fisso (OPV), offerta pubblica ad asta (o asta pubblica) ovvero trattativa privata.
Tra i principi generali, si dispone in primo luogo che la determinazione del valore delle partecipazioni da dismettere dovrà essere effettuata mediante l’assistenza di “primari o intermediari specializzati”, nazionali o internazionali, in secondo luogo, negli statuti delle società da privatizzare dovranno essere introdotti meccanismi di tutela degli azionisti di minoranza.
Nel caso di cessione mediante OPV, dovrà essere garantita la massima diffusione dell’azionariato, mentre il ricorso alla trattativa privata potrà essere utilizzato solo in presenza di interessi pubblici di particolare rilevanza.
Il ricavato delle operazioni di privatizzazione andrà ad alimentare uno speciale Fondo di Ammortamento che dovrà essere utilizzato per acquistare sul mercato ed estinguere contestualmente titoli rappresentativi del debito pubblico in circolazione (Bot, Cct, ecc.) per un pari importo.
Il primo grande smobilizzo di attività nel sistema delle Partecipazioni Statali si è avuto negli anni ‘80 con oltre 70 casi di dismissione dei principali enti di gestione (39 attribuibili all’IRI, 15 all’EFIM e 21 all’ENI). Questo fenomeno si è rivelato però nei fatti molto ridotto, anche se identifica una particolare volontà politica di inversione di tendenza. Infatti se si considera che negli anni 1983-86 le imprese pubbliche acquisite hanno raggiunto il 6% del totale a fronte di un 10,4% di casi in cui appaiono come acquirenti, allora questi dati dimostrano che in effetti in tale periodo il settore pubblico non ha diminuito la propria presenza nel sistema produttivo ma al contrario l’ha ampliata (vedi Tab.3 e Graf.4).
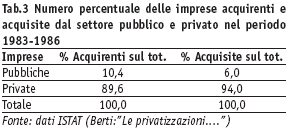
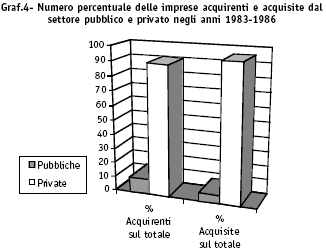
Tra gli altri, va ricordato che nel 1986 c’è stato il passaggio della società Alfa Romeo (IRI) alla FIAT, del gruppo Lanerossi (ENI) alla Marzotto; ci sono anche stati tentativi di privatizzazione che non hanno avuto successo: si pensi al caso dell’ENIMONT (società costituita con l’accordo tra l’ENI e il gruppo privato Montedison) conclusasi con lo scioglimento e il ritorno di tutte le sue attività all’ENI.
Le operazioni di cessione hanno riguardato solo quote di minoranza e spesso hanno interessato imprese, come l’Alfa Romeo o la Lanerossi, che si trovavano in condizioni di evidente difficoltà economica, anche se bisognerebbe indagare in maniera approfondita sulle reali cause politico-economiche di tali dissesti gestionali. In questi casi si è potuto addurre a motivazione il fatto che le operazioni di vendita siano state dettate più da un intento di risanamento finanziario ed economico che da una reale intenzione di natura squisitamente politico-monetarista che impone il passaggio del controllo dal settore pubblico al settore privato.
Per quanto riguarda poi le imprese di pubblica utilità, non si è verificato in questi anni un processo di privatizzazione inteso come vero e proprio trasferimento della proprietà pubblica al settore privato.
-----
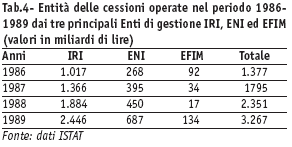 In
sostanza, però, il processo di privatizzazione che ha caratterizzato l’Italia
negli anni ‘80 sembra aver privilegiato interessi di parte, di alcune istituzioni
e grandi famiglie del padronato italiano, invece di conseguire finalità pubbliche,
o di allargamento della base azionaria in funzione di ventilati progetti di
democrazia economica basati sull’azionariato dei lavoratori e l’azionariato
popolare. L’intento è stato piuttosto quello di favorire grandi gruppi industriali
privati con il risultato di condizionare l’economia del Paese, sottoponendola
ancor più al dominio delle grandi famiglie.
In
sostanza, però, il processo di privatizzazione che ha caratterizzato l’Italia
negli anni ‘80 sembra aver privilegiato interessi di parte, di alcune istituzioni
e grandi famiglie del padronato italiano, invece di conseguire finalità pubbliche,
o di allargamento della base azionaria in funzione di ventilati progetti di
democrazia economica basati sull’azionariato dei lavoratori e l’azionariato
popolare. L’intento è stato piuttosto quello di favorire grandi gruppi industriali
privati con il risultato di condizionare l’economia del Paese, sottoponendola
ancor più al dominio delle grandi famiglie.
A confermare quanto detto basti ricordare il caso della tentata
vendita della SME (azienda alimentare), operante nel gruppo IRI, effettuata
nel 1985. Considerando che la SME era stata completamente sanata dopo gli interventi
di riforma avvenuti ne4l 1983 e nel 1985, è risultato chiaro che il tentativo
di vendita di questa impresa non era 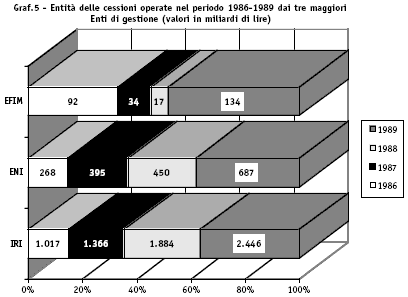 dettato
da una crisi economico-finanziaria quanto piuttosto dalla volontà di costruire
un grande polo alimentare nazionale a caratterizzazione privatistica, in grado
di fronteggiare eventuali acquisizioni estere. Il possibile acquirente scelto
dall’IRI (senza richiedere alcun tipo di approvazione da parte del Ministero
delle Partecipazioni Statali) era stato il gruppo Buitoni, con il quale era
stato già raggiunto un accordo preliminare. La completa mancanza di trasparenza
di questa operazione che avveniva a vantaggio di un gruppo privato a discapito
della finalità pubblica, ha portato a non autorizzare la vendita e alla riapertura
del processo di vendita attraverso un’asta pubblica. La Buitoni di rimando ha
aperto una causa legale nei confronti dell’IRI per il mancato adempimento degli
accordi. Questa confusa e contrastata vicenda ha interrotto la vendita della
SME, che fino al 1993 è rimasta nel settore pubblico.
dettato
da una crisi economico-finanziaria quanto piuttosto dalla volontà di costruire
un grande polo alimentare nazionale a caratterizzazione privatistica, in grado
di fronteggiare eventuali acquisizioni estere. Il possibile acquirente scelto
dall’IRI (senza richiedere alcun tipo di approvazione da parte del Ministero
delle Partecipazioni Statali) era stato il gruppo Buitoni, con il quale era
stato già raggiunto un accordo preliminare. La completa mancanza di trasparenza
di questa operazione che avveniva a vantaggio di un gruppo privato a discapito
della finalità pubblica, ha portato a non autorizzare la vendita e alla riapertura
del processo di vendita attraverso un’asta pubblica. La Buitoni di rimando ha
aperto una causa legale nei confronti dell’IRI per il mancato adempimento degli
accordi. Questa confusa e contrastata vicenda ha interrotto la vendita della
SME, che fino al 1993 è rimasta nel settore pubblico.
Anche per la cessione della Lanerossi ci sono delle particolarità; soprattutto grazie alla spinta delle organizzazioni dei lavoratori la vendita è avvenuta almeno nell’impegno formale di tre condizioni : la salvaguardia degli interessi dei livelli occupazionali, la garanzia del rispetto degli investimenti in corso, e infine a condizione che la società acquirente fosse di dimensioni simili alla Lanerossi. Il problema principale è stato soprattutto quello di un riposizionamento strategico dell’ENI: “Nel caso del tessile, il settore è stato acquisito dall’impresa pubblica per un’azione di salvataggio. Una volta compiuto il salvataggio e riportata l’azienda in equilibrio il compito si esaurisce e il problema della possibile dismissione si pone”; il presidente dell’ENI, Reviglio ha stabilito con queste parole la vendita della Lanerossi il 5 Febbraio 1987. Il gruppo Marzotto ha offerto la cifra più alta ( 167,9 miliardi di lire) ed ha acquistato la Lanerossi.
Il caso dell’Alfa Romeo è stato invece condotto senza alcun ostacolo e con una completa sottomissione allo strapotere del gruppo Fiat; anche se va ricordato che questa impresa, a differenza della SME, si trovava in condizioni disastrose dal punto di vista finanziario essendo in continua perdite di bilancio, dovute a scelte politico-economiche volutamente suicide. Si può sicuramente ipotizzare che il dissesto economico-finanziario dell’Alfa Romeo sia stato almeno in parte voluto, in modo tale che la privatizzazione risultasse quasi una “scelta imprenditoriale obbligata”; le proposte di acquisto delle azioni di questa società sono state formulate dalla FIAT e dal gruppo Ford (Stati Uniti). Una serie di fattori, tra i quali non ultimo la volontà di mantenere la gestione dell’impresa entro i confini nazionali, ha portato a privilegiare la proposta della FIAT.
La considerazione più ovvia da fare a conclusione di queste prime grandi privatizzazioni è lampante: l’IRI e l’ENI, sorte per contrastare i monopoli e difendere il settore pubblico, hanno in definitiva effettuato delle operazioni di privatizzazione che hanno rafforzato e non ridotto la concentrazione industriale. A tal proposito si vedano la Tab.5 e il Graf.6 che evidenziano in maniera inequivocabile la svendita dell’importante patrimonio pubblico dell’economia, ancora più accentuata per il sistema bancario, e il consolidamento delle concentrazioni oligopolistiche in mano alle grandi famiglie del capitalismo italiano.
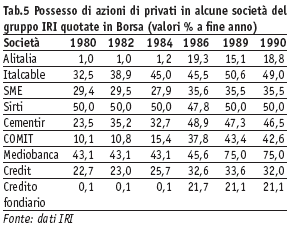
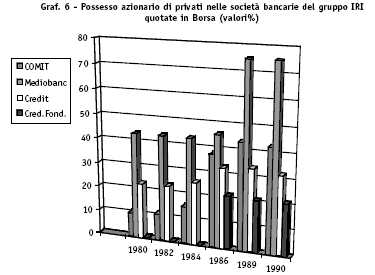
Per quanto concerne i servizi pubblici a livello locale (ci si riferisce al trasporto, alla luce, al gas, ai rifiuti urbani, alla sanità, alla gestione di parchi e giardini), va ricordato che la formula di solito adottata nel passaggio dalla gestione pubblica a quella privata, è stata quella dell’appalto ad imprese private (Cfr. Tab.6). Sono stati, cioè, affidati i compiti di erogazione dei servizi ad aziende private che vengono direttamente o indirettamente finanziate dall’autorità locale, la quale si riserva di operare solo una sorta di controllo e di direzione dei lavori.
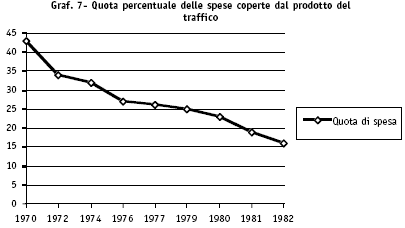

La legge n.210 del 1985, che ha disposto la trasformazione delle Ferrovie dello Stato da Azienda Autonoma in Ente Pubblico, può essere considerata come una ulteriore e diversificata forma di lento ma inesorabile percorso verso la privatizzazione dei trasporti, e dei servizi in genere di primaria importanza. Va considerato innanzitutto che le Ferrovie, con il loro disavanzo dovuto a una cattiva gestione manageriale e ad un sempre più perverso legame partitico-affaristico, per anni hanno costituito uno dei problemi più pressanti di finanza pubblica. I sempre maggiori disavanzi, uniti al forte aumento di squilibri di economicità e di efficienza, hanno portato l’azienda autonoma delle Ferrovie ad affrontare problemi sempre più seri; basta a questo proposito analizzare la quota percentuale delle spese correnti coperte con i proventi tariffari per notare come questa quota sia andata progressivamente diminuendo (vedi Graf.7 e relativa Tab.6a) .
 All’inadeguatezza
della politica gestionale, si è aggiunta poi la completa inefficienza nel campo
della qualità del servizio, creando così quegli apparenti presupposti, che in
realtà erano il risultato di un deliberato piano politico di affossamento della
struttura aziendale pubblica, i quali evidenziano le difficoltà registrate
nella gestione dell’azienda hanno portato alla promulgazione della legge del
1985 che, con l’istituzione dell’Ente pubblico, intendeva far acquisire una
maggiore economicità ed efficienza alle ferrovie attraverso una maggiore autonomia
patrimoniale, contabile, finanziaria, di direzione e gestione. Si trattava di
un primo passo verso un reale processo di privatizzazione, che ancora non si
è del tutto completato, e che al momento non solo non ha portato a risolvere
problemi esistenti nel settore dei trasporti senza migliorare i livelli di efficienza
ed economicità delle Ferrovie, ma che si è risolto in un apparente risultato
economico positivo per l’azienda, conseguito con tagli sul costo del
lavoro, sui costi di manutenzione e con incommensurabili costi
sociali; si vedano i continui incidenti e disastri ferroviari di questi
ultimi mesi.
All’inadeguatezza
della politica gestionale, si è aggiunta poi la completa inefficienza nel campo
della qualità del servizio, creando così quegli apparenti presupposti, che in
realtà erano il risultato di un deliberato piano politico di affossamento della
struttura aziendale pubblica, i quali evidenziano le difficoltà registrate
nella gestione dell’azienda hanno portato alla promulgazione della legge del
1985 che, con l’istituzione dell’Ente pubblico, intendeva far acquisire una
maggiore economicità ed efficienza alle ferrovie attraverso una maggiore autonomia
patrimoniale, contabile, finanziaria, di direzione e gestione. Si trattava di
un primo passo verso un reale processo di privatizzazione, che ancora non si
è del tutto completato, e che al momento non solo non ha portato a risolvere
problemi esistenti nel settore dei trasporti senza migliorare i livelli di efficienza
ed economicità delle Ferrovie, ma che si è risolto in un apparente risultato
economico positivo per l’azienda, conseguito con tagli sul costo del
lavoro, sui costi di manutenzione e con incommensurabili costi
sociali; si vedano i continui incidenti e disastri ferroviari di questi
ultimi mesi.
-----
2. Le grandi privatizzazioni degli anni ‘90
Privatizzare in nome dell’Europa di Maastricht
Negli anni ‘90 si è verificato in Italia il vero e proprio processo di privatizzazione con l’intento di ridimensionare la presenza pubblica nell’intero sistema produttivo del Paese. Le azioni del governo di questi anni confermano la volontà di attuare un programma completo di dismissione delle aziende pubbliche per risolvere i problemi produttivi ed economici dell’Italia.
Questo processo si è avviato in concomitanza alla costituzione del Mercato Unico Europeo (1992). Gli intensi processi di globalizzazione dell’economia a livello mondiale hanno portato il nostro Paese a cercare una ipotetica soluzione dei problemi della concorrenza internazionale con la cessione ai privati di interi settori di attività, ritenuti inefficienti, con l’obiettivo di risanare in questo modo una situazione ormai compromessa.
La stessa costruzione dell’Europa, basata sui parametri di Maastricht, altro non rappresenta che la definizione di uno scenario di un confronto aperto e diretto dei paesi europei alla partecipazione da protagonisti a quella economia globalizzata che misura lo scontro per la definizione delle aree di influenza e di dominio delle tre ipotesi liberiste: quella statunitense, quella giapponese e quella europea guidata dall’asse franco-tedesco. Una via europea che in nome di un malfigurato progresso, di un liberismo sempre più selvaggio si apre all’incontro-scontro con l’economia mondiale lasciando un sempre maggior numero di persone senza protezione, nella miseria, aumentando le diseguaglianze economico-sociali nel nome della gigantesca mistificazione europea.
L’Europa di Maastricht, lo stesso scontro in atto nel nostro Paese fra gli schieramenti politici che, anche se in maniera diversa, rappresentano e condividono la linea politica e socio-economica assegnate all’Italia dalla ricomposizione del capitale internazionale in chiave di ridefinizione neoliberista, sono i rappresentanti dello scontro in atto fra un modello di capitalismo, quale quello renano-nipponico, fondato più su un’economia sociale di mercato, e il modello neoamericano-anglosassone che trova una maggiore accentuazione individualista tendente alla massimizzazione dei profitti a breve e ad uno strapotere dell’economia finanziaria.
Dagli evidenti risultati che possono essere letti anche nel nostro Paese sembra prevalere una controffensiva, portata avanti dalla Confindustria e da varie forze politico-sociali, che tende all’affermazione del modello anglosassone. Basta ad esempio guardare ai livelli raggiunti dal tasso di disoccupazione in Italia e in Europa, alle politiche tendenti alla distruzione dello Stato Sociale e di qualsiasi garantismo solidaristico. Ma lo stesso tasso di disoccupazione presente in Germania e l’affossamento delle politiche sociali è una diretta testimonianza dei difetti e delle forti difficoltà dello stesso modello tedesco. [6]
E’ a partire dal 1990 con la costituzione di una Commissione Ministeriale (Commissione Scogamiglio), seguita poi da altri programmi di governo (Governo Andreotti 1991) che si è dato l’avvio a una serie di interventi legislativi atti a delineare un programma di privatizzazione delle imprese pubbliche.
Con la legge del 1992 n.35 erano state previste due fasi; nella prima si attuava la trasformazione delle Aziende Autonome e degli Enti pubblici in società per azioni; nella seconda fase invece si procedeva alla vendita delle azioni pubbliche. Questo programma ha presentato però molte difficoltà, dovute soprattutto al fatto che le imprese presentavano realtà molto diverse tra loro. Le Ferrovie ad esempio, in costante perdita, non rappresentavano certo alcun tipo di interesse per il mercato; l’ENI e l’ENEL avevano, tra l’altro, il monopolio della ricerca e gestione dei giacimenti di idrocarburi nella Val Padana e del trasporto e della produzione dell’energia elettrica.
Il programma del Governo Amato
Il piano presentato dal Presidente del Consiglio Amato a metà del novembre 1992, ha costituito per l’Italia il primo programma politico di privatizzazione.
Nell’ultimo decennio si erano già avute dismissioni anche importanti di aziende pubbliche (soprattutto nell’area delle partecipazioni statali: Alfa Romeo, Lanerossi, Cementir).
Questa strategia, in presenza di una mancata capacità dello Stato di onorare il proprio ruolo di azionista e nel permanere di rilevanti aree di perdita (siderurgia, cantieristica, chimica, impiantistica ), ha finito per ricondurre l’indebitamento dei gruppi pubblici (soprattutto quello dell’IRI) a livelli di altissima pericolosità. Le nuove ambizioni industriali, in definitiva, si sono scontrate con una congiuntura economica avversa e, innanzitutto, con la volontà di mantenere in vita imprese operanti in settori sempre più rischiosi e difficili.
La prima risposta a questa situazione, nei termini di un programma politico di privatizzazione, è maturata nel 1991, con l’idea di trasformare in società per azioni gli enti pubblici economici, collocandone poi le azioni sul mercato, passo questo obbligatorio per la trasformazione da “capitale di investimento o di sussistenza” a capitale sociale.
Si voleva, in questo modo dare la priorità al riassetto istituzionale, creando le premesse per una gestione meno condizionata da interferenze indebite.
La speranza di collocare sul mercato azioni di grandi conglomerati (la cui economicità prospettica è sempre di difficile percezione ), appariva però il lato debole del progetto. Si è arrivati quindi alla predisposizione di un’ampia e dettagliata dichiarazione d’intenti coinvolgente i principali enti pubblici economici (IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA).
Ha preso corpo, così, il primo piano di privatizzazione del nostro Paese, un programma molto articolato che è stato definito “Piano di riordino” piuttosto che “Piano di privatizzazione”. In base alla legge 359/1992, il piano di riordino doveva rispondere a due obiettivi molto generali: predisporre le operazioni necessarie alla valorizzazione di tutte le partecipazioni pubbliche e precisare il contributo dei ricavi da dismissioni alla riduzione del debito pubblico. Il tentativo compiuto è stato quello di rispondere ad entrambe le esigenze, anche attraverso l’individuazione di due ordini di operazioni di dismissione. Da un lato quelle strumentali a ricostruire l’equilibrio finanziario dei gruppi pubblici, dall’altro quelle più direttamente incidenti sul debito pubblico e quindi riferite ai gruppi stessi.
In altri termini, si sono fornite una serie di indicazioni per ottenere, nel più breve tempo possibile, un ritorno a gestioni privatistiche, ancora prima di una effettiva cessione ai privati.
Con il “programma di riordino delle partecipazioni statali “ della legge 359/92 si stabilisce che occorre:
• valorizzare le partecipazioni con la previsione di cessione di attività o settori d’azienda , con gli scambi di partecipazioni e con le fusioni , incorporazioni ed ogni altro atto necessario al riordino;
• quotare le società partecipate e definire il ricavo destinato alla diminuzione del debito pubblico;
• favorire l’azionariato diffuso con premi di fedeltà azionaria e agevolazioni fiscali ,evitando assetti proprietari instabili;
• limitare le dismissioni di attività considerate strategiche sotto il profilo pubblico;
• favorire la nascita di nuovi investitori istituzionali.
La delibera CIPE del 30/12/92 individuava tre tecniche di vendita :
• offerta pubblica di vendita , sia a prezzo fisso che con un prezzo determinato da asta;
• asta pubblica con eventuale preselezione dei partecipanti ;
• trattativa privata.
Successivamente, con il Decreto 389/93 , si è stabilito che l’alienazione può avvenire solo attraverso l’offerta pubblica di vendita e la trattativa privata diretta con preselezione degli acquirenti.
Nei successivi decreti vennero confermati tali orientamenti. Nell’ultimo Decreto 474/94 si è stabilito che i Ministri e gli organi competenti possono individuare le società a cui fare le cessioni al fine di costituire un nucleo stabile.
Il Governo Amato ha dato l’avvio effettivo alle operazioni proposte in precedenza (legge dell’8 Agosto 1992, n.359) con la privatizzazione dell’IRI, dell’ENEL, dell’ENI e dell’INA, trasformate in società per azioni.
Lo Stato ha mantenuto poteri molto ampi in merito alla vendita e all’acquisto di società, alle trasformazioni, alle fusioni, ecc. ( in precedenza queste decisioni erano assunte autonomamente dagli Enti stessi); inoltre si è data facoltà al CIPE di operare trasformazioni di altri Enti in Società per Azioni, indipendentemente dal loro settore di attività (con questa disposizione è stato possibile attuare la trasformazione dell’Ente pubblico delle Ferrovie in Società per Azioni).
Va evidenziato comunque che questo programma di privatizzazione si è rivelato in sostanza molto debole e poco efficace, anche perché lo scopo principale era quello di ridurre il debito pubblico con i proventi delle privatizzazioni (si vedano a titolo d’esempio la Tab. 8 e i Graff. 8 e 9).
E’ noto infatti il drammatico squilibro della nostra finanza pubblica dovuto soprattutto a quel perverso “equilibrismo consociativo” fra partiti di governo e di opposizione che ha caratterizzato la nostra scena politica e le conseguenti scelte politico-economiche in particolare negli anni ‘70 e ‘80. La Tab.8 consente di comprendere come il debito pubblico sia andato crescendo nel corso degli anni ‘80 e come il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo sia cresciuto di oltre 60 punti percentuali negli ultimi 20 anni (nel 1991 si è superato il 100%).
L’Italia presenta inoltre una percentuale molto elevata anche con riguardo al disavanzo, che risulta aumentato in termini assoluti, mentre ha subito una diminuzione del 2% rispetto al PIL.
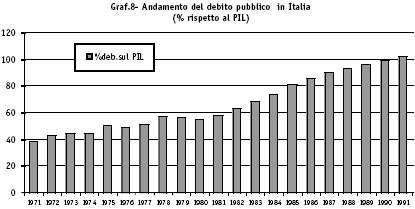
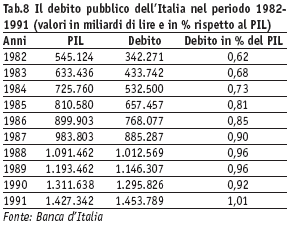
E’ evidente comunque che la politica di dismissione delle imprese pubbliche non può portare ad un miglioramento di questa situazione in quanto le entrate che si possono ricavare dall’intero processo di privatizzazione non sono in alcun modo sufficienti a coprire significativamente il complessivo debito pubblico. Un esempio: nel 1994 lo stock di debito era di 1.771.108 miliardi di lire, le entrate previste per il triennio 1993-95 dalle operazioni di privatizzazione è di 27.000 miliardi; i ricavi andranno quindi ad incidere sul debito pubblico solo per l’1,5%. Non è quindi la soluzione ottimale!
A legittimare definitivamente gli strumenti nel nostro ordinamento per un indiscriminato ricorso alle privatizzazioni, è stato il decreto legge 389 del 27 settembre 1993, reteirato in novembre, con il quale il Governo Ciampi, ha impresso una brusca accelerazione al processo di definizione del quadro istituzionale in cui si collocano le strategie di privatizzazioni. Dopo un primo incerto tentativo con il decreto legge del dicembre 1991, questo processo aveva conosciuto un avvio più deciso con il decreto 333 dell’11 luglio 1992, poi convertito con modifiche nella legge 3 59 dell’8 agosto 1992.
Quel provvedimento disponeva, con effetto immediato, la trasformazione di IRI, ENI, ENEL, e INA in società per azioni, semplificava più in generale la procedura di trasformazione in S.p.A. degli enti pubblici economici, e individuava nel Ministero del Tesoro l’azionista unico delle nuove società.
Sempre in base alla legge 3 59/1992, il Ministero del Tesoro era tenuto a sottopone al Parlamento un “ Piano di riordino e privatizzazione delle partecipazioni dello Stato”, rispetto al quale le Commissioni Parlamentari competenti dovevano esprimere un parere non vincolante.
Con il decreto legge 41 del 22 febbraio 1993 (non convertito), reiterato dal 118 del 23 aprile 1993 (convertito dalla legge 202 del 23 giugno) è stato soppresso il Ministero delle Partecipazioni Statali ( a seguito del referendum è stata abrogata anche la legge istitutiva del 1956). Con lo stesso decreto sono state anche riorganizzate le responsabilità istituzionali disponendo che: “Il Ministero del Tesoro esercita i diritti dell’azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato”.
Nel 1993 è stato soppresso il Ministero delle Partecipazioni Statali ed è stata liquidata l’EFIM; inoltre il nuovo presidente del Consiglio Ciampi ha affermato l’intenzione di continuare le privatizzazioni avviate da Amato; va rilevato che le operazioni di vendita non sono state supportate da una unica legge ma da una sequenza di decreti legge che contenevano le operazioni necessarie ad una veloce procedura di dismissione. L’intenzione del Governo di costituire delle public companies (seguendo l’esempio inglese) ha portato all’introduzione della “golden share”( decreto legge n.389 del 27 settembre 1993). La differenza tra questa azione speciale e quella omonima della Gran Bretagna si ravvisa soprattutto nel fatto che non si tratta di una riserva azionaria che permette al Ministero del Tesoro di esercitare dei diritti permanenti sulle società da privatizzare. I “particolari poteri“ quali il divieto di scioglimento ed il gradimento di partecipazioni rilevanti, pur essendo inseriti negli statuti degli Enti alienati, hanno una durata limitata nel tempo (solo per cinque anni); potranno inoltre essere inseriti solo nei settori strategici della difesa, delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell’energia.
Va rilevato inoltre che le società da privatizzare hanno il potere di limitare il possesso di azioni in riferimento a qualsiasi socio, compreso il Ministero del Tesoro; in aggiunta a ciò il decreto legge parla in modo molto generico della partecipazione dei piccoli azionisti al vertice delle imprese da privatizzare.
L’articolo 1 del decreto 389/93 elenca le modalità attraverso le quali è possibile trasferire a privati la proprietà delle partecipazione dello Stato: si tratta dell’offerta pubblica di vendita (OPV), del concambio con titoli pubblici, della trattativa diretta.
Il primo e il secondo di questi strumenti, in particolare, sono destinati nelle intenzioni a consentire il formarsi dell’azionariato diffuso.
Le norme contenute negli articoli 4 e 5 prevedono la possibilità di introdurre, negli statuti di imprese industriali istituti di credito e assicurazioni, limiti massimi alle partecipazioni detenute dai singoli azionisti o dai rispettivi gruppi di appartenenza.
Del gruppo, l’articolo 4 del decreto fornisce una nozione particolarmente estesa (vi si comprendono non soltanto la controllante e la controllata ma anche tutte le controllate di una stessa controllante) così da rendere molto stringente il divieto di superare determinate soglie di possesso azionario.
I limiti citati sono validi per qualunque azionista, pubblico o privato, derogando la normativa sugli istituti di credito pubblici che prevedeva una partecipazione minima dello Stato pari al 51 per cento del capitale. L’opzione a favore dell’azionariato diffuso è stata ribadita, affermando che negli statuti possono essere inserite clausole di salvaguardia delle minoranze azionarie e della loro effettiva partecipazione alla nomina delle cariche sociali.
Se l’OPV e il concambio fra titoli pubblici e azioni favoriscono il frazionamento della proprietà, la cessione di azioni mediante trattativa diretta ribadisce l’importanza assegnata ai mercati finanziari quale strumento fra i possibili impieghi produttivi.
Saranno infatti gli investitori istituzionali, selezionati secondo le procedure abituali dei mercati mobiliari internazionali, ad acquistare le partecipazioni cedute a trattativa diretta.
Secondo un’interpretazione suffragata dall’intervento del Presidente del Consiglio al Senato il 20 ottobre 1993, tutti gli strumenti di vendita previsti dal decreto potevano essere utilizzati per la cessione di istituti di credito e aziende gerenti pubblici serviti: entrambe le tipologie, infatti, si prestavano alla trasformazione in società ad azionariato diffuso.
Per le aziende di servizi pubblici era però impossibile privatizzare ricorrendo ai mercati mobiliari e alla diffusione dell’azionariato senza appositi meccanismi che consentivano di evitare trasformazioni delle società in esame contrarie al pubblico interesse.
Questi meccanismi altro non sono che i “poteri speciali” di cui parla l’articolo 2 del decreto, riferendoli obbligatoriamente al comparto dei servizi pubblici (più precisamente energia, trasporti e telecomunicazioni), oltre che, per ovvie ragioni, all’industria della difesa.
L’introduzione obbligatoria di poteri speciali negli statuti di queste società ha consentito di bloccare per cinque anni decisioni concernenti lo scioglimento o la liquidazione della società, il trasferimento all’estero dell’azienda e la modifica della sua missione imprenditoriale.
Inoltre, data l’esistenza di un limite massimo alle partecipazioni detenute dai singoli azionisti, il Ministero del Tesoro potrà esprimere un parere vincolante sull’assunzione di partecipazioni eccedenti il limite prefissato. Accanto alla possibilità di difendere l’esistenza dell’azienda e la natura pubblicistica della sua missione, il governo è quindi depositario della facoltà di bloccare passaggi di proprietà sgraditi, discrezionalmente ritenuti tali per ragioni non precisate in questo decreto e dunque interpretabili in maniera estensiva.
L’adozione di strumenti di vendita in grado di favorire la frantumazione della proprietà e la diffusione dell’azionariato, non è stata ritenuta sufficiente dalle Commissioni Bilancio e Finanza della Camera che, in occasione del dibattito sulla reiterazione del decreto, hanno presentato una proposta di modifica basata sull’asserita inadeguatezza delle norme a garantire l’intervento dei piccoli azionisti nei processi decisionali. La proposta prevedeva l’introduzione del voto di lista (che permette ai sottoscrittori di partecipazioni anche piccole di essere rappresentati nei Consigli d’Amministrazione delle aziende privatizzate), l’attribuzione agli intermediari finanziari della facoltà di rappresentare nelle assemblee gli investitori che affidano loro i titoli in gestione (fermi restando i limiti imposti al possesso di azioni e al relativo diritto al voto), la natura pubblica dei patti di sindacato tra gli azionisti.
Infine, le Commissioni Parlamentari, proponevano che la formula di privatizzazione adottata per i pubblici servizi e gli istituti di credito, venisse estesa anche alle imprese pubbliche non partecipate direttamente o indirettamente dal Ministero del Tesoro.
Lo scopo di tale richiesta era quello di allargare l’ambito di applicazione della formula di cessione mediante diffusione della proprietà resa più efficace dagli emendamenti in tema di procedure di voto delle assemblee.
Il Governo ha tuttavia preferito reiterare il decreto senza accogliere le modificazioni proposte: una clausola di retrodatazione avrebbe comportato, fra l’altro, una revisione delle procedure di privatizzazione già avviate e un conseguente ritardo nella conclusione delle vendite. Oltre ai dissensi sui contenuti degli emendamenti proposti, sono risultate determinanti per il Governo considerazioni relative all’esigenza di procedere rapidamente alle dismissioni avviate
Va detto, infine, che, oltre alla definizione degli strumenti di vendita, il decreto ha semplificato le eventuali procedure societarie da attivare per agevolare le dismissioni e garantirne il successo.
Il quadro di comando, così come viene delineandosi in base ai provvedimenti di legge e agli atteggiamenti concreti dell’Esecutivo è quindi caratterizzato essenzialmente da due soli livelli decisionali, ognuno dei quali gode di maggiore autonomia decisionale rispetto alla situazione precedente il decreto dell’11 luglio 1992. La transazione dal vecchio al nuovo regime di controllo sulle partecipazione dello Stato è però caratterizzata da alcune lacune nelle decisioni prese durante la crisi valutaria del ‘92 che rendono il quadro ancora non del tutto chiaro. In effetti, è l’Esecutivo a decidere le modalità di privatizzazione dei principali servizi pubblici (l’ENEL), delle assicurazioni (l’INA), degli istituti di credito (Credit, COMIT, e IRI) e dei grandi gruppi di rilevanza nazionale (l’ILVA), mentre il management dell’IRI e dell’ENI procede del tutto autonomamente nelle decisioni relative alla cessione di imprese estranee al cuore strategico dell’attività del gruppo. Tuttavia, rimane una zona d’ombra in cui il confine ha le diverse responsabilità istituzionali è meno nitido.
Nell’evolversi del processo di riordino e privatizzazione delle imprese pubbliche, quindi, rimane a favore del Governo un’area di discrezionalità che rende mobile il confine tra le responsabilità dell’esecutivo e quelle dei dirigenti. Il permanere di quest’area di incertezza può essere visto con timore, spingendo ad auspicare un’ulteriore precisazione normativa del quadro di comando, oppure può essere considerato positivamente come il margine di flessibilità necessario a far penetrare nelle privatizzazioni obiettivi di politica industriale.
Il terzo decreto legge emanato dopo la scadenza del secondo (scaduto il 30 gennaio 1994, che in pratica era una copia del primo) ha introdotto alcune novità. Tra queste merita attenzione l’introduzione del voto per corrispondenza degli azionisti di minoranza e la possibilità di acquisto di azioni a rate (non superiore a tre anni); vi sono inoltre diverse disposizioni atte ad aumentare la trasparenza delle operazioni di vendita e i poteri del Ministero del Tesoro.
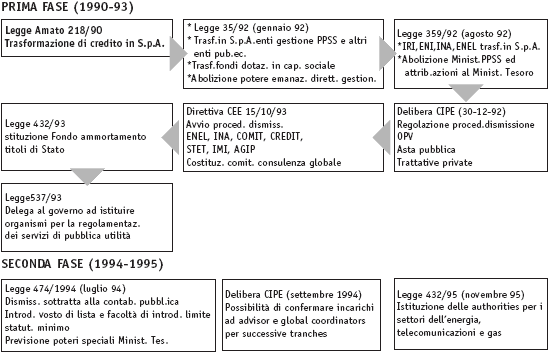
Di seguito si riporta l’evoluzione del quadro normativo riguardante le privatizzazioni in Italia per consentire di distinguere le diverse fasi con le quali questo processo di è attuato.
E’ interessante analizzare in modo più specifico la “filosofia” e le modalità attuative delle principali operazioni di privatizzazione che si sono avute a partire dalla fine del 1993 ad oggi, per comprendere e valutare se queste operazioni siano risultate realmente efficienti o se invece si sia trattato di un semplice trasferimento delle attività dal settore pubblico a quello privato, che ha in questo modo ha permesso a MEDIOBANCA , alle grandi familgie padronali, alle banche e alle assicurazioni, ai grandi gruppi del capitaismo italiano di accrescere il proprio potere nell’economia.
In Italia la speranza di un rimedio al debito pubblico ha animato tutta la prima fase del dibattito sulle privatizzazioni, riflettendosi concretamente negli orientamenti governativi.
Nel discorso programmatico tenuto alle Camere il 6 maggio 1993, il Presidente del Consiglio Ciampi affermò che le dismissioni non sarebbero state attuate “per dare qualche sollievo agli oneri finanziari dello Stato”. In seguito, il comportamento dell’esecutivo si è differenziato concretamente da quello dei due governi immediatamente precedenti per almeno due ragioni.
In primo luogo, le entrate derivanti dalla vendita di partecipazioni pubbliche non sono state iscritte nella Finanziaria, riconoscendo a un tempo la straordinarietà di questi proventi e la difficoltà di prevederne l’esatto ammontare e il momento di effettivo realizzo. Si ricorderà che la Finanziaria 1992 prevedeva 15.000 miliardi di entrate straordinarie derivanti dalla trasformazione in società per azioni dei gruppi pubblici e dalla successiva collocazione di partecipazioni sui mercati mobiliari. Le entrate relative alla cessione di queste partecipazioni, pur avendo carattere di straordinarietà, non venivano destinate in maniera esplicita alla riduzione dell’indebitamento. In questo modo si allentava la spinta al contenimento della spesa, dal momento che implicitamente si confondeva una beneficio temporaneo per un risanamento strutturale. La Finanziaria 1993 aveva parzialmente innovato rispetto a questa impostazione, destinando i 7.000 miliardi previsti a un Fondo di Ammortamento del debito pubblico. Si trattava però di una soluzione parziale. Se l’obiettivo resta quello di abbattere l’indebitamento, l’iscrizione in bilancio degli ipotetici realizzi delle dismissioni, permette al limite di raggiungere il risultato limitando la riduzione del disavanzo primario.
-----
In questo ambito è utile anche fornire un quadro esemplificativo delle entrate che lo Stato ha già incassato nella fase di privatizzazioni che si è avuta nell’arco di tempo 1993 - inizio 1994 (Cfr. Tab.9 e Graf.10).
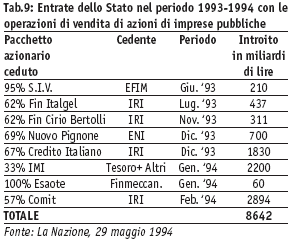
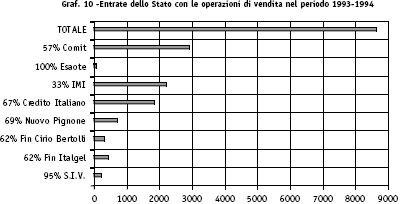
Abbandonata, poichè palesemente non credibile, la pista dell’aggancio formale alla riduzione del debito pubblico, il Governo ha definito altrimenti gli obiettivi da privilegiare nel programma di dismissioni.
Tra questi, ha assunto un certo peso la creazione di un azionariato diffuso, soprattutto con riguardo alle aziende finanziarie e a quelle di pubblici servizi. Più che di un obiettivo in se, tuttavia, la diffusione dell’azionariato sembra essere per il debole modello del capitalimso finanziario italiano lo strumento essenziale per favorire l’ispessimento dei mercati finanziari. Non a caso, il decreto Ciampi, che pure “inneggiava” alla tutela dell’azionariato diffuso tramite la previsione di limiti massimi al possesso delle azioni (articolo 4) e la garanzia della rappresentanza degli interessi delle minoranze (articolo 5), non ha incluso misure specifiche volte a promuovere e difendere la natura “popolare” della proprietà. Non sembra cioè, almeno in linea di principio, che alla diffusione dell’azionariato si attribuisca anche una valenza strettamente politica, simile a quella implicita nelle privatizzazioni britanniche, miranti tra l’altro a consolidare per questa via il consenso alla politica liberista del governo.
Anche il riconoscimento della strategicità dei pubblici servizi non è tuttavia da intendersi come interesse collettivo al potenziamento delle relative aziende, tramite una regolamentazione in grado di garantire la massimizzazione dell’efficienza, in condizioni di monopolio naturale e di realizzazione di rilevanti investimenti a redditività differita. Questa concezione della natura strategica dei servizi pubblici sembra esser stata abbandonata in favore di un’impostazione difensiva, che risolve nella conservazione della missione aziendale (e nella modifica in senso concorrenziale della regolamentazione) la giustificazione della partecipazione pubblica al capitale. Resta irrisolto il problema relativo alle politiche che verranno adottate alla scadenza dei poteri speciali garantiti dall’azione specifica, la cui durata è limitata a cinque anni.
Dall’altra il Governo considera le privatizzazioni un’opportunità non trascurabile per procedere al rafforzamento della grande industria, che deve essere messa in condizione di affrontare e sostenere la competizione internazionale e di consolidare gli assetti produttivi e occupazionali nazionali. Per questo, si ritiene indispensabile il ricorso ad acquirenti privati che presentino requisiti adeguati di vocazione imprenditoriale e solidità industriale e che siano in grado di predisporre e realizzare programmi di rafforzamento credibili; ciò si traduce in un forte intervento del capitale, industriale e soprattutto finanziario, internazionale.
Anche per quanto riguarda l’obiettivo di potenziamento dell’industria nazionale, la posizione del Governo Ciampi si differenzia significativamente da quella contenuta nel Piano Amato, che configurava la creazione di alcuni gruppi a maggioranza pubblica in comparti particolarmente significativi, il rafforzamento di questi gruppi avrebbe dovuto consentire di impostare e finanziare successivi disegni di politica industriale.
L’intento dell’Esecutivo Ciampi è stato, invece, quello di procedere alla formazione di nuove realtà industriali mediante la privatizzazione integrale e quindi la rinuncia alla partecipazione pubblica nel capitale.
Non viene perciò negata l’importanza strategica di alcuni comparti, ma lo strumento per garantirne il potenziamento è identificato nella capacità del Governo di decidere la cessione “sulla base di una attenta ponderazione delle diverse alternative, inclusa la possibilità di alleanze sia nazionali sia internazionali”. Verranno considerate strategiche quelle aziende che condizionano, per dimensioni o rilevanza settoriale, la sopravvivenza o le possibilità di sviluppo dell’intero comparto cui appartengono.
Inoltre, secondo quanto dichiarato da Ministero dell’industria durante l’audizione presso la Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati svoltasi il 9 novembre 1993, il Governo ha considerato prioritario il mantenimento in Italia dei centri decisionali delle aziende privatizzate, privilegiando la cessione del pacchetto di maggioranza ad investitori italiani. Anche questo si è rivelato un “bluff”, poichè nella realtà non si sono voluti assolutamente privilegiare i compratori italiani rispetto ai potenziali concorrenti esteri. Eventuali misure orientate a favorire gli investitori nazionali sarebbero state infatti inammissibili alla luce delle politiche comunitarie di difesa e incremento della concorrenza.
Per meglio affrontare il fenomeno privatizzazioni, il mercato finanziario mondiale, o meglioil capitale a spiccato connotato finanziario, si è attrezzato; sono nati “fondi chiusi”, i fondi pensione, i fondi immobiliari ecc., tutti specializzati nel trattare titoli di imprese in via di privatizzazione.
3. Alcuni “casi-studio”
Nel prossimo numero di PROTEO, come già precedentemente scritto, continuerà l’analisi-inchiesta sulle privatizzazioni, con approfondimenti e casi-studio trattati in un articolo della dott.ssa Rita Martufi. Di seguito si affronteranno dei casi-studio più significativi semplicemente al fine di introdurre il lettore nelle realtà aziendali che per prime hanno dato l’avvio al processo di privatizzazione nel nostro Paese.
Il caso SME
Dopo i tentativi falliti di vendere il gruppo SME negli anni ’80, l’IRI, nell’ambito del nuovo programma di privatizzazione, ha mostrato la ferma volontà di attuare la completa dismissione di questo gruppo industriale. Va ricordato che nelle operazioni di vendita si è scelto di procedere attraverso delle trattative private anziché costituire una public companies; ciò principalmente per due motivi: da un lato l’esigenza dell’IRI di massimizzare i ricavi (considerato il fatto che il gruppo SME era in buone condizioni finanziarie), in secondo luogo perché ormai da qualche anno rappresentava un’attività marginale per l’IRI.
Il gruppo SME è stato quindi scisso in tre società per le quali sono state adottate tecniche di dismissione diverse.
La prima società, l’Italgel S.p.A, è stata messa in vendita attraverso un’asta competitiva, che ha assegnato il 62% di questa società alla Nestlè. L’intento della Nestlè era chiaramente quello di rafforzare la propria posizione in Italia nei settori dei prodotti surgelati e dei gelati.
Anche il secondo gruppo di imprese, rispettivamente la Cirio, la Bertolli e la De Rica è stato venduto attraverso una trattativa privata. A differenza della vendita dell’Italgel però sono sorte delle complicazioni e delle polemiche dovute principalmente al fatto che la società acquirente la Fisvi era una piccola finanziaria agroalimentare che non presentava sufficienti garanzie economiche (al momento della vendita la Fisvi possedeva un capitale di 53 miliardi, contro i 310 che avrebbe dovuto pagare alla SME).
Per il terzo gruppo, GS-Autogrill, sono ancora in corso alcune operazioni relative alla sua completa vendita.
Nuovo Pignone
La dismissione del Nuovo Pignone si è perfezionata nel 1993 con la vendita del pacchetto azionario della società ad una impresa multinazionale americana, la General Electric, che aveva concorso con altri tre competitori : la Gec Alsthom (franco-inglese), l’ABB (svizzera-svedese) e la Dresser-Gersoll (americana).
Va rilevato che la General Electric si è impegnata a rispettare la piena autonomia gestionale e l’integrità produttiva dell’azienda. L’ENI ha venduto solo il 70% della Nuova Pignone, e non l’intera quota azionaria, con l’intenzione di mantenere i legami di carattere tecnologico e commerciale esistenti tra questa impresa e i settori strategici dell’ENI.
ENI
L’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) è stato istituito nel 1953 come Ente di diritto pubblico che agisce nei settori del petrolio e del gas naturale. Rappresenta una delle più grandi compagnie integrate nelle attività di ricerca e produzione di idrocarburi, di produzione e vendita di prodotti petrolchimici, di ingegneria e servizi, di approvvigionamento, trasporto e distribuzione di gas naturale di raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi.
Le attività dell’ENI sono svolte attraverso sei grandi società : Agip, Snam, Agip Petroli, Saipem, Snam progetti ed Enichem, in 84 paesi.
L’attività di ricerca e produzione di idrocarburi svolta attraverso l’Agip è sviluppata in Italia, in Africa (settentrionale ed occidentale), nel Mare del Nord, in Cina, negli USA e nei paesi dell’Ex Unione Sovietica; nel 1996 risultava essere al settimo posto (in termini di riserve) tra le imprese operanti nel settore del petrolio e del gas naturale.
L’ENI è, attraverso la Snam, il primo fornitore di gas naturale in Italia e il secondo in Europa (in termini di volumi venduti sul mercato nazionale); detiene inoltre il 41% della Italgas (distribuzione ai consumatori finali di gas naturale) e nel 1995 ha acquisito il pacchetto di maggioranza della Tigaz, la maggiore società regionale di distribuzione del gas ungherese.
Con l’Enichem, inoltre l’Eni è ai vertici europei nella produzione di etilene e di gomme stirene butadiene; l’attività di raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi è svolta attraverso l’Agip Petroli. Nel 1996 l’ENI ha acquisito una quota del 16.3% della società Ceska Rafinerska A.S. (repubblica Ceca); l’Agip Petroli opera anche in Africa ed in Estremo Oriente.
Con la Saipem l’ENI si colloca tra i maggiori operatori a livello mondiale nei settori di offshore, installazione di piattaforme e condotte sottomarine, mentre attraverso la Snam progetti si è specializzata nella fornitura di servizi all’industria petrolifera e chimica.
-----
Tra le altre attività svolte dall’ENi vi sono le attività di finanziamento e di assicurazione per le imprese gestite dalle finanziarie Enifin, Sofid ed Eni International Holding.
Nel 1992 l’Eni è stata trasformata in società per azioni ed, in base alle leggi emanate per la privatizzazione, il Ministero del Tesoro ha disposto la vendita al pubblico delle azioni. Il decreto del 10 maggio 1995 ha deliberato la vendita delle partecipazioni detenute dal Ministero del Tesoro nell’ENI S.p.A., attraverso l’offerta pubblica e il collocamento privato.
Nel 1996 circa 84.000 persone erano occupate nell’ENI S.p.A. (delle quali 8.200 assunte a tempo determinato) ed all’estero impiegava circa 25.500 dipendenti. La ristrutturazione che si è avuta negli anni che vanno dal 1992 al 1996 ha portato ad una riduzione del personale di circa il 33.5%; la principale causa di questa situazione va imputata alla chiusura di alcuni impianti industriali alla cessione di alcune attività e agli incentivi al prepensionamento ed uscita dall’Ente.
Come si evince dalla Tab 10 e Graf.11, la diminuzione occupazionale più rappresentativa si è avuta nel settore petrolchimico e nelle attività in corso di dismissione (si è avuta una riduzione del 53% nel primo e del 86.4% nel secondo).
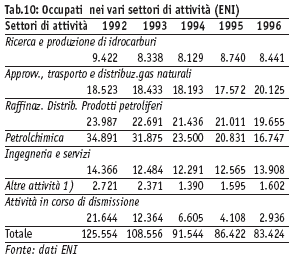
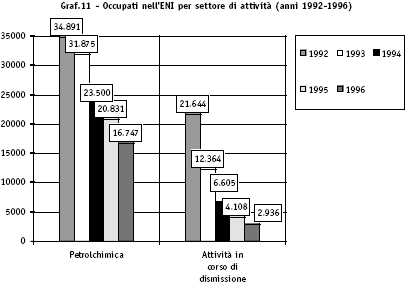
E’ interessante anche mostrare attraverso la Tab.11 e
il Graf.12 come sia stata ripartita, tra le varie categorie, la riduzione
del numero degli occupati. Dalla tabella a dal g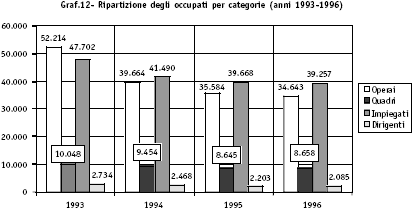 rafico
ci si accorge che dal 19
rafico
ci si accorge che dal 19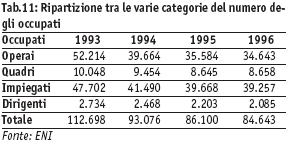 93
al 1996 si è avuta una diminuzione del 23,7% dei dirigenti, del 17,7% degli
impiegati, del 13,8% dei quadri e del 33,7% degli operai.
93
al 1996 si è avuta una diminuzione del 23,7% dei dirigenti, del 17,7% degli
impiegati, del 13,8% dei quadri e del 33,7% degli operai.
Va ancora evidenziato che negli anni che vanno dal 1994 al 1996 si registra un aumento di costi operativi derivati dall’incremento degli acquisti, dalle prestazioni di servizi e costi diversi delle attività del gas naturale e del petrolio ( ci si riferisce agli aumentati accantonamenti ai fondi svalutazione crediti, alla crescita del costo del gas naturale e delle materie prime dei prodotti petroliferi). Diversa è invece la situazione per quanto riguarda il costo del lavoro che registra un calo di oltre 117 miliardi di lire(l’1,9%).
In sostanza comunque, l’incidenza percentuale dei costi operativi
sui ricavi è aumentata (si passa dal 72,6% al 73%). (Cfr. Graf.13)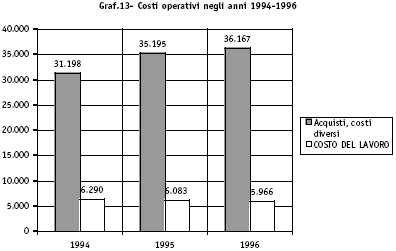
La privatizzazione dell’Eni ha avuto, nelle intenzioni formali, due obiettivi principali: il primo consisteva nell’eliminazione di settori in perdita e non strategici; il secondo invece intendeva garantire il supporto finanziario dei settori in sviluppo del Gruppo, rispettando l’equilibrio tra mezzi propri e debito.
Nella fase di attuazione dell’operazione di dismissione é stato garantita l’omogeneità di trattamento, predisponendo un’asta suddivisa in 2 fasi:
• la prima, in cui si prevede un offerta preliminare;
• la seconda, più articolata per la definizione dell’offerta finale vincolante.
In ambedue i casi i potenziali acquirenti hanno ricevuto le stesse informazioni nello stesso momento. Per consentire all’intera operazione il massimo della trasparenza è stata attuata una procedura d’asta tramite la pubblicazione di un annuncio che descriveva le fasi fondamentali e precisava il calendario.
Nel 1992 si è avviato il processo di cessione di attività nei settori :chimico, minerario - metallurgico , meccano - tessile e turistico; una tra le cessioni più importanti è stata quella del Nuovo Pignone.
Le operazioni di dismissioni si sono avute principalmente in attività che non consolidavano il business dell’ENI, ma operavano su interventi sociali.
La prima fase di privatizzazioni si è avuta nel dicembre 1995 ed è stata avviata anche grazie al record del bilancio consolidato del’94 ,che ha toccato un’utile netto di 3.215 miliardi, il più alto di tutta la storia e uno dei più alti in Italia. L’operazione di privatizzazione è stata rivolta all’intero mercato azionario con quotazioni a Milano, New York, Londra, Tokyo.
Il compito di coordinare l’operazione, deciso dal Comitato Interministeriale (Ministro del Tesoro, del Bilancio, dell’Industria e Presidente del Consiglio) è stato affidato all’IMI e a Credit SuisseFirt Boston; si è avuta una offerta pubblica italiana , una offerta pubblica internazionale e una offerta pubblica negli Stati Uniti.
Va ricordato che i dipendenti del gruppo, (i quali si impegnavano a mantenere ininterrottamente il possesso azionario per un anno), potevano ricevere azione gratis ogni 10 acquistate, con un massimo di 300; è stato riservato loro il 25% delle azioni, ma ne è stato utilizzato solo il 15%. L’Offerta, per la quota dei dipendenti è stata effettuata tramite la SOFID SIM S.p.A.
E’ stato, inoltre previsto il pagamento delle azioni mediante anticipo fino al 50% sul TFR.
Nella seconda fase del collocamento la composizione del consorzio internazionale è rimasta uguale a quella della prima trance. Nella prima trance hanno trovato maggior collocamento i grossi investitori ,in questa seconda fase si è cercato di favorire i piccoli risparmiatori con 3 strumenti diversi: sconto sul prezzo ,bonus in azioni e, se possibile, partly paid (pagamento rateizzato). La quota azionaria offerta dall’ENI , in questa seconda trance, è stata del 10%, con una parte rilevante destinata ai piccoli risparmiatori. Il giorno 21 /10/1996 il Tesoro ha deciso un prezzo massimo di 7.425 lire ed è stato concesso al pubblico uno sconto del 3.5% .
Il terzo collocamento è stato effettuato sulla base di quello precedente senza particolari cambiamenti. L’offerta pubblica di vendita è avvenuta dal 23 al 27 giugno 1997; il Ministero del Tesoro ha messo in vendita un miliardo di azioni, pari al 14,4% del capitale e a un controvalore di 10mila miliardi circa. In questo modo la quota pubblica è scesa dal 69% ( dopo il secondo collocamento ) al 51% del capitale.
Le azioni oggetto dell’offerta pubblica , con esclusione della quota destinata ai dipendenti dell’ENI , sono state collocate tra il pubblico attraverso il “Consorzio Italiano” di cui fanno parte l’IMI , la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano e l’Istituto Bancario San Paolo di Torino. Invece, le azioni riservate ai dipendenti sono state collocate esclusivamente per il tramite della SOFID SIM S.p.A.
Le azioni ENI sono state vendute attraverso un collocamento privato destinato ad investitori istituzionali , riservato ad Italia, Regno Unito, Europa e Resto del Mondo; un collocamento privato destinato ad investitori istituzionali riservato al Canada ed una offerta pubblica riservata agli USA .
I risparmiatori, per la prima volta, hanno potuto comprare le azioni , oltre che in banca, anche presso gli uffici postali.
In questi giorni è in corso un intenso dibattito fra forze politiche parlamentari, e altre forze sociali (sindacati confederali, Confindustrial, Banca d’Italia, ecc.) per dare definitivamente il via alla quarta fase di privatizzazione dell’ENI.
IL CREDITO ITALIANO
Il Credito Italiano (fondato nel 1870 [7]) è senza dubbio uno dei maggiori gruppi bancari del mondo; è quotato in Borsa dal 1895 e dal 1989 è quotato al sistema telematico di contrattazione internazionale dei valori mobiliari di Londra (SEAQ); nel 1992 il Credito Italiano era il settimo gruppo bancario italiano.
Tra le sue attività bancarie, parabancarie e finanziarie, svolte sia in Italia sia all’estero, vanno inclusi i finanziamenti, l’intermediazione in titoli, l’accettazione di depositi, finanziamenti all’import-export, operazioni di capital market corporate finance, gestione di portafoglio, sconto effetti, leasing, factoring, assicurazioni ed operazioni di cambio.
Nel 1993 l’IRI possedeva l’81,4% del suo pacchetto azionario (64,1% azioni ordinarie, e 17,3% azioni di risparmio); la quota restante era detenuta da circa 40.000 azionisti (cfr. Tab.12 e Graf.14).
Prima del 1990 (anno della legge Amato n.218) la banca e la sua società finanziaria (Credit Holding Italia S.p.A.) gestivano direttamente le società controllate, le categorie e le partecipazioni del gruppo. Nel 1992 invece sono state istituite altre due società finanziarie la Credit Holding Bank S.p.A. e la Credit Holding International S.p.A. che hanno affiancato la prima; le tre società hanno gestito quindi oltre alle attività bancarie nazionali, anche le attività non bancarie e le attività internazionali. Il Credito Italiano inoltre controlla direttamente, oltre alla SIMCredit (società di intermediazione mobiliare), anche la Banca Popolare di Spoleto.
La dismissione del Credito Italiano ha rappresentato, insieme a quella dello SME, la principale operazione su cui si è attuato il programma di privatizzazione in Italia.
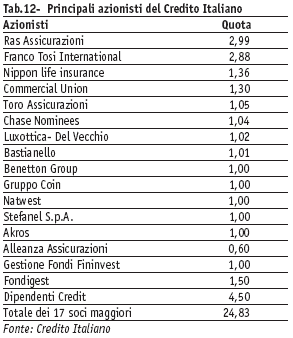
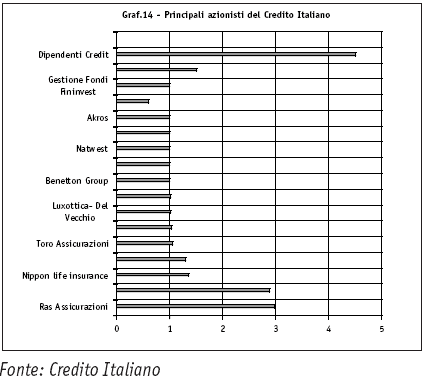
Il 6 Dicembre 1993, infatti l’IRI ha messo in vendita il 64% del capitale azionario della banca; l’offerta delle azioni (con esclusione delle azioni di risparmio ai dipendenti e degli investitori professionali) si è attuata solo in Italia; invece il collocamento privato di azioni ordinarie (riservate agli investitori istituzionali) si è svolta in molti altri paesi europei e degli Stati Uniti.
Con questa vendita lo Stato ha trasformato una banca di interesse nazionale in una public companies; l’offerta pubblica che ha riguardato il 40% delle azioni detenute dall’IRI ha coinvolto i piccoli risparmiatori, mentre i grandi investitori istituzionali hanno partecipato ad una contemporanea operazione privata che ha interessato anche gli investitori stranieri (è stato fissato come limite massimo di acquisto per gli investitori istituzionali ed esteri una quota pari al 2%). Alcune azioni privilegiate (il 17,4% del totale), azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie, sono state destinate ai dipendenti del Gruppo.
-----
L’idea era quella di creare con questa vendita una via di fatto solo apparente, ad una comoda forma di democrazia economica che tutelasse i piccoli risparmiatori; ma ciò è rimasto solo nelle intenzioni in quanto dopo la privatizzazione si è appurato che è emerso un pool di soci molto forti e l’assenza di una organizzazione efficace ha fatto si che i primi 12 azionisti in sostanza riescono a controllare la Banca con il solo 16% del capitale sociale. I componenti di questo “nocciolo duro” sono riusciti con una quota minima ad ottenere il dominio della banca in quanto risultano del tutto assenti dal Consiglio di Amministrazione i rappresentanti degli azionisti non facenti parte del nocciolo così pure il rappresentanti dei dipendenti.
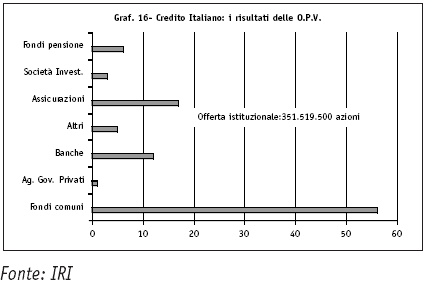
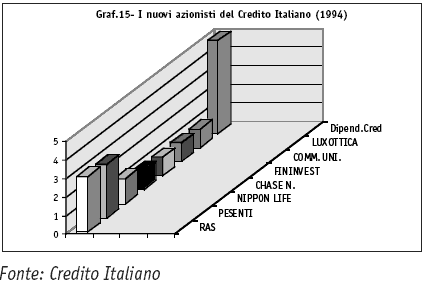
Si vedano i Graff. 15 e 16 per visualizzare la composizione dei nuovi azionisti e i risultati delle O.P.V.
BANCA COMMERCIALE ITALIANA
La Banca Commerciale Italiana (COMIT) agisce, in Italia e all’estero, in svariati settori di attività bancarie e finanziarie che comprendono l’erogazione di prestiti, l’intermediazione in valori mobiliari, la raccolta di depositi, i servizi di incasso e pagamento, le assicurazioni sulla vita e la previdenza, i fondi comuni di investimento e la gestione patrimoniale; è quotata in Borsa e dal 1989 anche al SEAQ di Londra.
Anche la COMIT, al pari del Credito Italiano, era stata rilevata dall’IRI negli anni ‘30 per evitarne il fallimento; nel 1937 è diventata Banca di interesse nazionale (nel 1993 questa definizione è stata eliminata in quanto il recepimento della seconda direttiva CEE ha stabilito che tutte le banche vengono denominate indistintamente enti creditizi). [8]
Nel 1992 vengono istituite tre sub-holding: la COMIT Holding Italia S.p.A. che possiede le maggiori partecipazioni finanziarie e bancarie italiane della capogruppo; la COMIT Holding International S.A. Lussemburgo alla quale fanno capo le maggiori società finanziarie e bancarie estere; la COMIT Holding S.p.A. che gestisce le partecipazioni nel settore parabancario e dei servizi finanziari.
Di seguito si riporta la struttura del Gruppo COMIT prima della privatizzazione (Cfr. Graf.17)
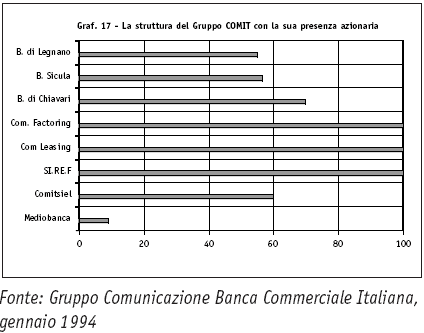 L’intera
quota detenuta dall’IRI (il 57,4%) è stata ceduta nel Febbraio 1994. Il meccanismo
è stato simile a quello del Credito Italiano : il 40% delle azioni ordinarie
destinate ai piccoli risparmiatori, l’8% ai dipendenti ed un’altra quota destinata
agli investitori stranieri ed istituzionali (non più del 2%).
L’intera
quota detenuta dall’IRI (il 57,4%) è stata ceduta nel Febbraio 1994. Il meccanismo
è stato simile a quello del Credito Italiano : il 40% delle azioni ordinarie
destinate ai piccoli risparmiatori, l’8% ai dipendenti ed un’altra quota destinata
agli investitori stranieri ed istituzionali (non più del 2%).
L’operazione aveva l’obiettivo di favorire la massima diffusione dei titoli attraverso l’Offerta Pubblica di Vendita in Italia, creando altresì una vasta area di azionariato diffuso tra i piccoli risparmiatori e i dipendenti e di collocare i titoli presso investitori istituzionali italiani e stranieri per permettere l’attuazione di investimenti di lungo periodo.
Anche la COMIT ha predisposto degli incentivi per i “possibili nuovi azionisti”; si è stabilito infatti che chi acquistava in OPV avesse diritto ad una azione gratuita ogni dieci ( con un massimo di 500 per sottoscrittore per chi non le rivende entro tre anni). Le azioni ordinarie acquistate consentivano ai sottoscrittori il diritto di partecipare alle assemblee e di avere informazioni sull’andamento della Banca.
Va evidenziato che la COMIT possedeva caratteristiche di solidità patrimoniale e di alta redditività, abbinate ad un indiscusso prestigio internazionale; nel 1992 era collocata ai vertici nelle classifiche mondiali, un patrimonio netto di circa 6.000 miliardi di lire e con attività pari a circa 130 miliardi di lire. Il Graf.18 mostra le percentuali di possesso dei nuovi azionisti della Banca Commerciale Italiana; è agevole rilevare che tra i nuovi soci rivestono un ruolo fondamentale le Assicurazioni (Generali 3% e Ras 1%), così come rilevante è la presenza del gruppo Benetton (2%) e del Gruppo Gestione Fondi Fininvest (0,50%); i dipendenti COMIT possiedono il 4% delle azioni.
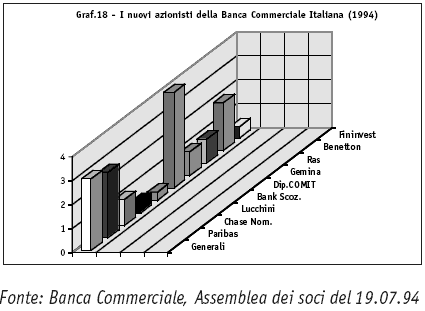
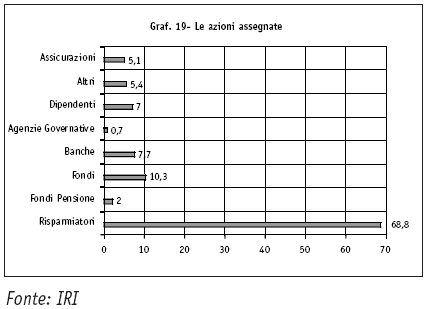
Il Graf.19 visualizza immediatamente in che modo sono state suddivise le azioni assegnate. Va ricordato che l’offerta globale è stata di 570.680.000 di azioni ordinarie.
Fonte: IRI
IMI
L’operazione di privatizzazione dell’Istituto Mobiliare Italiano è stata senza5 dubbio la meno conosciuta al pubblico. Bisogna sottolineare che l’IMI è una banca senza sportelli che si interessa soprattutto ai finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese; è la Banca Fideuram (sua società controllata) a rappresentare il gruppo nel settore dei prodotti finanziari delle famiglie.
L’IMI è nato come ente di Diritto Pubblico nel 1938 per consentire un potenziamento dell’economia italiana attraverso operazioni finanziarie e creditizie. L’importanza di questo istituto si è accentuata negli anni successivi alla seconda guerra mondiale nel momento in cui sono divenuti necessari dei finanziamenti all’economia attraverso disponibilità monetarie provenienti dall’European Recovery Program statunitense. In seguito l’IMI ha operato soprattutto nel settore dei finanziamenti a grandi progetti industriali, nel sostegno alle piccole e medie imprese e nel finanziamento a progetti riguardanti il Mezzogiorno; i fondi sono stati reperiti soprattutto attraverso l’emissione di obbligazioni e di certificati di deposito. Nel 1948 inoltre, con la IMICAPITAL e l’IMIREND, è stato avviata anche l’attività nel settore dei fondi comuni di investimento.
Nel 1991 si è avuta la trasformazione dell’Istituto in società per azioni (con la legge 218/90 del D.L. 20 -11 - 1990, n.356); mentre dal 1992 l’IMI è iscritto nell’albo dei gruppi bancari.
I tre settori principali di attività del gruppo IMI restano comunque :l’attività creditizia, l’investment banking e vari servizi bancari, assicurativi di minore entità. Per quanto attiene all’attività creditizia va ricordato che l’IMI possiede una quota pari al 20% del settore e circa il 4% del totale del sistema creditizio italiano; circa il 61% dell’utile lordo consolidato del gruppo nei primi nove mesi del 1993 è stato costituito dai ricavi dell’attività creditizia.
Per quanto concerne invece il settore dell’Investment Banking, l’IMI è attiva nei settori di Intermediazione Titoli e Finanza Aziendale Capital Markets; questa attività è svolta direttamente o attraverso società controllate che agiscono non solo in Italia ma anche sulle maggiori piazze finanziarie del mondo (New York, Londra, Francoforte, Parigi,ecc.). Il settore dei Servizi finanziari alle famiglie è imperniato sull’attività svolta dalla Banca Fideuram che offre servizi finanziari, bancari e assicurativi.
-----
Fino al 1994 il 50% del capitale della società era posseduto
direttamente dal Ministero del Tesoro, mentre il 9,27 era posseduto indirettamente
attraverso la partecipazione della CONSAP (Società posseduta Integralmente);
inoltre il 3,22% del capitale era degli enti INAIL e INPS.(Cfr. Graf.20)
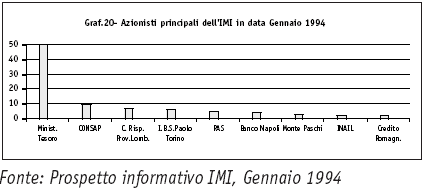
Il Consiglio dei Ministri nel Giugno 1993 ha stabilito la vendita dell’intera quota di partecipazione del Ministero del Tesoro e la quota detenuta dalla CONSAP S.p.A., attraverso un’offerta pubblica di vendita alla quale hanno partecipato la Banca Popolare di Novara, il Credito Varesino, l’INAIL, la Consap S.p.A, l’INPS, la RAS, il Banco di Napoli. Solo una quota di capitale compresa tra il 10 e il 20% è stata collocata sul mercato attraverso un’offerta pubblica (questo per realizzare all’interno dell’IMI un nucleo di azionisti di controllo).
Considerato che dal punto di vista finanziario questo istituto
può essere considerato uno dei “gioielli“ [9] (Cfr. Tab.13 ) dello
Stato, non si è avuta alcuna difficoltà nel collocamento delle azioni.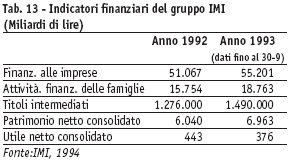
L’offerta pubblica, iniziata il 31 Gennaio 1994 e terminata anticipatamente il 1 febbraio dello stesso anno, è stata distinta in quattro tranches con riguardo al tipo di investitori: piccoli, istituzionali, dipendenti, del mercato USA. Il ricavo della vendita è stato destinato interamente alla riduzione il debito pubblico dello Stato.
E’ interessante comunque mostrare come sia cambiato dopo la
privatizzazione l’assetto proprietario del gruppo( cfr. Graf.21):
il Ministero del Tesoro possiede ora il 25,6% (invece del 50%), la RAS il 3,66
(aveva il 4,62), la CONSAP possiede il 4,76 (aveva il 9,26), il Banco di Napoli
il 2,08 (prima possedeva il 4,06),, l’INAIL ha l’1,75%(prima aveva il 2,17%),
l’INPS lo 0,53 (1,04) la banca Popolare di Bergamo lo 0,16 (0,32) e la Banca
Popolare di Novara lo 0,51% (1%). 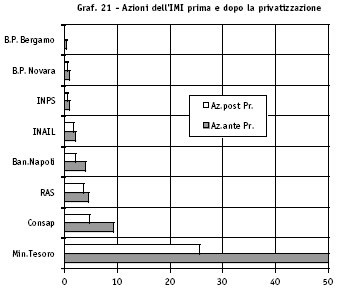
Come si rileva dal Graf.22, prima dell’offerta è molto elevata la percentuale
di possesso del Ministero del Tesoro (50%) ed è importante osservare che i primi
14 azionisti erano costituiti principalmente da banche e assicurazioni.
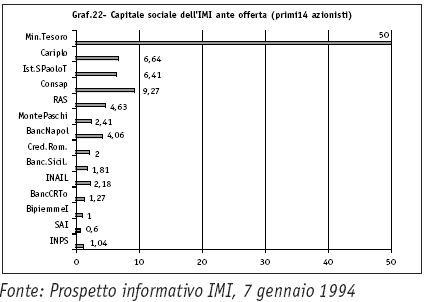
Il Graf.23 mostra, invece, come sia cambiata la ripartizione del capitale sociale dell’IMI dopo l’offerta; il possesso azionario del Tesoro è sceso dal 50% al 22,55%. Vi è una riduzione di azioni anche per l’INPS, l’INAIL, il Banco di Napoli, la RAS e la Consap.
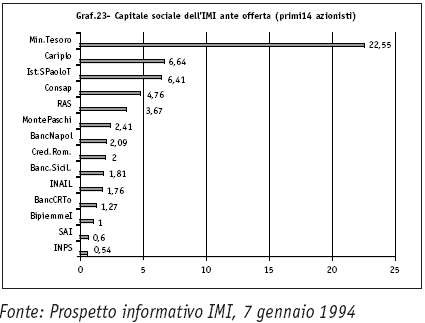
E’ interessante notare nell’ambito dell’offerta istituzionale
delle azioni IMI, quanto sia stato rilevante il ruolo svolto dalle varie Istituzioni
specializzate nella gestione del risparmio. Nel Graf.24 è evidenziato,
infatti, che oltre il 70% delle azioni riservate agli investitori istituzionali
sia andato ai Fondi Comuni, ai Fondi Pensione e agli Asset Manager. Anche le
Assicurazioni si sono accaparrate una percentuale elevata di azioni (l’11%),
ed ancora le banche che si sono assicurate il 7% del collocamento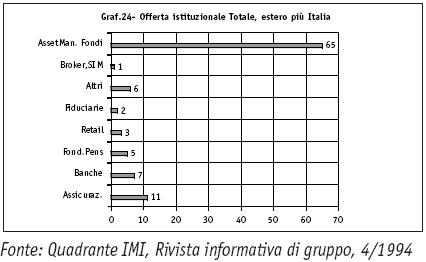 .
.
Le adesioni dei dipendenti all’acquisto delle azioni sono state abbastanza elevate. Se si considera la società capogruppo si evidenzia una significativa adesione all’intera operazione di vendita (Cfr. Graf.25). L’acquisto è avvenuto sia con mezzi propri dei dipendenti (circa il 28,4%), sia attraverso l’utilizzo di anticipi sul Trattamento di Fine Rapporto (46,3%), sia attraverso sovvenzioni dell’istituto concesse ad un tasso del 4% (la cui durata era di 18-60 mesi).
Le altre tranches di vendita delle azioni IMI sono state avviate e concluse nel Luglio 1995. Il Tesoro ha venduto una quota pari al 19,3% delle azioni possedute con una entrata pari a circa 1.200 miliardi di lire.
La Tab.14 e il Graf. 26 mostrano come sia cambiato l’assetto proprietario di questo Istituto dopo la privatizzazione. Va rilevato che il Tesoro possiede ora solo l’8,1% del capitale (questa quota si riduce ancora ed arriva al 6,92% se si contano quelle azioni che devono essere tenute a disposizione di soci che avendo partecipato alle OPV ne avranno gratis una ogni tre se non le rivenderanno prima di tre anni).
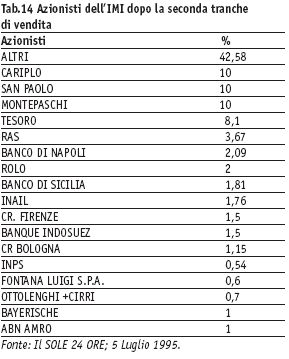
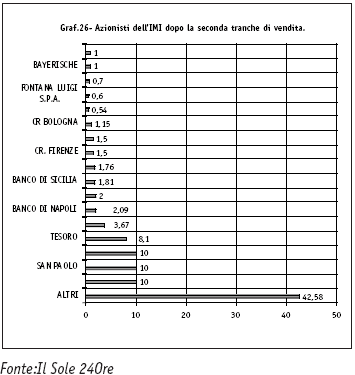
INA
Il gruppo INA, istituito come ente pubblico agli inizi del secolo ( 4 Aprile 1912), opera nei settori assicurativi-finanziari e creditizi sia in Italia che all’estero.
Fin dalla sua costituzione l’INA ha gestito le cessioni legali; il Fondo di garanzia per le vittime della strada ( che ha imposto l’assicurazione RC auto), il Consorzio Rischi Agricoli, il Conto Consortile (con riguardo alle assicurazioni RC auto), il fondo di garanzia per le vittime della caccia, il Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione.
-----
Nel corso degli anni l’INA ha ampliato il suo settore di attività anche al ramo vita attraverso la FATA, e nel ramo danni attraverso le società FATA e Assitalia; nell’ambito internazionale il gruppo INA agisce nel settore danni (attraverso la controllata ASTRA in Spagna e la COMAT in Francia); nel settore finanziario e creditizio invece opera attraverso le società controllate INA, SIM, e INA Banca.
In Italia il gruppo INA è al primo posto nel ramo assicurazioni sulla vita con una quota pari al 15,7%, mentre nel ramo assicurazioni danni ha una quota pari a circa l’8% del totale(Cfr.Graff.27 e 28).
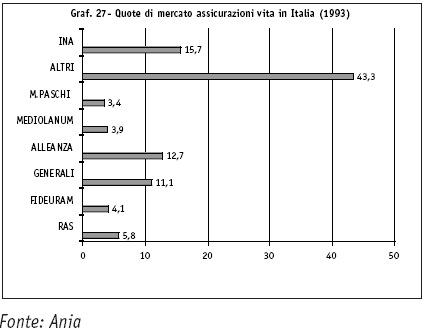
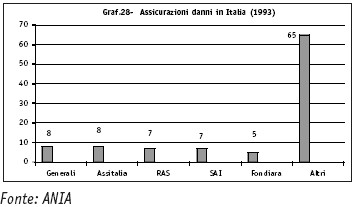
Il 7 Agosto 1992 il Consiglio di Amministrazione dell’INA ha convocato l’assemblea dei soci ed il Ministero del Tesoro quale azionista unico ha deliberato la trasformazione dell’ente in società per azioni. Il 30 Giugno 1993, inoltre, l’assemblea straordinaria dell’INA ha decretato la scissione dell’istituto in due società e precisamente in una società assicurativa che ha conservato il nome INA e che controlla un gruppo di imprese (Assitalia, Inasim, Fata, Inabanca) e in una società alla quale vengono assegnati per concessione i servizi assicurativi pubblici, la Consap; entrambe le società restavano di proprietà del Tesoro anche se solo l’INA è stata collocata sul mercato
L’operazione di privatizzazione, proposta dal Ministero del Tesoro che possedeva l’intero capitale sociale dell’istituto (100%), è stata effettuata con offerta pubblica di vendita attraverso la quale sono state cedute azioni ordinarie sul mercato nazionale ed internazionale ed è stata coordinata dall’Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. , dalla Banca Commerciale Italiana S.p.A., dal Credito Italiano S.p.A. e dall’Istituto San Paolo di Torino S.p.A.
Le azioni INA sono state cedute anche attraverso un collocamento privato rivolto ad investitori istituzionali italiani ed esteri, un’offerta pubblica riservata agli Stati Uniti d’America, a un collocamento privato riservato ai dipendenti ( ai quali viene effettuato uno sconto pari al 10% del prezzo delle azioni) e ad un collocamento privato riservato agli ex azionisti dell’Assitalia.
L’offerta globale di vendita è stata avviata il 27 giugno 1994; gli obiettivi seguiti dai vertici del gruppo sono stati quelli di cedere oltre il 50% delle azioni rimanendo però presenti in maniera significativa per consentire la costituzione di un assetto azionario stabile. Di seguito sono riportati i risultati del collocamento delle azioni. (Cfr. Graff.29 e 30).
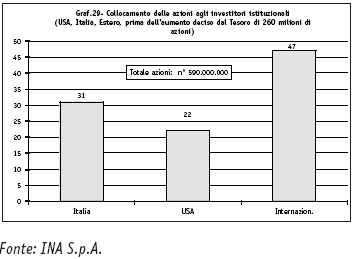
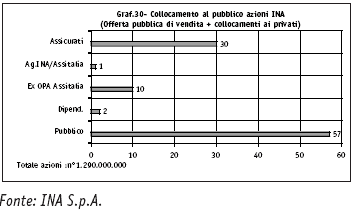
Il Ministero del Tesoro ha mantenuto la maggioranza relativa delle azioni dell’istituto, mentre tra i maggiori investitori esteri sono presenti la J. P. Morgan, la Legal and General, La Janus Capital Corp e la Schroeder Investments. L’offerta globale INA ha reso 4.152 miliardi di lire; agli investitori istituzionali italiani è andato il 9,6% dell’offerta, agli investitori istituzionali esteri il 21,8% mentre ai risparmiatori, ai dipendenti e agli ex azionisti dell’Assitalia è andato il 68,6% dell’offerta (Cfr. Graf.31 e Tab.15).
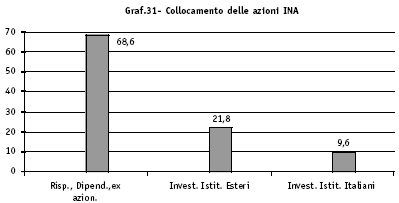
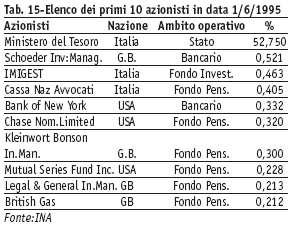
4. Rilanciare l’iniziativa politica ed economica contro la cultura
neoliberista della privatizzazione
dell’intero corpo sociale
Dall’universalismo dei diritti alla privatizzazione del welfare
Con l’inizio degli anni ’90 si accentuano nel nostro Paese scelte verso forme di capitalismo con connotati di vero e proprio darwinismo sociale.
Tale decisione che impone il definitivo passaggio dal capitalismo italiano, fondato su un modello di economia mista, a forme neoliberiste, da capitalismo selvaggio, basate su ipotesi economiche monetariste è dovuta ad una scelta europeista acritica del potere politico, economico e finanziario del nostro Paese che accetta, si sottomette ed anzi si fa promotore delle compatibilità monetariste dell’Europa de Maastricht, l’Europa voluta e imposta dai grandi capitali finanziari.
E’ in questa ottica che il processo di privatizzazione in Italia comincia a colpire pesantemente il welfare, puntando all’abbattimento dell’universalismo dei diritti e ipotizzando uno Stato Sociale rivolto soltanto, ed in modo inefficiente, alla copertura dei bisogni esclusivamente degli strati più poveri della popolazione.
La politica economica neo-liberista ha realizzato nel nostro Paese un quadro macroeconomico che evidenzia tendenze recessive, contrazione e precarizzazione dell’occupazione, diminuzione dei salari reali, diminuzione dell’inflazione dovuta soprattutto al forte calo della domanda, all’aumento delle fasce di povertà e dei tassi di disoccupazione. La risposta alle tragiche conseguenze della globalizzazione capitalistica non è indirizzata al mantenimento dei principi solidaristici e all’attuazione di serie politiche indirizzate a delle congrue prestazioni sociali ma alla creazione di un impianto incentrato su politiche di tagli del welfare che vanno a colpire sempre più gli strati più disagiati della popolazione.
Sono diversi i metodi con i quali è possibile attuare la cosiddetta “privatizzazione del welfare”; si pensi in primo luogo alla vendita di beni di proprietà pubblica (le imprese e le abitazioni di edilizia popolare); ed ancora la cessione ad organismi privati della fornitura dei servizi essenziali anche attraverso la possibilità di rimpiazzare il servizio pubblico con quello privato (ad esempio le pensioni sociali sostituite dalle forme assicurative private).
C’è inoltre l’irrigidimento dei criteri di ammissibilità ai servizi (vengono ristretti i margini di fruizione per costringere il cittadino a trovare diverse forme di sostegno).
In tal senso, ad esempio, al fine di introdurre sussidi alla disoccupazione, si è impostata una politica di risparmi in settori fondamentali quali la previdenza e la sanità, utilizzando come obiettivi prioritari la mobilità, la flessibilità del lavoro, le privatizzazioni e i tagli indiscriminati alla spesa sociale.
In questo modo si riducono i sussidi dei servizi sociali e sanitari attraverso un aumento dei ticket o comunque attraverso l’attuazione di normative che propongono una sanità sempre meno pubblica e più privata, con l’introduzione di forme di assicurazione sanitaria integrativa, con nuove regole di accesso al mercato della distribuzione dei farmaci o ancora con la gestione in via sperimentale di alcuni ospedali molto grandi e con la riduzione delle esenzioni.
Le principali misure previste nel settore della sanità ( al quale viene destinato circa il 5% in termini di PIL, un sesto della spesa sociale complessiva) sono chiaramente ispirate al criterio della privatizzazione; si propone sostanzialmente una sanità sempre meno pubblica e più privata, con l’introduzione di forme di assicurazione sanitaria integrativa, con nuove regole di accesso al mercato della distribuzione dei farmaci. Sono i parametri di efficienza e di efficacia competitiva del mercato, tipici indicatori della gestione d’impresa, che dovranno determinare le dinamiche evolutive dello Stato Sociale. E’ la cultura d’impresa, è la “moralità” del liberismo, è la logica del profitto e del mercato che deve essere caricata sulle già deboli spalle degli ammalati, degli anziani, dei disoccupati, dei sottoccupati, dei precari, di tutti gli strati emarginati della società.
Anche per quanto riguarda il sistema pensionistico la constatazione di una “forte prevalenza di anziani” nel nostro Paese porta alla personalizzazione e privatizzazione del sistema di protezione sociale arrivando ad optare per un passaggio al mercato della previdenza.
Non si tiene invece conto dell’elemento economicamente più importante e cioè che le politiche di welfare sono in difficoltà perché non ci sono più le condizioni, a causa delle scelte padronali che puntano al mantenimento del profitto attraverso la riduzione della quantità di lavoro e del suo costo, che avevano caratterizzato le fasi economicamente tendenti alla piena occupazione e all’incremento del monte salari dai cui contributi proveniva il finanziamento dello stato sociale. Oggi con la disoccupazione di massa voluta dalle politiche neo-liberiste legate ai processi di globalizzazione, e alla conseguente contrazione del monte salari ( che in Italia tra il 1980 e il 1995 è passato dal 48% del PIL al 41%), accompagnate da una evasione fiscale istituzionalizzata, si viene a creare una condizione complessiva macroeconomica in funzione della quale cade conseguentemente la modalità principale di finanziamento del welfare.
Si sviluppa in questo modo un sistema economico nel quale la spesa pubblica non è indirizzata ad un reale rafforzamento infrastrutturale del Paese e ad una efficiente produzione di servizi pubblici, anzi si realizza una società con maggiori differenziazioni sociali, in cui è sempre più ridotto il sistema di protezione sociale a favore delle fasce di cittadini più deboli, fasce che diventano sempre più grandi andando a comprendere anche quegli strati di società che fino a pochi anni fa erano considerate protette (lavoratori del pubblico impiego, artigiani e commercianti), creando quindi nuove povertà, nuovi bisogni, ampliando in sostanza l’area dell’emarginazione sociale complessiva.
Non si riesce a capire che i nuovi indirizzi di politica economica devono essere assolutamente finalizzati alla lotta alla disoccupazione strutturale creando nuove possibilità di lavoro ad utilità sociale e collettiva, realizzando produzioni non necessariamente mercantili, allargando le possibilità del lavoro femminile, del lavoro agli immigrati, del lavoro ai giovani; di mettere in atto una seria politica di riduzione generalizzata, sia in senso settoriale sia in senso terrioriale, dell’orario di lavoro a parità di salario, che riguardi anche fortemente il terziario pubblico e privato, le piccole e micro imprese.
La proposta del Reddito Sociale Minimo contro la cultura del Profit State
E’ ormai una necessità storica, politico-economica, oltre che una battaglia di civiltà riconoscere il Reddito Sociale Minimo per i disoccupati, i sottoccupati, i precari, i lavoratori atipici; Reddito Sociale Minimo che assume sia forme di natura diretta, cioè di un vero e proprio assegno mensile, sia forme di reddito indirette derivanti dalle tariffazioni sociali e dalla gratuità dei servizi fondamentali.
Un Reddito Sociale Minimo nell’ambito di una concezione che non deve rappresentare una sorta di “carità minima garantita”, voluta dai vari governi apparentemente progressisti presenti in Europa. Proposte tutte basate su una sorta di concezione di “minimo vitale di sopravvivenza”, che seppur finalizzate a sottrarre le fasce più deboli della società da una condizione di povertà, le renderebbe ricattabili e condizionate dal potere, innescando senza dubbio fattori disincentivanti e che ostacolano la ricomposizione di classe, favorendo invece la nascita di veri e propri assistiti sociali, disponibili alle politiche clientelari. Il problema non è assicurare un’assistenza caritatevole minima , ma piuttosto creare condizioni di sviluppo basate su un diverso modello della produzione, sempre riaffermando la centralità del lavoro come momento di valorizzazione economica complessiva e di organizzazione del dissendo sociale.
Il Reddito Sociale Minimo deve essere concepito in maniera tale che si opponga a quel “nuovo patto sociale” nel quale i ricchi e le imprese non partecipano alla spesa collettiva, la rendita e il profitto non devono essere intaccati, l’evasione fiscale deve essere legalizzata; gli industriali continuano a chiedere flessibilità del salario, delle condizioni di lavoro, della sicurezza del lavoro, degradando e precarizzando sempre più l’occupazione. Il Reddito Sociale Minimo non è una forma di assistenzialismo ma è una proposta direttamente connessa alla centralità del lavoro, lavoro che deve ripartire anche dalla funzione di uno Stato occupatore, che cioè crea condizioni strutturali e distribuisce occupazione, non delegando tutto al mercato, non privatizzando come se il profitto fosse il regolatore dell’interesse generale.
Il Reddito Sociale Minimo diventa così anche uno strumento di iniziativa politica che si contrappone alle forme al ribasso di uguaglianza che puntano a ripartire tra i poveri solo la miseria, contrapponendo i giovani agli anziani, gli occupati ai disoccupati, il diritto al lavoro ai diritti del lavoro, gli aumenti occupazionali a salari ridotti, alla flessibilità, alla grande precarietà, al continuo abbassamento della qualità del lavoro e della qualità della vita.
-----
Con la proposta del Reddito Sociale Minimo si può iniziare una seria lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale, aggiungendo una serie di altre iniziative a connotato di giustizia fiscale e distributiva, con forti contenuti e finalità di redistribuzione della ricchezza sociale prodotta dal lavoro.
Le risorse finanziarie ci sono e sono disponibili per il rafforzamento di un Welfare State non più e non solo della cittadinanza, ma di uno Stato Sociale che oltre a redistribuire reddito socializzi l’accumulazione del capitale, distribuisca cioè ricchezza derivante da incrementi di produttività che sono andati ad esclusivo vantaggio del capitale e non del lavoro; allora tali risorse finanziarie devono essere prelevate attraverso una seria e decisa tassazione dei capitali nelle sue diverse forme (tassazione dei capitali finanziari e speculativi, tassazione dell’innovazione tecnologica, tassazione del capital gain), lanciando in tal senso, inoltre, una campagna di iniziativa politico-economica internazionale e di civilità che realizzi la cosiddetta Tobin Tax, cioè la tassazione dei trasferimenti di valuta all’estero, tassazione da utilizzare esclusivamente a fini sociali, ambientali, occupazionali e per finanziare il Reddito Sociale Minimo per disoccupati, precari e non garantiti.
Tobin Tax e Reddito Sociale Minimo
James Tobin, premio nobel per l’economia nel 1981, è considerato un forte sostenitore del pensiero keynesiano. La tassa di cui parliamo prende il suo nome proprio perchè fu il primo economista ad evidenziare la diversificazione del rischio come motivo inerente la razionalità degli investitori. La Tobin Tax nella sua formulazione originaria prevede una regolamentazione dei cambi e una tassazione di tutte le transazioni di capitale finanziario a carattere speculativo, che però è possibile realizzare soltanto attraverso una mondializzazione delle intese fiscali per non sminuire la sua portata attraverso la fuga dei capitali verso i cosiddetti paradisi fiscali.
Come CESTES-PROTEO ci diciamo disponibili e abbiamo aderito all’organizzazione non governativa ATTAC (Azione per una Tobin Tax di aiuto ai cittadini) che si è costituita da pochi giorni per imporre ai governi e alle organizzazioni economiche internazionali l’applicazione appunto della Tobin Tax.
Nonostante l’idea iniziale di James Tobin fosse di venticinque anni fa, e che si sono detti nel tempo disponibili alla sua attuazione anche personaggi politici, economisti ed istituzioni che spesso hanno avuto seria responsabilità sull’imposizione a livello planetario della globalizzazione finanziaria neoliberista, noi pensiamo che la tassazione delle transazioni speculative (si pensi che quotidianamente circa 1.500 miliardi di dollari vengono trasferiti con tali modalità e circa il 90% di tali transazioni hanno durata che non supera i quattro, cinque giorni) se avvenisse anche con aliquote differenziate in funzione della durata dell’operazione, disincentivando fortemente gli investimenti di breve periodo, realizzerebbe diverse centinaia di miliardi di dollari l’anno che la comunità internazionale potrebbe gestire a fini sociali, sanitari, ambientali, di lotta alla povertà e di forte incremento occupazionale.
Dal nostro punto di vista però, i proventi derivanti dalla Tobin Tax dovranno essere utilizzati esclusivamente a fini socio-ambientali, per creare occupazione e da destinare al Reddito Sociale Minimo per disoccupati e precari. Inoltre la gestione di tali fondi derivanti dall’applicazione della Tobin Tax non può essere effettuata da quegli organismi internazionali (come il Fondo Monetario Internazionale) che sono invece proprio i veicolatori di quel modello neoliberista a forti connotati di economia finanziaria che, oltre a rendere sempre più marcato il divario Nord-Sud sta ulteriormente peggiorando le condizioni di vita delle stesse popolazioni ad industrialismo avanzato.
La Tobin Tax, insieme alle altre modalità di tassazione dei capitali (capital gain, innovazione tecnologica, ecc.), diventa così risorsa fondamentale per finanziare un progetto di Reddito Sociale Minimo, e non solo, che oltrepassando le frontiere italiane, rappresenti una proposta forte di politica economica che interessa non l’Europa di Maastricht ma un’Europa sociale e del lavoro, assumendo anche caratteristiche internazionali.
Tale battaglia può contribuire ad opporsi ai processi di finanziarizzazione dell’economia, agli accordi multilaterali sugli investimenti (tipo l’AMI) e a combattere le forme di privatizzazione del welfare (che ad esempio attraverso i fondi pensione e assistenziali contribuiscono alla speculazione finanziaria e all’abbattimento dello Stato Sociale); essa può inoltre essere indirizzata verso principi di giustizia fiscale e distributiva che possano colpire gli enormi profitti accumulati, gli enormi incrementi di produttività, sottraendoli all’ingordigia dell’accumulazione di capitale, per rilanciare investimenti produttivi capaci di creare occupazione.
Si tratta di lanciare un’offensiva di quel mondo culturale, politico, sindacale, dell’associazionismo di base, di tutte quelle forze che non accettano le compatibilità e l’omologazione dei principi politico-economici neoliberisti basati sulla cultura delle privatizzazioni del patrimonio pubblico,del welfare,del sociale,un’offensiva politica,sociale ed economica che sappia legare la riduzione gneralizzata dell’orario di lavoro, la creazione di nuova occupazione di produzioni non necessariamente a caratttere mercantile, la tassazione dei capitali per socializzare la ricchezza complessiva, il riconoscimento del Reddito Sociale Minimo per disoccupati e precari, il rafforzamento dello Stato Sociale della distribuzione dell’accumulazione, in un nuovo modello di sviluppo a forti connotati di eco-socio-compatibilità fuori-mercato.
-----
Riferimenti Bibliografici ESSENZIALI
Acocella N., La privatizzazione in Italia,Economia Pubblica, n.12, 1989.
Barca F., Imprese in cerca di padrone,Laterza, Bari, 1994.
Bernini A.M., Intervento statale e privatizzazioni, Padova,CEDAM,1996.
Berti L., Le privatizzazioni in Italia, in R. Marchionatti e L. Pennacchi (a cura di), Discrezionalità e Regole, Franco Angeli, 1991.
Cassese S., Privatizzare all’italiana, Politica ed Economia, n.4,1988.
Cavazzuti F., La trasformazione in SPA di un ente pubblico economico, Il Mulino, 1992.
Costamagna C., Privatizzazioni: l’obiettivo è la public company, Il Mulino 345, Bologna Anno XLII, gennaio-febbraio 1993.
Di Majo A., Le politiche di privatizzazione in Italia, Il Mulino, 1989.
Dossena G., Le privatizzazioni delle imprese. Modalità, problemi e prospettive, EGEA, Milano, 1990.
Martufi R. e Vasapollo L., Sviluppo capitalistico e modelli d’impresa, in Altra Europa, anno 3, n.8, Luglio-Settembre 1997.
Niada M., Quale golden share per il caso italiano,Mondo Economico, n.29,1993.
Padoa-Schioppa T.,Il processo di privatizzazione:sei esperienze a confronto, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, genn.-febbr. 1992.
Roncaglia A., Lineamenti di Economia Politica, Laterza, Bari, 1992.
Santagata W., Offerta privata di beni pubblici, Il Mulino, 1991.
Silva F., I nodi da sciogliere nel processo di privatizzazione, Economia e Politica Industriale, n.78, 1993.
Vasapollo L. , Il sistema finanziario. Mercati e Prodotti, Ed. Lavoro, Roma, 1993.
[1] “... La natura privata o pubblica della proprietà si definisce in base al soggetto che ha il diritto di disporre dell’impresa in tutti i modi che non siano esclusi dai contratti e dalle norme vigenti. Le due forme private dell’impresa, privata e pubblica, sono dunque, rispettivamente: quella di un’azienda gestita direttamente da uno o più proprietari privati o da managers su delega dei proprietari privati; quella di un’azienda gestita da funzionari pubblici che rispondono a organi dell’Amministrazione statale..... Alcuni intendono come privatizzazione ogni iniziativa volta a ridurre la presenza pubblica nella proprietà o nella gestione dell’impresa. In questa accezione del termine rientrano allora la cessione a privati di quote di minoranza...la deregolamentazione di aspetti di attività dell’impresa; l’abbandono di attività accessorie prima integrate nella gestione in favore dell’acquisto sul mercato di quei beni o servizi....”; in Padoa-Schioppa T.,”Il processo di privatizzazione:sei esperienze a confronto”, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, genn.-febbr. 1992, p. 3.
[2] Tali considerazioni sul modello di capitalismo italiano, come alcune altre successive, sono tratte da : R. Martufi e L.Vasapollo, “Sviluppo capitalistico e modelli d’impresa”, in “Altra Europa”, anno 3, n.8, Luglio-Settembre 1997.
[3] Va ricordato che nel 1977 l’EGAM è stato sciolto come pure l’EAGG e l’EAGAT (sciolti agli inizi degli anni ‘80); l’EFIM è stato liquidato recentemente mentre l’IRI e l’ENI nel 1992 sono state trasformate in società per azioni.
[4] Cfr.R.Martufi e L. Vasapollo, “Sviluppo capitalistico...”, op. cit.
[5] Cfr.R.Martufi e L. Vasapollo, “Sviluppo capitalistico...”, op. cit.
[6] Cfr.R. Martufi e L. Vasapollo, “Sviluppo capitalistico...”, l’Altra Europa, op. cit.
[7] L’IRI, che nel 1933 ha assunto il controllo effettivo della Banca, ha stabilito nel 1936 che questo istituto poteva operare come istituto a breve termine (sino a 18 mesi) o istituto di credito ordinario, con la possibilità di concedere crediti a medio termine entro limiti prefissati; sempre nel 1936 il Credito Italiano, insieme alla Banca Commerciale Italiana e al Banco di Roma, è stato classificato come banca di interesse nazionale (definizione ora abolita).
[8] Va ricordato inoltre che dopo la seconda guerra mondiale questa banca insieme al Credito Italiano e al Banco di Roma hanno fondato la Mediobanca ed hanno acquisito il Credito Fondiario ed industriale FONSAP S.p.A.10 L’IMI registra oltre 60 anni di bilanci positivi; nel 1992 l’esercizio si è chiuso con un attivo di 443 miliardi di lire, il 30 settembre 1993 risultavano 376 miliardi di utili con una previsione per l’esercizio di oltre 500 miliardi di lire.
[9] L’IMI registra oltre 60 anni di bilanci positivi; nel 1992 l’esercizio si è chiuso con un attivo di 443 miliardi di lire, il 30 settembre 1993 risultavano 376 miliardi di utili con una previsione per l’esercizio di oltre 500 miliardi di lire.