Per comprendere fino in fondo l’attuale fase della competizione globale è determinante connetterla con l’analisi dell’organizzazione del ciclo produttivo, delle caratteristiche del tessuto produttivo e sociale, del ruolo dello Stato, dei rapporti tra le aree internazionali e della loro struttura economica, degli interessi complessivi di dominio ed espansione che determinano il conflitto interimperialistico. Tutte problematiche fortemente connesse, spesso anzi dipendenti dall’epocale passaggio dall’era fordista a quella cosiddetta postfordista [1].
Ripercorrendo molto schematicamente l’ultimo trentennio con le connesse fasi politico-economiche risulta che già a partire dall’inizio degli anni ’70 comincia a venir meno quel connubio fra sistema produttivo fordista e modelli keynesiani attraverso i quali lo Stato realizzava un contesto complessivo di mediazione, regolazione e compressione del conflitto sociale.
Si parla a tal proposito di messa in discussione della rigidità dei processi di accumulazione proprio perché la crisi fordista è identificata dalla rigidità degli investimenti e dell’innovazione tecnologica, da una rigidità dei mercati di incetta e dei mercati di consumo. A ciò si aggiunge la rigidità del mercato del lavoro, grazie anche alla forza espressa dal movimento operaio tra la seconda metà degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70.
Tali “rigidità del sistema produttivo facevano sì che non fosse più possibile il sostenimento della domanda attraverso la spesa pubblica a causa di un restringimento della base fiscale. L’unica risposta fu allora quella della politica monetaria caratterizzata da linee inflattive.
Si interrompevano, così, i processi di crescita del dopoguerra in un contesto di sviluppo economico che vedeva nuovi processi di concorrenza internazionale e il venir meno del ruolo dello Stato keynesiano. L’intenso processo di industrializzazione fordista si sposta allora, verso nuovi mercati, specialmente del Sud-Est asiatico, aumentando la competizione internazionale e mettendo in discussione la leadership statunitense.
Nel 1973 l’innalzamento dei prezzi del petrolio, il primo shock petrolifero e le politiche di controllo dell’inflazione evidenziano difficoltà finanziarie e un’eccedenza di capacità produttiva nei paesi a capitalismo avanzato; tutto ciò metteva fortemente in crisi i processi di accumulazione capitalistica dell’era fordista.
Si delineano di conseguenza strategie di sopravvivenza aziendale e capitalistica in una situazione di forte deflazione (1973-75); l’uscita dalla stagflazione identifica processi che mettono fortemente in discussione il compromesso fordista-keynesiano. Da allora iniziano le innovazioni nell’organizzazione industriale, l’intensificazione dell’innovazione tecnologica e dei modelli di automazione, i processi di delocalizzazione produttiva, i grandi piani di acquisizioni e fusioni, la nuova progettualità complessiva per l’accelerazione dei tempi di rotazione del capitale. Insomma forti innovazioni di processo e di prodotto che si accompagnano ad un diverso sistema statuale-istituzionale di mediazione politico-sociale che ha come obiettivo il controllo estremo della conflittualità dei lavoratori e dell’antagonismo sociale in genere.
Tali processi hanno bisogno di un diverso modo di realizzare il ciclo produttivo, di un diverso modo di rapportarsi alla forza-lavoro, di un diverso modo di interpretare le dinamiche spaziali della produzione. E tutto ciò è possibile attraverso un ruolo diverso dello Stato nel veicolare complessivamente una nuova specifica ideologia per l’attuale ciclo dell’accumulazione flessibile. È così che le rigidità dell’ultima fase fordista debbono trasformarsi in flessibilità dei processi produttivi, flessibilità dei mercati del lavoro, flessibilità della domanda. Tutto ciò in funzione tale che le minacce da parte dei movimenti dei lavoratori all’ordine sociale capitalista, e i periodi di crisi dovuti a processi di sovraccumulazione, potessero essere assorbiti, o perlomeno contenuti e gestiti.
Negli anni ‘80 si è verificato un sostanziale cambiamento nella durata dei cicli economici, cioè dal momento dell’inizio della fase di recessione all’altra. Si rileva infatti che, mentre nel periodo seguito alla seconda guerra mondiale il ciclo economico si caratterizzava per una durata di circa cinque anni, dal 1980 in poi la distanza tra due periodi di recessione si è allungata a oltre 10 anni, anche se la ripresa economica nel senso di vera e propria espansione ha poi stentato a realizzarsi. Al contempo si è cercato così di “snellire” le imprese pubbliche e private per attuare una “produzione snella”.
In tale scenario si sviluppa il quadro macroeconomico mondiale degli anni ‘90, (in particolare la seconda metà), contemporaneamente caratterizzato da tassi di crescita molto deboli del PIL, compresi i paesi come il Giappone che hanno svolto una funzione trainante nei confronti del resto dell’economia mondiale. Una deflazione crescente; una congiuntura mondiale estremamente instabile, inframmezzata da sussulti monetari e finanziari; aumento di investimenti, in particolare di carattere finanziario, che si è accompagnato alla crescita della disoccupazione di massa e alla sua natura tecnologica e strutturale. Il tutto coniugato al contenimento dei salari reali, da alta flessibilità e precarizzazione del lavoro e da condizioni del lavoro medievali in molti paesi in cui la manodopera viene sfruttata all’estremo.
Si determina così l’accentuarsi delle disuguaglianze di reddito e di condizioni di vita all’interno anche dei paesi a capitalismo maturo. A ciò continua ad accompagnarsi la marginalizzazione di intere regioni del globo dal sistema di scambi e una concorrenza internazionale sempre più intensa. Nel caso dei paesi OCSE, circa i tre quarti delle operazioni di investimento all’estero hanno preso la forma di operazioni di acquisizione e di fusione di imprese esistenti, ovvero di cambiamento di proprietà del capitale esistente, spesso seguiti da ristrutturazione di processo e di prodotto, che hanno determinato disoccupazione senza creazione di mezzi di produzione nuovi; e laddove ci sono stati investimenti produttivi questi non hanno necessariamente diminuito la disoccupazione, anzi il contrario. In molti mercati, i tassi di concentrazione mondiale sono dunque analoghi a quelli di trent’anni fa, tipici delle economie chiuse.
Ma è proprio in questo quadro che si inserisce la linea portante della cosiddetta fase dell’accumulazione flessibile, cioè la completa riorganizzazione e deregolamentazione soprattutto del sistema finanziario mondiale con innovazioni di strumenti, di mercati, di intermediari e con una differenziazione e un decentramento territoriale dei flussi finanziari. Tutto ciò ha evidenziato la necessità della strutturazione di un unico mercato mondiale finanziario e creditizio, anche se telematico e virtuale, facendo emergere i grandi conglomerati finanziari con un ruolo centrale degli investitori istituzionali. Il contenuto effettivo della cosiddetta globalizzazione è dato, pertanto, non dalla mondializzazione degli scambi, ma da quella delle operazioni del capitale, tanto sotto la forma industriale che finanziaria.
È quindi evidente che il contesto complessivo della cosiddetta globalizzazione si è sempre più legato alla dinamica specifica della sfera finanziaria, la cui crescita a ritmi qualitativamente superiori a quelli degli investimenti produttivi, del PIL o degli scambi, sono stati il fattore che ha maggiormente sconvolto la situazione economica, a partire in particolare dagli anni ‘80. A risentirne sono stati i paesi in particolare delle aree a basso e medio livello di sviluppo, soprattutto dell’Europa dell’Est e dell’Asia centrale, zone ricche di risorse petrolifere e di gas. Intere aree che ormai devono affrontare questi problemi sotto il ricatto di una guerra economica, e non solo, fra USA e UE.
Sono comunque questi due ultimi blocchi economici che impongono gravi costrizioni dovute al peso schiacciante del debito contratto dai paesi dipendenti. È proprio agli USA e ai paesi UE che (vedi da ultima la situazione in Argentina) si devono pagare in interessi più di quello che si è ricevuto in prestiti, donazioni, investimenti. E il pagamento di un debito così cospicuo costringe i paesi del Terzo Mondo a saccheggiare le foreste, svendere le materie prime, supersfruttare e distruggere il patrimonio ambientale; in genere a sottostare ad accordi neoliberisti e a privatizzazioni, a standard sociali minimi, tali da attirare gli investitori stranieri.
La mancata ripresa dell’economia soprattutto dagli anni ’90 in poi, è anche dovuta alla contrazione della domanda dovuta sempre più anche all’estrema disuguaglianza economica e sociale, allargando la forbice di condizioni tra ricchi e poveri. Si tratta di una ulteriore prova del fallimento del mercato che, lasciato libero a se stesso, accentua sempre più le distanze esistenti tra le classi sociali.
È in tale quadro storico politico-economico che vanno interpretate le caratteristiche principali del postfordismo incentrato sul paradigma dell’accumulazione flessibile. Caratteristiche che comunque si possono schematizzare con: una specializzazione flessibile, la volatilità dei mercati, la riduzione sostanziale della funzione di regolazione economica dello Stato-nazione e l’individualizzazione dei rapporti di lavoro.
Parlare attualmente di era postfordista non significa che non sussistano ancora elementi tipici dei processi fordisti, anzi. Il cosiddetto modello postfordista tipico dell’area centrale dei paesi a capitalismo avanzato convive con un tipico modello ancora fordista della periferia e addirittura con modelli schiavistici dei paesi dell’estrema periferia (dove per estrema periferia si intendono anche alcune aree marginali del centro nei paesi a capitalismo avanzato). Tutto ciò perché oggi convivono le diverse facce di uno stesso modo di produzione capitalistico, anche se lo si vuole identificare come l’era della “New e Net Economy” e del paradigma dell’accumulazione flessibile. È comunque una fase in cui si determina sempre più una crescita distruttiva senza alcuna forma di sviluppo sociale e di civiltà.
Il processo che ha caratterizzato lo sviluppo industriale degli ultimi 25 anni nei paesi a capitalismo maturo è stato, infatti, contraddistinto quasi sempre e, anche se in modo diversificato, ovunque da un forte aumento della produttività del lavoro, a cui è corrisposto un risparmio di lavoro che eccede decisamente la creazione di nuove opportunità occupazionali. In effetti gli incrementi massicci di produttività, dovuta ad intensi processi di innovazione tecnologica e ad una conseguente ridefinizione del mercato del lavoro, hanno fatto sì che tali incrementi si traducessero esclusivamente in aumenti vertiginosi dei profitti e delle varie forme di remunerazione del fattore produttivo capitale. Il fattore lavoro non ha avuto alcun tipo di beneficio in termini di redistribuzione reale di tali incrementi di produttività. Infatti, non si è realizzato incremento occupazionale, né corrispondenti incrementi nell’andamento dei salari reali, né tanto meno relativi andamenti decrescenti nell’orario di lavoro ed, infine, neppure il mantenimento dei precedenti livelli di salario indiretto quantificabili attraverso la spesa sociale complessiva.
La fase della nuova globalizzazione ha significato, quindi, dominio delle Borse e della finanziarizzazione dell’economia, in conflitto con qualsiasi forma di miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni, ostacolando la libertà di scelta e allargamento dei diritti universali. Questo concretamente è il concetto di modernità del capitalismo selvaggio anche se si tenta di plasmarlo su toni più moderati ed equilibrati con irreali ipotesi di mercato sociale.
Il principio che guida questa fase è basato sul fatto che è la domanda a fissare la produzione in relazione a modelli di efficienza produttiva e sfrenata concorrenza, anche se spesso imperfetta. Ne segue che la concorrenza si basa sempre più sulla qualità del prodotto, la qualità del lavoro, con un nuovo ruolo assegnato al cosiddetto capitale umano, al capitale intellettuale, in un modello sempre più caratterizzato da risorse immateriali del capitale intangibile, dal capitale informazione messo direttamente a produzione.
Una strutturazione del capitale che si accompagna al lavoro manuale sottopagato, delocalizzato e sempre più spesso non regolamentato, a flessibilità imposta e precarizzazione del lavoro e dell’intero vivere sociale, a servizi esternalizzati e a scarso contenuto di garanzie che ne permettono l’uso, e non più sulle connessioni fra quantità prodotta e prezzo (elementi tipici del fordismo).
Tutto ciò perché oggi convivono le diverse facce di uno stesso modo di produzione capitalistico basato sull’estorsione di plusvalore e pluslavoro. Si sviluppano e si rafforzano così, forti processi consociativi e di compressione del conflitto funzionali alla società del sistema di flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro, di terziarizzazione e di finanziarizzazione, della privatizzazione delle imprese pubbliche, dei servizi demolendo il welfare, delle delocalizzazioni ed esternalizzazioni produttive e di accorciamento delle entità spazio-temporali nel mondo capitalistico. Andando così ad incidere sul contesto sociale che viene sempre di più messo direttamente a produzione, aziendalizzato. È l’insieme di tutto ciò che contraddistingue in pratica la forte ripresa di posizioni, quindi di potere, del capitale rispetto al lavoro.
La generalizzazione e globalizzazione del capitalismo selvaggio, tipico del modello americano-anglosassone, continuano a far ritenere gli USA riferimento centrale di uno sviluppo mondiale a guida unipolare, in particolare dagli ultimi anni ‘80, con la fine dell’URSS. La nuova fase di globalizzazione coincide proprio con una nuova era a guida unipolare del mondo, in particolare dagli ultimi anni ‘80 a metà degli anni ‘90.
2. L’apparente configurazione del capitale mondializzato nello scontro tra blocchi economici
La liberalizzazione degli scambi, insieme alla deregolamentazione e allo smantellamento della legislazione a tutela dei salari, ha permesso ai gruppi delle multinazionali, in particolare americane, di sfruttare simultaneamente i vantaggi della libera circolazione delle merci e delle forti disparità tra i paesi, le regioni o i luoghi situati anche all’interno delle stesse grandi aree economiche occidentali. La politica economica determina sempre più scelte monetariste e neoliberiste, lasciando intatte le cause profonde che originano gli squilibri della struttura produttiva, approfondendo il deficit commerciale. Seguendo le indicazioni della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, numerosi governi dei paesi dipendenti (vedi da ultimi Messico, Brasile, Indonesia, Malesia, Russia, Argentina, ecc.) continuano ad applicare politiche non di semplice congiuntura ma sempre più invece di carattere strutturale e di apertura commerciale dipendente accelerata, con privatizzazione delle imprese statali e la deregulation economica. Si realizzano così politiche economiche che hanno come prime ripercussioni l’abbassamento dei salari reali, le privatizzazioni di imprese e delle diverse forme di Welfare State, l’aumento della disoccupazione, la deindustrializzazione senza investimenti reali e produttivi finanziati da capitale interno e, quindi, l’ampliamento della dipendenza dai due grandi blocchi economici occidentali USA e UE. La configurazione e le modalità d’uso, a finalità di controllo sociale complessivo, del capitale privato mondializzato non ha smesso di modificarsi e oggi si indirizza sempre più a favore di istituzioni finanziarie non bancarie legate alle multinazionali, in un perverso legame fra capitale finanziario e capitale produttivo (che si configura sempre più nelle dinamiche degli investimenti diretti esteri).
Si realizza, così, una mondializzazione finanziaria e produttiva a quasi esclusivo dominio USA e UE, in cui gli squilibri economico-produttivi si acuiscono progressivamente. Si realizza, allo stesso modo, un processo profondo di modificazione e di distribuzione del reddito in favore dei redditi finanziari e comunque del capitale (profitti industriali che vanno a rendita per poi tornare a profitti), strozzando definitivamente non solo i paesi del Terzo Mondo ma soprattutto quelli a medio livello di sviluppo. Nell’ambito dei processi di ridefinizione delle aree di influenza dei poli geoeconomici, il controllo delle risorse materiali (petrolio, gas, metano, minerali preziosi, ecc.) e del capitale umano (lavoratori specializzati a basso costo e con minimi livelli di diritti) delle regioni a medio livello di sviluppo diventa, pertanto, motivo forte e strategico di contesa nella competizione globale. La dinamica geografica dei flussi degli investimenti diretti esteri (IDE) ha, infatti, rappresentato negli anni ‘90 lo strumento principale del paradigma della stabilità “politico-economica globale”, rimettendo in parte al centro dell’iniziativa capitalistica l’investimento produttivo che non può rimanere del tutto subordinato alle dinamiche della finanziarizzazione. Infatti, la sfera finanziaria si alimenta proprio della ricchezza creata dagli investimenti produttivi nei paesi a medio livello di sviluppo, tra i quali centrali sono quelli dell’Eurasia. Investimenti in quest’area significano profitti per le multinazionali, accaparramento di risorse primarie e di capitale umano a basso prezzo e a buona specializzazione, controllo del petrolio, delle materie prime e delle fonti di energia, determinazione della valuta di quotazione dei barili di petrolio e, quindi, determinazione della valuta che giocherà in futuro il ruolo di riserva internazionale. Significa, cioè, profitti e capitali immediatamente disponibili per gli operatori finanziari, istituzionali e non, per le speculazioni internazionali e capitali industriali produttivi pronti a processi sfrenati di sfruttamento. Si tratta delle due facce del capitale internazionale che ha comunque carattere destabilizzante per i paesi poveri e a medio livello di sviluppo, sottoposti all’aggressione economica, finanziaria e militare.-----
Gli elementi precedentemente presentati devono essere interpretati come l’avvisaglia della maturità di un grande regime di accumulazione mondiale nuovo. La fase, e allo stesso tempo, il paradigma dell’accumulazione flessibile, il funzionamento della quale è sottomesso alle priorità del capitale privato e finanziario altamente concentrato.
3. Dalla globalizzazione alla competizione globale
È necessario ricordare che negli ultimi dodici anni gli USA sono stati impegnati in prima linea in ben cinque conflitti. La prima guerra è stata quella del 1991 contro l’Iraq, poi c’è stata la guerra in Croazia e Bosnia, ancora l’aggressione ad opera della NATO (guidata sempre dagli USA) contro la Serbia, poi contro l’Afghanistan ed infine l’ultima ancora in corso contro l’Iraq. Con la scusa del “ terrorismo internazionale” i venti di guerra continuano a soffiare anche verso la Siria, l’Iran, la Corea, le Filippine, la Colombia, e così continuando nel contesto della “guerra globale e permanente”. E la recessione ormai presente da tempo negli USA, anche se mascherata da una crescita economica pompata dall’indebitamento interno ed estero, dal cambio sostenuto e dalla “bolla finanziaria” speculativa di Borsa, mette in evidenza una crisi che ha anche carattere strutturale e non semplicemente ciclico-congiunturale in cui l’economia di guerra è un tentativo di uscita dalla grande crisi economico-finanziaria e di accumulazione.
Ecco perché anche dopo ciò che è accaduto l’11 settembre del 2001 è diventato ancora più lampante che gli USA non possono aspirare ad essere gli unici gendarmi o i moralizzatori del pianeta, non avendo nessuna legittimità per essere una guida unipolare come “polizia del mondo”. Inoltre, devono essere considerati anche un paese che ha seri problemi interni di stabilità e di crescita economica, di sviluppo sociale, di equilibrio generale con forti contrasti etici, politico-economici, sociali, da risolvere. E se il predominio assoluto degli USA è in difficoltà, se la “belle epoque” della globalizzazione a guida unipolare è finita, allora quali sono gli immediati competitori nella spartizione del dominio globale?
Il primo paese da considerare è il Giappone, anche se ormai da anni sta subendo una crisi economica a guida USA, dalla quale ancora non riesce a uscire. Il Giappone è stato per lunghi anni additato come paese esemplare, sfuggito alla colonizzazione e anzi alleato degli occidentali. Questo paese è stato considerato per lunghi anni come un esempio di democrazia ed è stato sostenuto dagli USA sia nell’ingresso della NATO sia nell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Con la convinzione che comunque il processo di sviluppo economico di questo paese non potesse costituire un problema, gli americani hanno sostenuto e trasferito al Giappone tecnologie di importanza determinante. L’economia giapponese però, con la realizzazione di prodotti sempre più sofisticati ed avanzati immessi nel mercato mondiale ed in particolare in quello americano, con i forti tassi di produttività, con il modello della flessibilità e della qualità totale, ha prodotto una sovrabbondanza di capacità industriale che ha portato nel 1997 allo scatenarsi di una crisi di sovrapproduzione. Si tratta di una crisi diretta, imposta e sostenuta nel tempo dal grande capitale USA. È proprio il grande capitale statunitense che si è reso conto che le proprie industrie tecnologiche, elettroniche, delle automobili, ecc., si sono trovate in una situazione di completo assoggettamento al potenziale industriale nipponico. Da quel momento il crollo della guida giapponese si è tirato dietro tutte le economie asiatiche che entrarono in una crisi profonda che si è estesa in breve tempo.
Certo nell’area asiatica le variabili per un nuovo, forte e competitivo polo geoeconomico e geopolitico sono molteplici, a partire dal ruolo che sta esercitando in particolare la Cina che può rafforzare e maggiormente concretizzare le mire espansionistiche a scapito degli USA. Un ruolo nuovo e determinato viene rivestito dall’Europa (soprattutto dopo l’istituzione della moneta unica europea), che oltre ad avere una significativa potenza militare (al momento limitata a livello nazionale ma che si sta attrezzando senza problemi particolari a essere organizzata a livello comunitario) ha una elevata capacità economica e finanziaria, al punto anche di superare gli USA nel volume degli scambi commerciali. Nel contesto presentato si inseriscono i procedimenti e le assunzioni di carattere commerciale e più specificatamente di tipo economico-finanziario da parte dell’UE. Infatti l’UE sta cercando di giocare un ruolo di primo piano e in aperta competizione con gli USA, che tentano in tutti i modi di rilanciare il loro ruolo di “gendarme” di un mondo a guida unipolare. Questo fa sì che l’UE potrebbe diventare la “nuova superpotenza” nel mondo. È chiaro che per poter raggiungere questo risultato l’UE dovrebbe acquisire, oltre ad una unità economica, anche e soprattutto una unità politica, cosa ben più difficile da realizzare considerando le notevoli differenze e discordanze esistenti tra i vari paesi europei.
Va ricordato che l’Unione Europea assomma una popolazione di circa 400 milioni di persone, che hanno degli standard di vita e di modello politico-economico molto simile a quello degli USA. Nell’Unione Europea anche l’Italia gioca un suo ruolo con particolari mire espansionistiche verso i paesi dell’Est europeo e l’Africa mediterranea; la Francia vede un modo per ridiventare una vera potenza mondiale; la Germania cerca soprattutto la sicurezza ed anche un riscatto che le restituisca un prestigio etico e politico, ma soprattutto di espansione geoeconomica. La riunificazione delle due Germanie ha fatto diventare automaticamente questo paese la prima potenza dell’Europa occidentale. La Gran Bretagna, invece, non è entrata volontariamente nell’Unione Monetaria, e può essere considerata una semplice appendice degli USA, essendo, a tutti gli effetti “vassalli fedeli” del grande “feudatario americano”. La Gran Bretagna vede nell’asse con gli USA l’unico modo per mantenere un ruolo di forte e di grande potenza, rafforzando i propri specifici interessi geopolitici.
L’Europa, comunque, non rappresenta soltanto e semplicemente “la testa di ponte” degli USA sull’Eurasia; è per questo che non è stato possibile influenzare fino in fondo in chiave americana il lungo cammino dell’integrazione monetaria ed economica dell’Europa. Le guerre economiche sui mercati del cambio, gli attacchi speculativi sui mercati finanziari, l’uso delle crisi geopolitiche di area (quelle nei Balcani, in Afghanistan, in Iraq, in tutta l’Eurasia, e quelle ad apparenti connotati diversi dell’Argentina, sono sistematiche e sintomatiche) rappresentano momenti di guerra economica, finanziaria, commmerciale e politica di una violenta competizione fra poli geoeconomici, in particolare USA e UE. Quest’ultima è ormai in forte conflitto con gli USA sia per quanto riguarda l’imposizione del nuovo ordine geopolitico mondiale, sia per la spartizione del mercato mondiale sia, infine, per il controllo delle mire espansionistiche geoeconomiche del polo asiatico da parte ancora del Giappone o del nuovo ruolo che può assumere la Cina. Questo è il contesto della competizione globale.
Quelli evidenziati sono solo alcuni aspetti della guerra di egemonia economica che si fa sempre più frontale in tutte le aree del pianeta fra il polo geopolitico-geoeconomico USA e quello dell’UE. E lo scontro è diventato ancora più duro con l’avvento della moneta unica europea e con il timore da parte degli USA che nel tempo crescano le opportunità dell’euro di rafforzarsi e diventare valuta di riserva e di riferimento internazionale.
Comunque la mondializzazione capitalistica e l’intento del capitale finanziario di dominare il movimento di capitale nella sua totalità, non cancellano l’esistenza degli Stati nazionali, bensì tali processi accentuano i fattori di gerarchizzazione tra i paesi e ne ridimensionano la configurazione, acutizzando così i conflitti per il controllo su quelle aree a maggiore interesse di spartizione geopolitica e geoeconomica.
È così identificato il paradigma economico istituzionale della competizione globale per blocchi geoeconomici.
4. Il contesto dell’attuale quadro macroeconomico e le tendenze in atto: l’economia di guerra
I paragrafi precedenti hanno evidenziato come si stia configurando un particolare ed intenso processo di territorializzazione delocalizzativa a carattere nazionale e internazionale dell’economia, spiegabile non soltanto da fenomeni di ristrutturazione e riconversione che interessano l’industria ma che sta mutando lo stesso modo di presentarsi del modello di sviluppo, o meglio di crescita capitalistica. Si afferma una diversa logica economico-produttiva, quella di una nuova accumulazione generalizzata, cioè un paradigma di nuove forme di accumulazione che investono sempre più il sociale, l’intero vivere sociale, attraverso forme sempre più diversificate dei modelli di produzione e nell’organizzazione del lavoro rispetto ai precedenti processi produttivi. Un paradigma dell’accumulazione flessibile, della produzione snella e della terziarizzazione che, però, convive con i modelli di tipo industriale e con al centro sempre il lavoro dipendente, salariato, con logiche sempre più sfrenate di sfruttamento, con estorsioni sempre più massicce di plusvalore assoluto e relativo.
È immediato capire che il modello dell’accumulazione flessibile ha bisogno della ristrutturazione e di un rilancio capitalistico incentrato ancora sullo sfruttamento del lavoro, con forme diversificate a livello internazionale che spiegano la competizione globale come conflitto aperto fra poli geoeconomici, in cui anche l’Italia ormai gioca un ruolo di primaria importanza.
È questo il contesto in cui si afferma la nuova struttura della società del capitale. Ciò avviene a partire da alcune caratterizzazioni che hanno assunto le modalità delle dinamiche della crescita capitalistica collegate nell’ambito di un rapporto capitale-lavoro sempre finalizzato al controllo sociale interno ad ogni paesi capitalista. E ciò è ancora più evidente analizzando i dati macroeconomici della crisi recessiva capitalista, crisi che spinge all’opzione imprescindibile della guerra guerreggiata.
Il rallentamento dell’economia mondiale, palesato in maniera evidente nella seconda metà del 2000 a causa dell’aumento del prezzo del petrolio e del netto indebolimento del processo di accumulazione, si è accentuato nel 2001-2002 e nel 2003. Iniziato negli Stati Uniti si è esteso rapidamente a tutte le aree del globo. Nella media del 2001 il prodotto mondiale è aumentato del 2,5%, contro il 4,7 nel 2000. La sfavorevole fase congiunturale si è accompagnata, ma allo stesso tempo ne è stata influenzata, a un drastico rallentamento degli scambi [2]. La dinamica del commercio mondiale di beni e servizi ha registrato un crollo, dal 12,4% nel 2000 a -0,2 nel 2001 per poi riprendersi nella prima metà del 2002 e stabilizzarsi verso il basso successivamente. La crescita dei flussi commerciali è andata di pari passo con quella dell’attività manifatturiera, segnando l’inizio di un periodo di moderata accumulazione [3]. I dati presentati dall’FMI collocavano per il 2002 il tasso di sviluppo del prodotto e del commercio mondiale al 2,8 e al 2,5% rispettivamente. Più volte nello scorso anno, fino ai primi mesi del 2003, le previsioni sull’andamento dell’economia mondiale sono state riviste al ribasso. Le prospettive di crescita sono solo parzialmente migliorate nei primi mesi del 2003, riflettendo soprattutto l’evoluzione, più favorevole del previsto, grazie agli effetti dell’economia di guerra. Il commercio mondiale di beni e servizi non dovrebbe accelerare molto nel corso del 2003; il suo sviluppo si potrebbe elevare nel 2004, sempre che dovesse tendere a consolidarsi la ripresa dell’economia negli USA, visto che già negli ultimi anni gli investimenti in macchinari e in attrezzature informatiche hanno ripreso a crescere per l’effetto economico del keynesismo di guerra.
L’impulso al rallentamento è provenuto soprattutto dagli USA, le cui importazioni sono cadute; fra il 1994 e il 2000 erano aumentate, in media, di oltre l’11% all’anno. Inoltre nel 2001 l’attività produttiva negli USA è aumentata dell’1,2%, rispetto al 4,1 dell’anno precedente. All’origine dell’andamento ciclico negativo anche del 2002 e 2003 vi è la caduta dell’accumulazione di capitale, soprattutto per i beni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e il consistente ridimensionamento delle scorte. Gli investimenti fissi lordi, cresciuti del 7,6% nel 2000, sono calati del 2,0 nel 2001; il loro contributo alla crescita, da positivo per 1,3 punti percentuali nel 2001, è divenuto negativo. Successivamente nell’ultimo periodo ci sono stati momenti in cui il prodotto è tornato però a salire. Il dato di crescita ha riflesso un aumento parziale dei consumi privati che solo in parte ha compensato la riduzione degli investimenti, iniziata nel 2000 e continuata successivamente; non hanno mostrato miglioramenti, invece, la produzione industriale e il mercato del lavoro che continuano a registrare tassi di disoccupazione superiori al 6% della forza lavoro; esso era pari al 4% alla fine del 2000 [4].
Anche dagli ultimi dati risulta che l’economia americana è in forte difficoltà, evidenziando significativi segni della recessione economica per più trimestri consecutivi. A ciò si può aggiungere una continua perdita di fiducia dei consumatori che negli ultimi mesi ha toccato la soglia più bassa degli ultimi dieci anni e i mercati azionari continuano ad essere in balia di forti tensioni. La debolezza dell’economia americana è riconosciuta anche dalla stessa Federal Reserve, dalla Banca Centrale e da altri organismi economici internazionali che hanno evidenziato i rischi di più intense cadute in termini recessivi e di risvegli di forti tendenze alla deflazione, tant’è che si comincia a parlare anche per il 2003 e il 2004 di eventuale ripresa ma in termini molto lenti. In questo quadro continua l’attacco dell’amministrazione Bush al pubblico impiego. Infatti negli ultimi mesi del 2002 si è avviata la più forte campagna di privatizzazione dei servizi di pubblico impiego degli ultimi 20 anni. Si è arrivati ad ipotizzare che circa 850.000 dipendenti pubblici (cioè la metà del totale ) dovrà passare al settore privato. La manovra ha un chiaro significato perché tende a ridurre i costi del personale in una fase di forte crisi della finanza pubblica e di indebolire i sindacati che nel settore del pubblico impiego degli USA hanno ancora una forte credibilità. Non a caso la legge sulla “Homeland Security” inserisce un forte controllo esercitato dall’Amministrazione Bush sulle assunzioni, i licenziamenti e i trasferimenti del personale civile nel ministero per la Sicurezza Interna. Il processo di privatizzazione portato avanti da Bush non punta ai servizi sanitari o previdenziali, già quasi completamente privatizzati, ma a portare un ulteriore attacco ai sindacati privatizzando, ad esempio, la gestione dei servizi di manutenzione dei pacchi, i servizi di nettezza urbana, la ristorazione negli uffici pubblici, ecc. Si noti inoltre che per tali progetti di privatizzazione la Casa Bianca non avrà bisogno di chiedere alcuna autorizzazione al Parlamento e tutto ciò che, dall’inizio del 2002, si è avuta una ulteriore riduzione dei costi del lavoro trasferendo oltre il 15% del personale civile delle agenzie federali ai privati.
Per quanto riguarda il Giappone, nel 2001 la sua economia è entrata nuovamente in recessione, per la terza volta negli ultimi dieci anni. L’attività economica è diminuita, riflettendo il ciclo negativo degli investimenti privati e la forte caduta delle esportazioni. La produzione industriale è caduta e la domanda interna è rimasta stagnante e la spesa delle famiglie è cresciuta pochissimo. Il tasso di disoccupazione è aumentato, e negli ultimi mesi la piccola ripresa della domanda estera e dell’economia statunitense dovuta agli impulsi dell’economia di guerra, ha determinato un lieve miglioramento del quadro congiunturale giapponese; la produzione industriale si è stabilizzata, le esportazioni hanno segnato piccoli incrementi. Gli organismi economico-finanziari internazionali prevedono per il 2003-2004 una crescita positiva, grazie ancora all’ipotizzato miglioramento del contesto internazionale, piuttosto che ad una effettiva ripresa della domanda interna, ma ciò grazie alla domanda indotta dal contesto generale di economia di guerra.-----
Nel corso del 2001 l’attività economica è rallentata in misura significativa anche nell’area dell’euro. I principali indicatori congiunturali mostrano che la fase recessiva del 2001 ha toccato il suo punto di minimo nel novembre 2001. Nella media dell’anno il prodotto è aumentato dell’1,5%, contro il 3,5 nel 2000. Tutti i paesi dell’area hanno registrato una decelerazione dell’attività nel 2001. Anche per il 2002 e questi ultimi mesi sul rallentamento dell’attività economica nei paesi dell’area hanno pesato la brusca frenata degli investimenti e la netta decelerazione delle esportazioni. Il netto deterioramento delle attese sull’evoluzione della domanda estera ha inciso sull’accumulazione, che si è arrestata. Il tasso di sviluppo dei consumi delle famiglie si è ridotto in misura significativa rispetto all’anno precedente. Il tasso di disoccupazione, sceso di quasi un punto percentuale nel 2000, è rimasto sostanzialmente invariato nel corso del 2001, all’8,3% per crescere poi ulteriormente. La scomposizione settoriale mostra come il rallentamento della crescita dell’occupazione abbia riguardato principalmente il comparto industriale. Anche la creazione di posti di lavoro nei servizi è risultata più lenta rispetto all’anno precedente [5].
In tutti i paesi dell’area si è registrata una moderata intensità della ripresa nel 2002, comunque inferiore a quella degli Stati Uniti. Infatti, contrariamente alle attese di molti operatori, la produzione industriale non ha mostrato segni di accelerazione [6]. Si può stimare che il rallentamento dell’attività economica nell’area dell’euro sia riconducibile per oltre la metà a quello della domanda mondiale, su cui hanno influito i rincari del petrolio negli anni precedenti.
Le principali istituzioni internazionali prevedono inoltre una crescita in ripresa per il biennio 2003-2004. Ciò in previsione di una accelerazione degli investimenti, dei consumi delle famiglie e di una ripresa delle esportazioni; il tutto probabilmente sarà possibile se si continua a mantenere in maniera diretta e indiretta un contesto di keynesismo di guerra.
Si consideri che l’ipotesi di riforma del bilancio europeo da effettuare per il 2006 ha scatenato gli economisti di scuola keynesiana, che vedono la possibilità di realizzare un modello di federalismo classico in modo da utilizzare il bilancio comunitario in funzione di stabilizzazione anticiclica, togliendo così tali funzioni alle singole autorità nazionali. In quest’ambito bisogna considerare ovviamente le spese della difesa e della sicurezza che dovranno essere sussunte in un quadro generale finanziario europeo mettendole al centro della riforma del bilancio comunitario; giustificando tutto ciò in funzione dei mutamenti del quadro geopolitica e della nuova caratterizzazione che si è data la NATO a partire dagli attentati dell’11 settembre del 2001. Si consideri che in un rapporto commissionato dal Governo Federale USA si è evidenziato che i quattro maggiori paesi della UE (Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia) hanno avuto una bassa crescita del PIL per la scarsa spesa della difesa. Il rapporto della RAND si conclude sottolineando che la spesa per la difesa dei suddetti paesi dell’UE è assolutamente insufficiente non solo per gli impegni assunti dalla UE nella NATO ma anche per gli impegni che i paesi membri dell’UE hanno sottoscritto nell’ambito della ESDP (European Security and Defence Policy) e della RRF (Rapid Reaction Force).
Moderazione dell’inflazione, politiche economiche decisamente espansive a connotati militari nelle maggiori economie e la ripresa dei profitti delle imprese maggiormente legate all’economia di guerra, sono, quindi, i fattori principali che potrebbero consentire alle economie avanzate di riportarsi su un sentiero di crescita nel medio termine [7].
5. Il ruolo dell’Italia nella competizione globale
Si sta completando anche in Italia una fase di ristrutturazione e ridefinizione del modello capitalistico che aveva caratterizzato il periodo della ricostruzione post-bellica e della corsa allo sviluppo industriale tipica degli anni ‘60 e ‘70. Non si tratta soltanto del passaggio dall’era taylorista alle forme di liberismo postfordista, ma anche del diffondersi dei diversi modi di presentarsi delle attività produttive, con i connessi mutamenti nelle dinamiche evolutive dello sviluppo e delle soggettualità socio-economiche.
In Italia, così come nel resto dei paesi a capitalismo maturo, si è davanti, oltre che ad alcuni processi di deindustrializzazione e ad una delle tante crisi del capitalismo, anche ad una sua importante trasformazione in chiave economico-sociale che investe l’intera società. Cioè dei processi di modificazione economico-produttiva che creano nuovi bisogni senza soddisfarli, con una concezione della crescita economica, dello stesso modo di essere della vita che induce a diversi comportamenti socio-economici della collettività imposti e coercizzati dalla cultura d’impresa; imposti, cioè, dalla flessibilità dell’impresa diffusa nel tessuto sociale. Si superano, così, molte rigidità della società industrialista basata sulla centralità di fabbrica in un contesto di crescita quantitativa senza qualità dello sviluppo nelle aree centrali e di completa miseria assoluta senza mediazioni nelle aree del Sud e più periferiche.
Ciò spiega ancor meglio i connotati anche qualitativi, oltre che quantitativi, della ristrutturazione del capitale, la sua ridefinizione sociale e come essa assuma sempre più un ruolo fondamentale per comprendere il conflitto di classe delle nuove forme che andrà assumendo.
L’evoluzione del quadro economico internazionale si ripercuote, quindi, necessariamente anche sull’economia italiana. È evidente un rallentamento dell’attività produttiva. Le ultime stime indicano che anche il 2003 sarà un anno in cui difficilmente potrà aversi una ripresa economica. Tale decelerazione è stata causata da un indebolimento molto rapido della domanda aggregata, e ciò attraverso una contrazione dei consumi totali e degli stessi investimenti. È chiaro il legame con il mutamento delle condizioni dell’economia internazionale, in primo luogo del rallentamento della domanda mondiale. Infatti, l’unica componente che ha contribuito a sostenere la crescita, pur modesta, della domanda aggregata (consumi, investimenti, esportazioni) è stata quella interna a carattere derivato e riconducibile comunque soprattutto all’industria connessa alla produzione di tipo militare. Se comunque si nota una piccola ripresa degli investimenti, dovuta soprattutto al settore delle costruzioni e alle infrastrutture, si evidenzia un trend assolutamente negativo per quanto riguarda i consumi. E sembra veramente incredibile la ricetta del governo italiano sul rafforzamento della dotazione di infrastrutture nel Paese e sull’equazione meno tasse e contributi (ovviamente in particolare per le imprese) uguale a più sviluppo. L’incredibilità nasce dal fatto che proprio in questo momento si evidenzia una fase molto critica per la finanza pubblica, e che gli unici provvedimenti per aumentare le entrate fiscali sembrano le privatizzazioni, le cartolarizzazioni e i concordati fiscali. Non si pensa assolutamente invece a ridare slancio al PIL attraverso interventi che rafforzino la struttura produttiva italiana rilanciando l’occupazione. Si pensi al caso del gruppo FIAT che insieme al suo indotto pesa sul PIL per circa lo 0,5% ed è il produttore che ha subito sul mercato europeo la maggiore contrazione delle vendite mentre ai primi anni ‘90 era il secondo gruppo in Europa con una quota del 15%. Sembrerebbe quindi opportuno un rilancio degli investimenti e dell’occupazione e non le manovre ridicole sui condoni e le finte diminuzioni delle tasse.
Il contributo delle attività economiche all’incremento annuo del PIL è stato piuttosto differenziato: positivo ed elevato quello delle attività dei servizi e delle costruzioni, quasi nullo quello delle attività industriali in senso stretto.
Tra il 1995 e il 2001 il PIL è aumentato in Italia in media dell’1,9% ogni anno. Alla base della debole crescita della nostra economia si ritrova una perdita di competitività sia sul mercato internazionale sia su quello interno. Il volume delle esportazioni italiane è aumentato tra il 1995 e il 2001 del 25%. Nello stesso periodo lo sviluppo del commercio mondiale è stato del 45%. La quota percentuale di prodotti italiani nel commercio mondiale, valutata a prezzi costanti, è diminuita tra il 1995 e il 2001 dal 4,6 al 3,7%.
È solo con tali caratterizzazioni macroeconomiche che si può pensare ad una ripresa della crescita del PIL e della domanda interna, cui si dovrebbero aggiungere una dinamica favorevole della redditività di impresa e la riduzione della pressione fiscale, mantenendo alta la domanda di investimenti, che nel 2004 registrerebbero un tasso medio-alto di crescita. Le esportazioni dovrebbero rimanere stabili risentendo della brusca frenata registrata negli ultimi anni.
Il calo della competitività di tutto il sistema economico è dovuto maggiormente ai risultati delle imprese più grandi, in cui si notano ormai da anni difficoltà nel diffondere gli avanzamenti tecnologici, per stimolare la ricerca, per formare capacità gestionali.
In questa direzione spingono sia il peggioramento delle prospettive di ripresa dell’economia internazionale sia la perdita di competitività di prezzo delle nostre esportazioni sui mercati extra-europei. Nel 2003 e 2004 il PIL italiano, traendo stimolo dalla domanda interna sia dal lato dei consumi delle famiglie che degli investimenti, dovrebbe riprendere a crescere più o meno in linea con l’area dell’euro [8].
Il passaggio ormai è chiaro. Il terziario sempre più abbandona il carattere residuale-assistenziale diventando, attraverso i processi di flessibilità e precarizzazione imposti dalla nuova fase capitalista, elemento di mantenimento e accelerazione della crescita quantitativa, fattore trainante di un modello capitalistico che si è allontanato dalla centralità industriale di fabbrica. Un terziario implicito ed esplicito capace di rispondere in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi, alle continue trasformazioni ed evoluzioni della domanda, promuovendo e realizzando di pari passo processi innovativi per i fattori dell’offerta, imponendo all’intero corpo sociale, alle nuove figure del lavoro, del non lavoro e del lavoro negato un adattamento attivo al nuovo ciclo capitalistico basato sull’accumulazione flessibile.
Il modello del capitalismo italiano assume come risorsa principale ancora soprattutto le nuove forme del distretto industriale allargato attraverso la struttura e le dinamiche delle filiere internazionali. Un modello caratterizzato da specializzazione delle strutture e della forza lavoro all’interno di reti di imprese in continua trasformazione, con multilocalizzazione delle attività in presenza di strutture dinamiche e continuamente mutevoli. Al contempo si realizza un massiccio ricorso alla flessibilità salariale, all’intensificazione dei ritmi, all’elevata divisione del lavoro che spinge alla precarizzazione e alla diffusione della negazione dei diritti sindacali.
La competitività della nostra industria ha risentito della frammentazione dell’attività in un numero elevatissimo di imprese piccole. Dimensioni aziendali ridotte conferiscono elasticità al sistema, ma rendono più difficile lo sviluppo di prodotti e tecniche innovative, limitano l’efficienza e puntando fortemente sul continuo processo di flessibilizzazione e precarizzazione del mercato del lavoro.
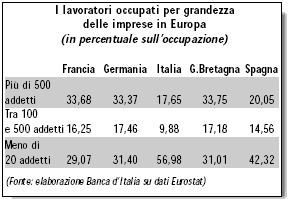
Il 95% delle nostre imprese ha meno di 10 addetti. Il contributo che le piccole imprese hanno fornito negli ultimi decenni allo sviluppo della nostra economia è stato determinante, ma la frammentazione rischia ora di incidere negativamente sulle capacità di crescita.
Il decentramento produttivo, la delocalizzazione, i processi di esternalizzazione messi in essere dalle piccole, ma anche dalle grandi aziende, riduce sempre più la quota di raggruppamenti di imprese all’interno dei quali le condizioni di lavoro sfuggono ad una regolamentazione, il rapporto con il lavoratore è sempre più a carattere individuale, privo di garanzie. A ciò si aggiunge l’estendersi del fenomeno di miniaturizzazione dell’impresa sino alla forma dell’impresa individuale, con il conseguente allargamento del settore del lavoro autonomo di ultima generazione di strati crescenti di lavoratori espulsi dall’impresa madre, costretti ad un precario lavoro deregolamentato, nei fatti ancora più subordinato di quello che avevano in precedenza.
La flessibilità è il nuovo paradigma per realizzare sicuramente i diversi obiettivi del moderno progetto della società del capitale: primo fra tutti un attacco deliberato ai diritti acquisiti dai lavoratori (si pensi all’art.18 e in genere all’attacco all’intero Statuto dei Lavoratori fino allo diritto di sciopero, alla deregolamentazione degli orari di lavoro, alle condizioni del lavoro e ai livelli di reddito). Attraverso la flessibilità si effettua poi una frammentazione della classe lavoratrice e di conseguenza della sua possibilità di associazione (è chiaro che se in un’impresa i lavoratori cambiano continuamente per sottostare ai principi di flessibilità è molto più difficile che si organizzino).
Si va approfondendo così il solco fra un Paese ricco e settori sempre più vasti di popolazione esclusa, precarizzata, vicino alla soglia di povertà; masse sociali spesso rese da tali processi di precarizzazione talmente emarginate e povere da essere considerate fra i “nuovi miserabili” nella società dell’opulenza. Si giunge così alla determinazione di nuove soggettualità locali del lavoro e del lavoro negato, spesso ai margini del sistema produttivo ufficiale, che svolgono attività sottopagate, lavoro nero, lavoratori che pur di avere garantito un minimo reddito sono costrette ad accettare condizioni qualitative di lavoro tipiche dell’inizio del secolo.
Si hanno, inoltre, dinamiche da economia marginale, come ad esempio, le relazioni che tutte le strutture dell’economia stabiliscono con la realtà produttiva meridionale. Relazioni che mutano nel tempo ma che continuano a configurare rapporti funzionali da sottosviluppo, realizzati in maniera specifica per l’evoluzione del sistema in altre aree dell’Italia, per la riproduzione e l’espansione della struttura centrale dell’economia.
È con tale approccio che vanno letti i processi di trasformazione. Si capisce così, ad esempio, come viene utilizzata l’industria tradizionale (produzione standardizzata) nelle aree periferiche a basso costo del lavoro e bassa conflittualità, innalzando i livelli di precarietà sociale; mentre, invece, si mantiene l’industria innovativa (produzioni creative) nelle aree centrali con mercato del lavoro altamente specializzato andando a determinare una sorta di aristocrazia salariata e rendendo marginali ed emarginati gli altri soggetti economici del lavoro. Si pensi ai lavoratori del pubblico impiego, agli artigiani, ai piccoli commercianti, ai lavoratori precari, ai sottoccupati, alle sempre più folte masse di disoccupazione palese o più o meno occulta, fino a giungere alle aree sempre più fitte del lavoro negato, di espulsione e completa emarginazione produttiva, reddituale e sociale.
Questa situazione ha portato alla nascita di una forma di lavoro nuovo, alternativo chiamato anche “lavoro atipico o informale”. La mancanza di protezioni legislative e sindacali fa sì che questi lavoratori non siano garantiti in alcun modo e si trovino, quindi, ad operare in condizioni di lavoro inaccettabili.
Nonostante il rallentamento dell’attività produttiva, nella media l’occupazione, secondo la rilevazione delle forze di lavoro, è aumentata. Ma la corretta lettura di questo dato deve tener conto della precarizzazione del mercato del lavoro, della componente nelle sue diverse forme della quota di occupati di carattere temporaneo; il numero di quelli dipendenti permanenti a tempo pieno ha continuato a crescere anche grazie a specifiche politiche di incentivazione. Questo è dovuto principalmente ad un nuovo sistema economico, che produce quote sempre più elevate di ricchezza con quote sempre più basse di lavoro; ai processi di informatizzazione che producono un grande risparmio di forza lavoro, permettendo così la diminuzione dell’organico dei lavoratori permanenti a tutto vantaggio di coloro che lavorano in modo precario e a tempo parziale e creando un esercito di lavoratori di riserva in pianta stabile. La disoccupazione, la flessibilità e la precarizzazione di salari e delle forme di lavoro diventano così fenomeni strutturali. La maggiore occupazione si è concentrata nel settore terziario. È ancora aumentato il numero degli occupati nel settore delle costruzioni. Sono invece diminuiti gli addetti all’industria manifatturiera [9].-----
In Italia si può allora sostenere che esistono e coesistono distinte strutture economiche, disomogenee strutture economico-produttive a cui corrispondono soggettualità diverse, derivanti in maniera naturale da tali strutture e tendenze a formazioni degenerative di un processo che ha assunto a volte connotato e risultati non attesi, che possono tramutarsi anche in elementi diforte conflittualità sociale.
Non si tratta, quindi, di un semplice processo di deindustrializzazione ma di una trasformazione capitalistica che crea nuovi soggetti del lavoro, del non lavoro, del lavoro negato, la nascita di nuove attività, la maggior parte delle quali a carattere terziario e precario, che generano, e forzano nello stesso tempo, nuovi meccanismi di crescita, di organizzazione della società e di accumulazione del capitale nella cosiddetta era della nuova globalizzazione, o meglio della competizione globale.
Dai risultati delle diverse fasi dell’analisi-inchiesta che abbiamo realizzato come CESTES-PROTEO, emerge un terziario che sempre più interagisce e si integra con le altre attività produttive, specialmente con quelle industriali con un ruolo strategico produttivo in chiave salariata e subordinata anche dei nuovi soggetti del lavoro autonomo di ultima generazione. Si determina, quindi, un nuovo modello produttivo e localizzativo, che si può definire come un contesto economico produttivo fortemente caratterizzato da un terziario implicito (interno alla stessa industria) ed esplicito che modella il territorio, nella sua caratterizzazione sia economica sia sociale. E attraverso il ruolo del settore terziario assume sempre più una centralità produttiva la risorsa informazione.
Si ha così un paradigma di flessibilizzazione del vivere sociale imposto da un’impresa diffusa socialmente nel sistema territoriale. Si tratta, cioè, di un terziario a centralità comunicazionale che si accompagna a delocalizzazioni, a processi di terziarizzazione, ad esternalizzazioni del ciclo produttivo e ad un modello di flessibilità generale e di sfruttamento nel e del sociale.
Tutto ciò ha assunto un ruolo sempre più trainante del modello di capitalismo italiano, non spiegabile soltanto da semplici processi di deindustrializzazione o di ricompattamento e riconversione industriale, ma dalle esigenze di ristrutturazione e diversificazione complessiva delle modalità della crescita capitalistica. Ci si accorge che cresce un settore terziario che sempre più identifica e si identifica in nuovi soggetti sociali, che tende a caratterizzarsi anche con forme di lavoro a sempre più alto contenuto di precarizzazione e di flessibilità del lavoro e del salario. Ci si trova, così, in presenza di un alto turn over della manodopera con continua creazione e distruzione di lavoro; un aumento del lavoro falsamente indipendente soprattutto nell’industria, un aumento di utilizzo di orari di lavoro e turni non regolari, e infine una crescita costante e continua dei lavori a tempo parziale, determinato, dell’apprendistato, del part-time forzato. La crisi sta portando alla diminuzione del lavoro regolamentato e a tempo indeterminato ma non del lavoro salariato e subordinato. Un lavoro sempre più flessibile e atipico e sempre più spesso attinto attraverso processi di delocalizzazione internazionali alla ricerca di forme di lavoro a scarso contenuto di diritti e a bassissimo salario; a ciò si accompagnata una forte presenza di lavori intellettuali e tecnico professionali spesso precarizzati come quelli manuali e ripetitivi.
La contrazione del costo del lavoro e la flessibilità del lavoro non riescono neppure a rilanciare gli investimenti. L’atteso consolidamento della ripresa dell’economia italiana e internazionale è sperata solo in funzione del carattere complessivo che va assumendo, nelle sue diverse forme, a secondo dei paesi, il contesto di economia di guerra.
Ciò è strettamente correlato ad un contesto di sostenimento della domanda complessiva attraverso politiche economiche di stampo da keynesismo militare nel contesto di “guerra infinita”, che altro non vuol dimostrare se non la possibilità di crescita economica e di ripresa dei processi di accumulazione attraverso un contesto di economia di guerra accompagnato da una compressione generale del costo del lavoro e della spesa sociale.
6. Alcune ipotesi per la ripresa del conflitto capitale-lavoro
Il movimento dei lavoratori, e gli oppositori al modello capitalistico in genere, dovranno fare i conti con lo scenario di keynesismo di guerra come fenomeno economico strutturale e quindi prepararsi a restrizioni da parte dei governi sul piano delle libertà individuali e sindacali, dei diritti in genere e con forme di sviluppo della spesa pubblica a carattere militare, con conseguenti restrizioni economiche che colpiranno sempre di più i salari e la spesa sociale. È questo lo scenario dei prossimi anni entro cui il movimento dei lavoratori dovrà organizzarsi e configgere considerando anche l’ipotesi, suffragata ormai da dati reali, che anche l’economia di guerra difficilmente porterà il capitalismo fuori da una crisi che assume sempre più carattere strutturale.
Si realizza così una società con maggiori differenziazioni sociali, in cui è sempre più ridotto il sistema di protezione sociale a favore delle fasce dei cittadini più deboli. Fasce di nuove marginalità del lavoro e del non lavoro che si allargano sempre più andando a comprendere anche quegli strati di società che fino a non molti anni fa erano ritenuti protetti; come ad esempio i lavoratori del pubblico impiego, alcune fasce di artigiani e commercianti, i pensionati. Si vanno creando, così nel contempo nuove povertà, nuovi bisogni a cui non si riesce o non si vuole dare risposta, ampliando in ultima analisi l’area dell’emarginazione sociale complessiva.
La realtà economica è, quindi, in rapida e ineluttabile evoluzione, ma tende a rendere sempre più evidente la linea di demarcazione fra proprietà - capitale e una classe dei lavoratori che non può accettare quelle compatibilità funzionali alla crisi quantitativa di accumulazione che il capitale sta attraversando.
Le trasformazioni strutturali che stanno caratterizzando il sistema socio-economico sono, anche, trasformazioni nell’essere e nell’interagire dei nuovi soggetti produttivi e sociali in genere, e ciò è possibile leggerlo e interpretarlo attraverso analisi basate sulla centralità del terziario, anche dei servizi alle imprese e alla fabbrica industriale, e su un ruolo dello Stato che assume sempre più le funzioni di sostenimento dell’impresa abbandonando il ruolo di regolatore e mediatore del conflitto capitale-lavoro. Tali processi di trasformazione sono molto spesso ignorati, i nuovi soggetti economici non sono protetti, molto frequentemente neppure considerati, perché è predominante la cultura delle compatibilità industriale. Si ripropongono così analisi politiche, sindacali, contributi scientifici scontati e compatibili agli attuali processi ridefinitori del capitale, ma comunque non riferibili alla concreta realtà socio-economica che ancora una volta va interpretata in termini di classe. I vari modelli di analisi economica e sociale adottati a tutt’oggi da studiosi di varia formazione e collocazione politica risultano ancorati a forme di misurazione basati su parametri elaborati e desunti da una logica interpretativa di “stampo antico” cioè esclusivamente fordista, o proiettate nel futurismo postfordista in cui si suppone superato il conflitto capitale-lavoro. Logiche assunte come centrali da gran parte delle forze sindacali confederali e a volte da forze politiche della sinistra, anche di una parte di quella radicale e alternativa.
Il processo di sviluppo economico che si attraversa ha bisogno di nuove logiche interpretative, di nuovi strumenti ignorati dalle analisi economiche di impostazione “industrialista”, “fordista” e del modernismo postfordista.
L’analisi va, quindi, riportata sul piano delle nuove relazioni industriali. Si individuano così i caratteri strutturali dei sistemi produttivi locali basati sul lavoro specializzato; sull’intensificazione dei ritmi sull’elevata divisione del lavoro, sulla spinta alla specializzazione produttiva; sulla molteplicità dei soggetti economici, di nuovi soggetti del mondo del lavoro; sulla diffusa professionalità dei lavoratori accompagnata, per i lavori più miseri, da commesse esterne con forte componente di lavoro nero e sottopagato; sulla diffusione dei rapporti faccia a faccia senza intermediazioni sindacali.
Le trasformazioni strutturali che stanno caratterizzando il sistema socio-economico sono anche, e forse soprattutto, trasformazioni nell’essere e nell’interagire delle modalità di sviluppo di un capitalismo che abbandonando la centralità di fabbrica propone un sistema produttivo e culturale sempre più spostato e incentrato nel territorio, assecondato dal ruolo attivo del Profit State. Ciò è possibile leggerlo ed interpretarlo solo attraverso analisi disaggregate della distribuzione territoriale delle attività, con una forte caratterizzazione tipica dell’analisi di classe, rilanciando un’offensiva culturale, politica e sindacale a partire da una nuova grande stagione di lotte, di un nuovo grande movimento dei lavoratori realmente indipendente, in cui la CUB e il sindacalismo di base avranno certamente un ruolo da protagonisti.
[1] Per approfondimenti sugli argomenti trattati sinteticamente su questo articolo si possono vedere tra gli altri: Martufi R., Vasapollo L. “EuroBang. La sfida del polo europeo nella competizione globale: inchiesta su lavoro e capitale”, Mediaprint Ediz., Roma 2000; Cararo S.,Casadio M., Martufi R.,Vasapollo L., Viola F., “No Made Italy. Eurobang 2. La multinazionale italia e i lavoratori nella competizione globale, Mediaprint Ediz., Roma 2001; Cararo S.,Casadio M., Martufi R.,Vasapollo L., Viola F., “La Coscienza di Cipputi. EuroBang 3. Lavoro: soggetti e progetti”, Mediaprint Ediz., Roma 2002.
[2] Cfr. Banca d’Italia “Assemblea generale ordinaria dei partecipanti”, tenuta in Roma il 31/05/02. Anno 2001, centottesimo esercizio.
[3] Cfr. Confindustria, Previsioni Macroeconomiche “La politica economica verso la finanza. Federalismo e bilancio pubblico”. Roma. Settembre 2002.
[4] Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze “Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese (2001)”. VolumeI. Edit. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2002.
[5] Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze “Relazione Generale...”, op. già citata.
[6] Cfr. Confindustria, Previsioni Macroeconomiche “La politica economica....”, op.citata.
[7] Cfr. Confindustria, Previsioni Macroeconomiche “La politica economica...”, op. già citata.
[8] Cfr. Confindustria, Previsioni Macroeconomiche “La politica economica...”, op. già citata.
[9] Cfr. Banca d’Italia “Assemblea generale ordinaria dei partecipanti”, tenuta in Roma il 31/05/02. Anno 2001, centottesimo esercizio.