1. Le Crociate vecchie e nuove
Alla fine del capitolo introduttivo della sua opera Era dos extremos, lo storico inglese Eric Hobsbawm dice: “il vecchio secolo non si è concluso bene” [1]. Neanche il più scettico di tutti gli analisti sarebbe riuscito ad immaginare quanto male sarebbe cominciato il secolo XXI. Malgrado la vicinanza degli avvenimenti dell’11 settembre è stato già detto e scritto molto al riguardo, non sempre seguendo il saggio principio della prudenza. Da ciò che è stato affermato fino ad ora, sembra concretizzarsi il presentimento che ci troviamo di fronte ad un mutamento storico. L’immagine dei brutali attacchi alle torri del World Trade Center adesso potrà essere sostituita dalle immagini di avvenimenti ancora più tragici. Chissà quali sorprese ci riserva il futuro ... ma, senza dubbio, l’evento inaugurale del nostro secolo segnerà in maniera indelebile ciò che sta per accadere, nel bene o nel male.
Imperialismo. Il termine, che è stato cancellato dai vocabolari della sinistra durante il decennio degli anni ‘90, acquista adesso rinnovata capacità esplicativa. Come poter spiegare, senza di esso, questa coincidenza temporale tra crisi economica e guerra. Come interpretare gli ampi movimenti diplomatici nordamericani seguiti, come sempre, da ampi spostamenti militari, senza questa categoria.
Quando è stato scritto questo articolo, il mondo, in apprensione, seguiva lo sviluppo di un conflitto militare su larga scala, con la guerra contro l’Iraq e la costruzione di un governo di coalizione in Afghanistan sotto la tutela militare dell’imperialismo. Nelle sue strampalate dichiarazioni iniziali, il presidente George W. Bush ha definito le azioni nordamericane come una “crociata contro il terrorismo”. Consigliato dai collaboratori, preoccupati delle ripercussioni della dichiarazione nel mondo arabo, ha poi abbandonato tale espressione. Ma nella sua xenofobia ed ingenua ignoranza, il presidente degli Stati Uniti ha utilizzato una analogia che può essere utile per la comprensione della guerra attuale.
È bene ricordare. Le Crociate, sebbene avessero espliciti obiettivi religiosi, non erano che uno scontro di civiltà pre-huntingtoniane. Facevano parte di un processo di sviluppo ed espansione del nascente capitalismo mercantile, con le sue forze sociali nuove e vigorose. Le loro conquiste più durature furono la ri-configurazione economica, politica e, perché no, culturale del mondo, o perlomeno della piccola porzione situata intorno al Mediterraneo.
I risultati sono noti. Con la vittoria della Prima Crociata, iniziata nel 1096, le città italiane e, in misura minore quelle della Catalogna e della Provenza, si garantivano il dominio del Mediterraneo Orientale e si assicuravano, per la prima volta, il predominio commerciale dell’Asia. Nel 1293, il porto di Genova raccoglieva, come tassa marittima, “tre volte e mezzo più di tutta la rendita reale della monarchia francese” [2].
La nuova Crociata promossa dagli Stati Uniti vede moltissime somiglianze con le precedenti, che possono essere prese come riferimento per permettere una più completa comprensione della situazione attuale. Anche oggi è in atto un tentativo di riconfigurazione economica, politica e culturale del mondo contemporaneo. Si tratta pertanto di una dimensione molto più ampia rispetto a quella che viene esplicitata: la guerra al terrorismo.
L’analogia è quindi pertinente. Ma oltre alle enormi differenze, risultanti da circa nove secoli di passaggi storici, ce n’è una che vogliamo mettere in risalto: mentre l’antica crociata faceva parte di un impulso egemonico di un giovane e vigoroso capitalismo mercantile, la crociata moderna è espressione della crisi organica dell’ordine mondiale capitalista.
2. Crisi organica = crisi economica + crisi politica
Ci sono una serie di espressioni che, a livello mondiale, hanno seguito un processo simultaneo di consacrazione e saturazione, al punto di diventare così familiari alle orecchie e alle menti occidentali che sembrano trasportare con sé l’attributo della naturalezza. È il caso dell’ ordine mondiale. Trattato comunemente come oggetto, ridotto a discussione basata sui mercati gli investimenti, quantificato e studiato come un fenomeno trasparente, quasi contabile, l’ ordine mondiale tuttavia deve essere trattato, prima di tutto, come un processo. Processo che affonda le radici più profonde negli accordi per il ridisegno del mondo del dopo Seconda Guerra Mondiale.
Non può esistere un “ordine” senza un’istituzione che lo organizzi nello stesso tempo in cui lo sta solidificando e potenziando. Tale istituzione riposa sull’ordine costituzionale, costruito nel dopoguerra intorno agli aggiustamenti economici, politici e militari; gli accordi di Bretton Woods, con la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale; gli accordi di Yalta e Postdam, atto di nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; e la creazione dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e del Patto di Varsavia.
Negli anni 1943-1947, questa istituzionalizzazione era basata sull’accordo strategico esistente tra imperialismo e Unione Sovietica e sullo sforzo comune di costruire un ordine mondiale la cui stabilità economica avesse come presupposto la stabilità politica. Il contributo di Mosca per quel nuovo ordine è stato importante. Nell’immediato dopoguerra vennero a volte utilizzati i partiti comunisti nazionali e il prestigio ottenuto dalla disfatta del nazismo per contenere un percorso rivoluzionario che si agitava in alcune parti d’Europa [3]. L’impressionante livello di crescita dei Paesi imperialisti nel dopoguerra ha avuto come presupposto lo spostamento dei conflitti sociali verso la periferia del sistema con a volte la collaborazione dei peggio settori della burocrazia stalinista.
La stabilità politica e la crescita economica di Stati Uniti, Europa e Giappone sono state le caratteristiche dell’ordine mondiale che più lo hanno definito, fino alla fine del decennio degli anni ’60, quando l’intrecciarsi di tre processi su scala mondiale, ha raggiunto in maniera decisiva i meccanismi economici, politici e militari sostenuti dall’imperialismo e da alcuni settori burocratici sovietici nel periodo precedente, scompigliando così l’“ordine”: la crisi economica; il processo di decolonizzazione e la nascita di un nazionalismo terzomondista; l’avvento delle lotte delle classi lavoratrici all’interno dei Paesi imperialisti e dell’Est europeo.
Il controllo sulle decisioni centrali -incluse quelle sull’economia- sfuggiva di mano alla borghesia internazionale. Una dopo l’altra le istituzioni del dopoguerra sono state messe in dubbio, svuotate, riformulate. Non è questa la sede per sviluppare a fondo questo tema, basta sapere che la presente crisi economica e politica mondiale trova le sue radici in questo processo secolare.
Con l’annuncio dell’indice negativo del PIL nordamericano nel terzo trimestre del 2001, è stato reso noto ciò che veniva annunciato da molto tempo. La crisi economica era arrivata negli Stati Uniti. Analisti non accecati dalla propaganda nordamericana, avevano messo in guardia sulla gravità della crisi dell’economia mondiale, già dopo il collasso delle borse asiatiche, nel 1997.
In quasi tutti i Paesi del mondo, tra il luglio 1997 e il luglio 1998, le azioni sono scese dal 50 al 75%, fatta eccezione per l’Europa e gli Stati Uniti [4]. Ma i livelli di produzione e gli alti tassi di interesse dell’economia nordamericana sembravano aver sopportato la pressione esterna, al punto che Alan Greenspan, onnipotente capo della Federal Riserve, aveva annunciato, in un intervento al Congresso, che fosse possibile per gli Stati Uniti andare “oltre la storia”, cioè superare gli ostacoli dei cicli economici e raggiungere una crescita permanente [5].
Già molto prima dell’11 settembre si sapeva che tale crescita permanente fosse più un’immagine creata dalla camera oscura dell’ideologia che non una realtà. La crescita dell’economia nordamericana è rimasta molto al di qua della storia, lontana dai livelli di crescita dello stesso capitalismo nordamericano del dopoguerra. Negli anni ‘90, la produttività del lavoro misurata come Prodotto Interno Lordo per ora lavorativa, è cresciuta, in media, dello 0,7%, meno di un terzo del periodo 1950-1973. Il tasso di profitto nell’industria non è andato meglio, è rimasto molto al di sotto della media del dopoguerra, nonostante il crescente contenimento salariale [6].
I primi segnali che la crisi economica era arrivata negli USA sono stati dati dalla caduta degli indici di borsa della “nuova economia”, il Nasdaq. Il suo indice è sceso da 5.060 del marzo 2000, a 2.552 del dicembre dello stesso anno, un calo pari quasi al 50%. Si annunciava così una crisi finanziaria nel cuore stesso del capitalismo finanziario. All’inizio la crisi si è manifestata nel punto più vulnerabile. La crescita smisurata delle azioni delle multinazionali legate all’economia digitale avevano prodotto rapidamente la percezione che i crediti su tali attività corressero il rischio di non realizzarsi.
Svanita la bolla di sapone che aveva alimentato la crescita dei guadagni non finanziari durante la seconda metà degli anni ‘90, è stata la volta dell’industria a dare segnali di crisi. Nel settembre 2001, la produzione industriale nordamericana è scesa dell’1%, accumulando, in 12 mesi, una caduta del 5,8%. Quanto maggiore era stata la crescita della produzione tra il quarto trimestre del 1999 e lo stesso periodo del 2000, tanto maggiore fu la caduta. Così, il settore delle elaborazione dati e correlati, il più corteggiato dai propagandisti della nuova economia, che, tra il 1999 e il 2000, aveva registrato un aumento della produzione del 23,1%, ha avuto una diminuzione del 6,4% [7].
L’impatto della caduta della produzione industriale sul Prodotto Interno Lordo si i è fatta rapidamente sentire. Sebbene il PIL nordamericano sia cresciuto del 4,1% nel 2000, i tassi di crescita sono scesi rapidamente: del 5,7% nel secondo trimestre; dell’1,3% nel terzo e dell’1,9% nel quarto. La tendenza verso il basso ha continuato a manifestarsi nel 2001: solo l’1,3% di crescita nel primo trimestre e lo 0,3% nel secondo. Nel terzo trimestre è successo ciò che ci si aspettava, una caduta dello 0,4% nel PIL nordamericano, registrando il primo indice negativo dalla metà degli anni ’80 [8].
Sebbene non sia possibile comprendere la crisi politica con la crisi economica, è chiaro che tra esse c’è un legame profondo. La crisi economica ha creato un “terreno favorevole” alla crisi politica nella misura in cui sono state compromesse le basi materiali per la costruzione del consenso e della legittimazione dell’ordine borghese. L’assorbimento delle domande non antagoniste, necessario alla costituzione di quel consenso, diventa un processo arduo e raramente completato in modo efficace. La crisi economica ha messo in difficoltà la possibilità di costruzione di un ordine mondiale capace di stabilizzare il dominio imperialista, evitando esplosioni nella periferia del sistema e l’opposizione nei suoi centri.
3. Spese militari e “adeguamento dell’ambiente”
Il collasso dell’Unione Sovietica è stato un colpo fatale per l’ordine mondiale già tanto agitato. Venuta meno la capacità di contenimento di quel soggetto strategico, improvvisamente gli Stati Uniti si sono visti elevati al rango di unica potenza mondiale, proprio nel momento in cui il loro potere economico stava declinando. Il sogno di Ronald Reagan si stava trasformando in un incubo. L’esplosione delle guerre nazionali (Jugoslavia ed ex Repubbliche Sovietiche), etniche e tribali (Somalia, Ruanda e Burundi) e convenzionali (Golfo Persico) delineano gli aspetti più crudeli di quell’incubo. L’emergenza di un movimento antiglobalizzazione che si andava sviluppando, soprattutto ai margini delle istituzioni tradizionali, nell’organizzazione dei movimenti sociali (Seattle, Montreal, Genova); di scioperi generali e insurrezioni urbane contro la politica economica neoliberale (Argentina, Ecuador) e di un attivo movimento sindacale all’interno dei Paesi imperialisti(Germania, Francia), rendono conto della attuale instabilità politica.
La risposta degli Stati Uniti alla crisi organica, che ha cominciato a manifestarsi a partire dalla fine degli anni ‘60, è stata una espansione sempre crescente delle sue capacità repressive. L’insicurezza di Richard Nixon, incapace di risolvere la crisi organica, ha dato luogo al militarismo apocalittico di Ronald Reagan [9]. Durante quest’ultima presidenza, l’ampliamento della capacità militare nordamericana, elevata alla massima potenza, ha provocato un crescente deficit nel bilancio, trasformando gli Stati Uniti in un Paese debitore [10]. Con il collasso dell’Unione Sovietica, alla fine degli anni ‘80, sono stati messi in dubbio i fondamenti stessi della politica estera nordamericana. Eliminato l’avversario strategico, che per decenni era servito da motivazione ai volumi delle spese militari, non sono mancati i sostenitori della possibilità di raccogliere i “proventi della pace”. Dopo aver canalizzato, per anni, parti significative del PIL nelle spese militari, secondo alcuni analisti gli Stati Uniti avrebbero potuto ridurre il deficit del bilancio alimentato dalla corsa agli armamenti sostenuta dai governi di Ronald Reagan e George Bush (padre).
Quando, nel 1993, Bill Clinton andò al potere, molti analisti pensarono fosse giunto il momento di ribaltare l’unilateralismo aggressivo dei repubblicani e delle loro politiche di bilancio, e di definire nuove strategie in merito alla distribuzione delle spese. Ma quando il segretario alla difesa Les Aspin annunciò la nuova politica strategica di bilancio, il Bottom-Up Review (BUR), fu chiaro che tale revisione non sarebbe stata profonda [11].
Nella definizione della nuova politica di difesa nordamericana, il Bottom-Up Review parte da tre grandi eventi: la caduta del Muro di Berlino nel 1989; l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq nel 1990 e l’insuccesso del golpe in Unione Sovietica nel 1991. Tali eventi segnano la fine dello spettro sovietico che aveva segnato la politica di difesa degli Stati Uniti sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e la nascita di “nuove minacce” per la politica e l’economia nordamericane.
Avendo raggiunto una congiuntura favorevole ai propri interessi, la politica estera nordamericana intravedeva l’inizio di un’era di “nuove opportunità”. Questa era la contropartita delle “nuove minacce”. Secondo il documento, “esiste la possibilità che si possa sostituire il confronto Est-Ovest della guerra fredda, con un’era in cui la comunità delle nazioni, guidata dall’impegno comune nei confronti dei principi democratici, dell’economia di libero mercato e del dominio della legge, possa essere significativamente allargata” [12]. Nel linguaggio codificato del Partito Democratico di Bill Clinton, comunità delle nazioni non è altro che un eufemismo per dominio nordamericano, come appare chiaro nella seguente affermazione: “una continua buona volontà da parte degli Stati Uniti di agire come garante della sicurezza sarà un importante fattore nel sostegno alla cooperazione in molte aree. Per questo la nostra strategia presuppone che gli Stati Uniti rimangano il principale garante della sicurezza in Europa, Asia Orientale, Medio Oriente e Sud-Est Asiatico” [13].
Per il governo nordamericano il domino militare è un modo per affermare il predomino economico sul così detto Terzo Mondo, ma anche per garantire il suo predomino sulle altre potenze imperialiste: “I nostri alleati devono essere sensibili ai vincoli che derivano dal legame con gli Stati Uniti, da un lato con le loro assicurazioni e dall’altro con le loro azioni in alcuni ambiti come la politica commerciale, il trasferimento di tecnologie e la partecipazione alle operazioni multinazionali di sicurezza” [14].
L’utilizzazione della forza militare come moneta di scambio, un vero ricatto, diventa esplicito quando il Segretario alla Difesa afferma che “il potere militare sostiene ed è sostenuto dal potere economico e politico. Allo stesso modo, le relazioni di sicurezza si sostengono e sono sostenute dalle relazioni commerciali. Non possiamo aspettarci di migliorare le nostre relazioni commerciali o la nostra posizione commerciale nei confronti degli alleati se non teniamo conto delle nostre relazioni di sicurezza” [15].
Le relazioni economiche con le altre potenze imperialiste sono mediate dal potere militare nordamericano che gli garantisce un accesso privilegiato a mercati e risorse strategiche. I bersagli sono, sicuramente Giappone e Germania (Unione Europea), I principali concorrenti sul mercato mondiale [16].
La minaccia militare diventa così punto chiave della politica estera nordamericana. L’ordine mondiale nato dal collasso dell’Unione Sovietica è lontano dai sogni di pluralismo liberale. Piuttosto che essere la libera interazione delle forze economiche a definire gli aggiustamenti politici esistenti, è il potere coercitivo dello Stato nordamericano a determinare le regole del gioco economico, controllando le altre potenze imperialiste (i cosiddetti alleati) ed i governi dei Paesi del Terzo Mondo.
Mentre teneva sotto controllo gli alleati, il Bottom-Up Review, in assenza di un altro concorrente globale di forza equivalente (global peer competitor), definiva come obiettivo il mantenimento delle forze militari sufficienti a portare avanti, simultaneamente e senza alleati, due grandi conflitti regionali (Major Theater Wars - MTWs) della dimensione della Guerra del Golfo. Il nuovo orientamento dava inoltre inizio alla modernizzazione del programma di difesa, detto della Rivoluzione negli Affari Militari (Revolution in Military Affairs) includendo, gradatamente, nuove e sofisticate tecnologie belliche [17].
Lo spettro dell’Unione Sovietica dava luogo alla minaccia dei Rogue States (Stati canaglia), nazioni che, poste al margine dei sistemi di dominio nordamericano, avrebbero rappresentato una seria minaccia all’ordine mondiale. La lista di tali Stati includeva Cuba, Iran, Libia, Siria, Sudan, Iraq e Corea del Nord, con speciale attenzione a queste ultime due. Si delineavano così due teatri di possibili operazioni: Il nord-est e il sud-est asiatico. Ma la sproporzione esistente tra le risorse militari degli Stati Uniti e quelle dei Rogue States, denunciava che i veri avversari non erano quegli Stati, ma piuttosto Russia e Cina [18].
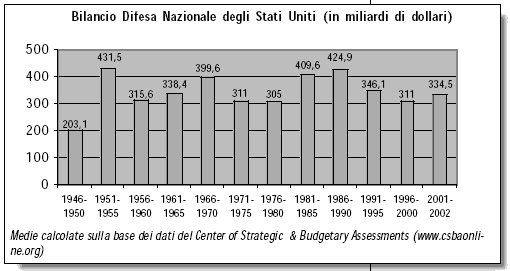
Questa strategia è stata poi approfondita nel Quadrennial Defense Review del 1997. Secondo il Segretario alla Difesa, William Cohen: “le forze degli Stati Uniti devono essere in grado di lottare e vincere, quasi simultaneamente, due major theatre wars. Intanto, sebbene il Bottom-Up sottolinei la difficoltà di questa impresa, abbiamo valutato attentamente altri fattori, come porre maggior enfasi sulla necessità di mantenere una presenza al di là del mare per un adeguamento all’ambiente internazionale ed una maggiore capacità di rispondere a situazioni varie anche di piccola entità e alle minacce asimmetriche” [19].
Un mondo unipolare, ma anche instabile, con la capacità di contenimento dell’Unione Sovietica enormemente ridotta, aumentava a dismisura il ventaglio di possibili operazioni di difesa da parte nordamericana. Così, venivano incluse nella strategia di difesa non solo le possibili minacce simultanee di due potenze regionali, ma anche “contingenze di piccola entità e minacce asimmetriche”, cioè, azioni rapide in aree considerate strategiche per gli interessi nordamericani, attaccare gruppi “terroristi” e, perché no, evitare la nascita di rivoluzioni popolari e la crescita del movimento antiglobalizzazione. Si deve ricordare che lo stesso Quadrennial Defense Review contemplava come obiettivo, oltre alla difesa degli Stati Uniti e dei suoi alleati, la garanzia di “accesso senza restrizioni ai mercati chiave, fonti di energia e risorse strategiche” [20].
In questo modo, con l’indicazione “adeguare l’ambiente internazionale”, si sarebbero intensificati i programmi militari di assistenza, i contatti con le forze armate di altri Paesi, aumentando il peso delle forze armate nella politica estera nordamericana. Secondo Carl Conetta e Charles Knight, ricercatori del Commonwealth Institute, “il ruolo delle forze armate nordamericane in politica estera non è retrocesso di un passo dopo il declino della minaccia sovietica. Anzi, fino ad ora, è aumentato, assumendo funzioni che prima erano esclusiva responsabilità del Dipartimento di Stato” [21].
Il turno dei repubblicani al potere negli Stati Uniti, ha approfondito ed esplicitato tendenze già presenti nella strategia democratica. Poco prima di essere nominata dal presidente Bush, consigliera per la Sicurezza Nazionale, Condolezza Rice ha annunciato, con i toni belligeranti e auto proclamatori che le sono propri, che i riferimenti alla “comunità internazionale” dei democratici avrebbero dato luogo all’esplicita difesa dell’ “interesse nazionale” nordamericano [22]. Tra questi interessi nazionali ci sono sicuramente gli interessi economici. Uno degli obiettivi dichiarati della politica estera nordamericane è: “promuovere la crescita economica e l’apertura politica ampliando il libero commercio e un sistema monetario internazionale stabile per chi si è impegnato secondo questi principi, e tra questi l’emisfero occidentale che è stato frequentemente trascurato come zona vitale per gli interessi nordamericani” [23].
Nel Quadrennial Defense Review del 2001, presentato quindi dal governo di George W. Bush, viene rafforzata la tematica dell’“interesse nazionale”. In esso la protezione degli interessi nazionali permanenti rimane uno degli obiettivi delle Forze Armate degli Stati Uniti. Ma, oltre all’accesso ai mercati e alle risorse strategiche, viene qui indicato come obiettivo la “vitalità e la produttività dell’economia globale”, ossia, la globalizzazione e il neo liberismo diventanomete della politica militare nordamericana [24].
Per raggiungere i propri obiettivi, secondo il documento, gli Stati Uniti dovrebbero essere capaci di difendersi, di dissuadere qualunque aggressione nelle regioni critiche, di sconfiggere gli aggressori in due grandi conflitti simultanei e, in fine, di gestire un numero limitato di operazioni con contingenti di piccola entità [25].
Il Quadrennial Defense Review del 2001 mantiene ed amplia la strategia dei due conflitti regionali simultanei, aumentando i possibili centri di conflitto con l’inclusione del litorale Est dell’Asia, definito come la regione compresa tra il sud del Giappone, l’Australia ed il golfo del Bengala, cioè, la frontiera cinese. Pubblicato dopo l’attentato dell’11 settembre, il documento presenta anche un nuovo paradigma strategico. Esce di scena il piano di difesa “basato sulle minacce” ed al suo posto ne compare uno “basato sulle capacità”, che mette a fuoco più come l’avversario potrebbe attaccare che non chi potrebbe essere o quando potrebbe accadere [26]. Questo nuovo paradigma permetterebbe non solo di preparare gli Stati Uniti ad affrontare minacce di gruppi “terroristici”, ma anche di aumentarne l’efficacia contro rivoluzioni o movimenti sociali.
La nuova strategia, definita a partire dal 1993, aveva modificato sostanzialmente il tipo di operazioni nelle quali si trovavano coinvolti gli Stati Uniti. Sebbene, prima della guerra contro l’Afghanistan, il numero di militari effettivi nordamericani in altri Paesi fosse circa metà della media degli anni ’80, cresceva il numero di nazioni in cui gli Stati Uniti mantenevano una presenza militare. Il numero delle esercitazioni è raddoppiato ed il numero di persone impiegate in operazioni è triplicato, raggiungendo, nel dicembre 2000 la cifra di 35 mila.
Sulla base di questa nuova strategia il bilancio militare nordamericano non riprende la sua crescita fino al 1999. Ma è bene sottolineare che la diminuzione del bilancio della difesa nordamericana, nei primi anni ’90, mantiene i costi allo stesso livello della guerra fredda. Stabilendo una media dei costi in modo da escludere lo sprint finale della corsa agli armamenti avvenuto durante la presidenza di Ronald Reagan, vediamo che tra il 1946 e il 1979 la media annuale del bilancio della difesa degli Stati Uniti è stata di 329,7 milioni di dollari, ed è stata costante fino all’anno fiscale 2002. Per l’anno fiscale 2002, l’amministrazione di George Bush aveva stanziato 343,2 milioni per il Pentagono. Prima degli attentati dell’11 settembre, quindi, il bilancio della difesa nordamericano per il 2002 era superiore alla media degli anni della guerra fredda!
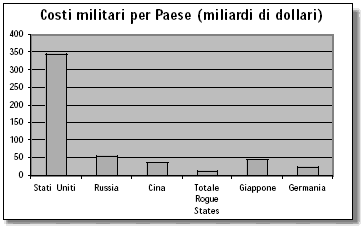
Così, sebbene Democratici e Repubblicani fossero d’accordo con la diminuzione del deficit federale attraverso tagli dei costi pubblici, erano altrettanto d’accordo nel lasciare il bilancio militare fuori da questi tagli. Non sono mancate critiche al super dimensionamento delle forze armate, denuncie sulla sproporzione tra le elevate spese e i modesti nemici esistenti dopo il collasso dell’Unione Sovietica [27]. Se pensiamo ai nuovi scenari che stanno per essere disegnati dalla politica estera nordamericana, vediamo che più che di una inflazione nel bilancio si tratta di una inflazione dei pericoli. -----
4. Potere militare e rivoluzione passiva permanente
La nuova crociata promossa dall’imperialismo nordamericano deve essere interpretata dal punto di vista della sua rinnovata strategia militare e della crescita delle spese militari. Questa non è una guerra contro piccoli nuclei fondamentalisti, è un’azione imperialista che tende ad espandere il controllo politico ed economico sul mondo. O, parafrasando il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, una guerra per “adeguare l’ambiente” e garantire la “vitalità e la produttività dell’economia globale” in un contesto internazionale segnato dalla crisi economica e politica.
“Se Osama bin Laden non esistesse bisognerebbe inventarlo” aveva affermato, pochi giorni dopo l’attentato, George Mambiot sul giornale The Guardian [28]. Di fatto, gli attentati alle torri del World Trade Center si sono trasformati nel pretesto necessario per una nuova offensiva economica e politico-militare nordamericana, una risposta capitalista alla crisi del capitalismo. Da lì la necessità di condannare non soltanto la politica estera nordamericana, ma gli attacchi terroristici che hanno sacrificato migliaia di vite di lavoratori, hanno unificato le forze dell’imperialismo e posto sulla difensiva i movimenti antiglobalizzazione.
La risposta nordamericana presuppone molto più che eliminare Osama bin Laden e si estenderà molto più in là del sud-est asiatico. Certamente il nemico dichiarato è molto più “diffuso” di quanto gli Stati Uniti desidererebbero, come evidenzia Le Monde Diplomatique nel suo numero di ottobre. Ma gli obiettivi sono ben concentrati.
Come ha sottolineato Marco Cepik, in un articolo pubblicato pochi giorni prima dell’inizio degli attacchi, la strategia degli Stati Uniti è così articolata: “1) Una guerra di coalizione il cui nucleo è formato dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, contro il regime dei Talebani in Afghanistan, con l’appoggio locale russo e pachistano. 2) Una escalation repressiva di portata globale contro il terrorismo, definito in modo tale da includere anche le forze insorgenti e le organizzazioni criminali” [29].
Per quanto riguarda il primo punto, il risultato, se favorevole agli Stati Uniti, sarà una maggiore presenza nordamericana in una regione strategica. Al nord, l’Afghanistan confina con le ex repubbliche sovietiche del Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan. La regione, soprattutto quella intorno al Mar Caspio, è ricca di gas naturale, petrolio e uranio, e possiede grandi riserve ancora inesplorate. È anche zona di passaggio e nodo di oleodotti e gasdotti ancora in fase di progettazione ed espansione, che permetterebbero l’accesso a quelle risorse di Cina, India, Giappone e della Comunità Europea. Così ci mette in guardia José Miguel Martins, “considerando che dopo la guerra del Kuwait sarebbero stati i Paesi con forze militari nella regione ad ottenere i contratti di ricostruzione, allora, forse, la coalizione occidentale non si è ristretta soltanto per ragioni ‘militari’” [30].
Completano il quadro: i Rogue States, l’Iraq e l’Iran; una potenza nucleare alleata, il Pakistan; ed all’est, nuovamente lei, la Cina. Ricordiamo che, nell’includere l’area dell’est asiatico tra le priorità strategiche, il Quadrennial Defense Review del 2001 affermava che “esiste la possibilità che emerga nella regione un concorrente militare con una formidabile base di forze”. Il nome di tale potenza non veniva menzionato, ma evidentemente era la Cina [i].
Dall’inizio delle operazioni i nordamericani hanno utilizzato le basi militari cedute dall’Uzbekistan e dal Tagikistan, con il consenso del governo di Vladimir Putin. Dal punto di vista commerciale, aveva intravisto la possibilità di utilizzare il suo ruolo strategico nella regione come leva per il rapido ingresso della Russia nell’OMC e per la sua integrazione nell’Unione Europea. Dal punto di vista della politica interna, Putin spera di risolvere definitivamente la questione cecena per la quale ha già ricevuto carta bianca dall’imperialismo occidentale. Sul fronte della politica estera, i russi cercano di recuperare le posizioni strategiche perdute, e partecipare in modo subordinato, ma più attivo, alla creazione di un nuovo ordine mondiale [31].
Ma, sebbene Putin insistesse affinché l’utilizzo delle basi militari nell’Asia centrale fosse regolato dalla Comunità degli Stati Indipendenti, di cui la Russia fa parte insieme alle altre ex repubbliche sovietiche, gli Stati Uniti hanno stipulato accordi diretti con Uzbekistan e Tagikistan. Nonostante le ambizioni di Putin e l’interesse della Russia per lo scenario dell’Asia centrale, da cui si era allontanata dopo la sconfitta in Afghanistan, gli Stati Uniti scommettono sulla trasformazione dell’Uzbekistan in forza alleata regionale [32].
Una conseguenza di questo inaspettato avvicinamento tra Russia e Stati Uniti può essere la neutralizzazione di un altro potente avversario. Negli ultimi anni Russia e Cina erano andati avvicinandosi e avevano firmato, a luglio, il trattato russo-cinese di Buon Vicinato e Cooperazione Amichevole, contrastando gli interessi strategici degli Stati Uniti. L’interesse russo per l’Asia centrale può infastidire entrambi i Paesi, allontanando il pericolo che avrebbe rappresentato l’accordo politico e militare delle due potenze nucleari [33].
La seconda delle dimensioni segnalate da Cepik, quella della “scalata repressiva contro il terrorismo”, rivela la portata della politica imperialista. Definendo il terrorismo in una accezione ampia, si includono in quella categoria tutti gli Stati che si collocano ai margini del sistema di dominio imperialista, come pure tutti i movimenti di contestazione e opposizione ad esso. “Avversari asimmetrici”, nel gergo del Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti. È una sezione fatta su misura per potervi includere il nemico occasionale.
5. Prospettive imperialiste e movimenti sociali
È toccato a Robert Zoellick, capo della delegazione degli Stati Uniti alla conferenza ministeriale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) prendere l’iniziativa e mettere in chiaro le cose. Nel discorso fatto due settimane dopo gli attentati, Zoellick ha affermato: “la scelta degli obiettivi del nostro nemico la Casa Bianca, il Pentagono e le World Trade Towers- evidenzia come il potere e la luce dell’America, emanate dalla nostra politica, sono la sicurezza e la vitalità economica. La nostra controffensiva dovrà confermare la leadership degli Stati Uniti su tutti questi fronti”. D’accordo con Zoellick, gli antichi nemici avevano già compreso che gli Stati Uniti erano “l’arsenale della democrazia”, adesso i nemici avrebbero conosciuto il potere economico nordamericano: “Forza economica -in casa e fuori- è la base del potere duro e duttile degli Stati Uniti. Inoltre, la leadership nordamericana è vitale per promuovere il sistema commerciale internazionale”. Il commercio, ha concluso Zellick, “è più che semplice efficienza economica. Promuove valori nel cuore di questa lunga lotta” [34].
L’artiglieria pesante di Zoellick è stata diretta anche contro il movimento antiglobalizzazione. Nel suo discorso ha affermato che, essendo i terroristi contrari alle idee difese dagli Stati Uniti, è naturale supporre che avessero legami “con chi ha utilizzato la violenza per attaccare la finanza internazionale, la globalizzazione e gli Stait Uniti”. Minacciosamente ha affermato, “Questo presidente (George W. Bush) e questa amministrazione lotteranno per i mercati aperti e il libero commercio. Non ci faremo intimidire da chi ha preso di mira il commercio - e gli Stati Uniti- accusandoli dei mali del mondo” [35].
Il rappresentante nordamericano a Doha non è stato l’unico ad attaccare i movimenti antiglobalizzazione. Greenspan, nel discorso tenuto all’Istituto Internazionale di Economia, si è dedicato a confutare le argomentazioni dei movimenti sociali, concludendo poi che “la globalizzazione è un sistema che può disseminare nel mondo i valori della libertà e del vivere civile, l’antitesi del terrorismo” [36]. Il falso legame, costruito da Greenspan, tra globalizzazione e libertà, trova la sua contropartita in quello stabilito tra resistenze contro la globalizzazione e terrorismo.
L’eco della dichiarazione di guerra contro i movimenti antiglobalizzazione è arrivata anche in Brasile. Gustavo Franco, che quando era presidente della Banca Centrale rimise il controllo della politica monetaria alla Federal Riserve, ha sintetizzato la polemica in poche righe: “Il terrorismo è forse il prodotto più radicale del brodo della cultura antiglobalizzazione? Forse un pretesto sbagliato da parte degli esclusi quanto i metodi di lotta? O una barbarie perpetrata da un gruppo di pazzi? Indipendentemente dalle azioni del presidente Bush, l’attentato deve farci riflettere sui limiti dell’azione politica e sulla strana “libertà di saccheggiare” di chi sfrutta i movimenti antiglobalizzazione” [37].
La guerra commerciale dà luogo alla guerra di fatto. Alla conferenza dell’OMC gli Stati Uniti hanno posto sul tavolo delle negoziazioni le proprie armi. Il messaggio è brutalmente diretto: chi non fosse stato d’accordo con le loro indicazioni economiche avrebbe dovuto fare i conti con le conseguenze. È il paradosso del capitalismo nella sua fase imperialista. Lo sfruttamento della forza lavoro impera e l’espropriazione di ciò che più serve al proprio processo produttivo, cioè ciò che definisce il capitalismo stesso, cedono gradualmente il posto al lavoro compulso e a meccanismi di appropriazione extra economica. Invece di andare “oltre la storia”, l’imperialismo ci porta oltre il presente.
L’idea che la mondializzazione del capitale aveva messo sotto scacco lo Stato-nazione, non ha fatto meno rumore. Si deve ricordare che anche la sinistra si era avvicinata a questa idea. Eric Hobsbawm, ad esempio, è arrivato ad affermare che “il mondo più conveniente per i giganti delle multinazionali, è quello degli Stati nani, o quello dell’assenza dello Stato” [38]. Il mondo più adatto al potere delle multinazionali è quello in cui l’egemonia è ingoiata dalla coercizione, l’ordine economico è nascosto dal potere militare e politico degli Stati. “Microsoft o Goldman Sachs non potranno inviare portaerei o F16 nel Golfo per inseguire Osama bin Laden; soltanto i militari potranno”, ha affermato, a ragione, Francio Fukuyama , dopo essersi svegliato, insieme ad Alan Greenspam, dal sogno di “fine della storia” [39].
L’egemonia affermata dalla politica estera degli Stati Uniti è molto lontana dal rappresentare una rinnovata capacità di direzione politica e ideologica. Piuttosto si afferma, essenzialmente, con la coercizione. È iniziato così il processo di costruzione di un nuovo ordine mondiale che non riesce a trovare il suo punto di equilibrio. E non potrà mai trovarlo. Avendo come presupposto la unilateralità del più forte, è incapace di creare un consenso spontaneo costruito sulla base degli accordi e delle concessioni, come chiede la socialdemocrazia europea. Nell’ordine del capitale, l’idea di piena egemonia, egemonia nel senso gramsciano del termine, di direzione etico-politica, è fuori luogo. Sarebbe più giusto parlare di una rivoluzione passiva permanente, ossia, di un processo continuo di costruzione di un ordine mondiale non inclusivo, in cui l’uso della forza si collega alla corruzione e la frode all’obiettivo di spaccare e frammentare chiunque gli si opponga.
La sfida della sinistra è quella di scomporre questa rivoluzione passiva. Impedire la costruzione di quella riconfigurazione economica, politica e geografica del mondo, sostenuta dai crociati del neoliberismo. Contrapporre alla politica globale dell’imperialismo la politica mondiale degli sfruttati. Impedire che il nuovo secolo inizi peggio di come è terminato il secolo precedente. Una sconfitta degli Stati Uniti e dei suoi alleati è la chiave per tutto questo.
[1] Eric Hobsbawm, Era dos extremis, São Paulo, Companhia das letras, p. 26.
[2] Perry Anderson, Passagem da antiguidade ao feudalismo, São Paulo, Brasiliense, 1992, p. 188. Si veda anche: Henri Perenne, Histórica econômica e social da idade Média, São Paulo, Mestre Jou, 1963, pp. 31-44.
[3] Per il difficile processo di contenimento dei processi rivoluzionari nell’immediato dopoguerra si veda: Pierre Broué, “O fim da segunda Guerra e a contenção da revolução”, in Osvaldo Coggiola, Segunda Guerra Mundial: um balanço histórico, São Paulo, Xamã/FFLCH-USP, 1995.
[4] Robert Brenner, “A crise emergente do capitalismo mundial: do neoliberalismo à depressão”, in Outubro, São Paulo, n. 3, 1999, p. 7.
[5] Alan Greenspan, Statement by Chairman Board of Governors of the Federal Riserve System before the Joint Economic Committee, Washington D.C., United States Congress, 10.06.1998.
[6] Robert Brenner, “The economics of global turbulence”, in New Left Review, n. 229, maggio-giugno, 1998.
[7] Federal Riserve, Statistical release, g. 17, n. 419, supplement, 16.10.2001.
[8] Bureau of Economic Analysis, Overview of the Economy, 31.10.2001, disponibile su: www.bea.doc.gov/bea/glance.htm
[9] Per il passaggio dall’insicurezza alla politica aggressiva di Reagan, si veda: Sebastião Velasco e Cruz, “Desencontros. O Brasil e o mundo no limiar dos anos 80”, in Primiera Versão, IFCH/Unicamp, n. 88, nov. 1999.
[10] Per la politica estera nordamericana del periodo si veda: Fred Halliday, The making of the Second Cold War, Londra, Verso, 1986.
[11] Les Aspin, Report of the Bottom-Up Review, Washington D.C., Department of Defense, 1993, disponibile anche su: www.fas.org/man/docs/bur/index.htm
[12] Idem
[13] Idem
[14] Idem
[15] Idem
[16] Si veda: James Petras e Morris Morley, Empire or republic? American global power and domestic decay, New York Routledge, 1995, cap. 1 e 2. Sui recenti conflitti economici tra Stati Uniti da un lato e Giappone e Germania dall’altro, si veda: Fred C. Bergsten, “Estados Unidos: Los dos frentes del conflictos económicos”, in Foreign Affaire En Español, maggio 2001, disponibile su: www.foreignaffairs-esp.org.
[17] Sul Bottom-Up Review e la strategia dei due MTWs si veda: Gilbert Achcar, La nouvelle guerre froid. Le monde après le Kosovo, Parigi, Presses Universitairescde France, 1999 e Nicholas Guyatt, Another American Century? Londra, Zed, 2000, pp. 114-176. Per Revolution on Military Affaire si veda la lunga lista di articoli e libri accessibili su The Project on Defense Alternatives, The RMA debite, disponibile su www.comw.org/rma/index.html
[18] Si veda al riguardo Gilbert Achcab, Op. cit.
[19] William S. Cohen, “The Secretary message’s”, in US Department of Defense, Quadrennial Defense Review, Washington D.C., 1997.
[20] Molto più esplicito del documento del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ed ispirato alla stessa logica, il documento della Cupola di Washington dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) arriva ad affermare: “Alcuni Paesi e loro vicini dell’area euro-atlantica si trovano in gravi difficoltà economiche,sociali e politiche. Le rivalità etniche, religiose, le dispute territoriali, l’inadeguatezza o l’insuccesso degli sforzi di riforma, la violazione dei diritti umani e la dissoluzione degli Stati, possono produrre instabilità locali e regionali. Le tensioni risultanti possono sfociare in crisi che influenzano la stabilità euro-atlantica, dar luogo a sofferenze umane e provocare conflitti armati”. NATO, Guia completa de la cumbre de Washington, 23-25 aprile 1999, disponibile su: www.nato.int/docu/rdr-gde/rdrgde-sp.pdf
[21] Carl Conetta e Charles Knight, “A New US Military Strategy: Issues and Options”, in Project on Defense Alternatives Briefing Memo, n. 20, 21.05.2001, disponibile su: www.comw.org/pda/0105bm20.html
[22] Condolezza Rice, “La promoción del interés nacional”, in Foreign Affair En Español, gen-feb 2000. Disponibile su: www.foreignaffairs-esp.org
[23] Idem
[24] US Department of Defense, Quadriennal Defense Review, 2001, p. 2
[25] Idem, p. 17.
[26] Donald H. Rumsfeld, “Foreword”, in US Department of Defense, op. cit., 2001, p. IV.
[27] LJ. Korb, “Oour overstuffed Armed Forces”, in Foreign Affaire, v. 74, n. 6, 1995.
[28] George Manbiot, “The need for dissent”, in The Guardian, 18.09.2001
[29] Marco Cepik, “Contra-terrorismo como guerra de coalizão: riscos sistêmicos”, in Conjuntura Politica, n. 30, sett. 2001, disponibile su: http://cevep.ufmg.br/bacp/030/02-wtc.htm
[30] José Miguel Martins, “O terror e a ‘justiça infinita’. Realinhamentos internacionais e o novo alcanne da coerção extra-econômica”, in Conjuntura Politica, n. 30, nov. 2001, disponibile su: http://cevep.ufmg.br/bacp/031/07.htm
[i] Quadrennial Defense Review 2001, op. cit., p. 4
[31] “Suddenly, such good neighbours”, in The Economist, 10.11.2001 e “From evil empire to strategically”, in Business Week, 12.11.2001
[32] Nina Bachkatov, “Porquai Moscou a saisi la balle au bond”, in Le Monde Diplomatique, nov. 2001, p. 14.
[33] Marco Cepik, op. cit., e José Miguel Martins, op. cit.
[34] Robert B. Zoellick, American trade leadership: what is at stake?, Washington D. C., The Washington International Trade Association/The National Policy Association, 25.09.2001, disponibile su: www.npal.org/aid/zoellick.asp
[35] Idem
[36] Alan Greenspan, “A globalização pode semear pelo mundo valores da libertade, antitese do terrorismo”, in O Estrado de S. Pailo, 28.10.2001
[37] Gustavo Franco, “Terror e (anti)globalização”, in O Estrado de S. Paulo, 16.09.2001
[38] Eric Hobsbawm, op.cit., p. 276. A questo riguardo si veda anche la ben articolata critica di Leo Panitch, “The new imperial State”, in new Left Review, n. 2 (second series), mar. 2000.
[39] Francio Fukuyama, “Francio Fukuyama says Tuesday’s attack marks the end of ‘America’s exceptionalism’“, in Financial Times, 15.09.2001