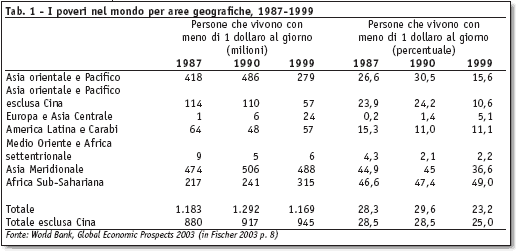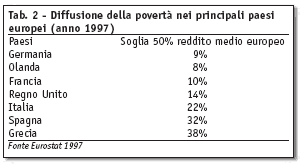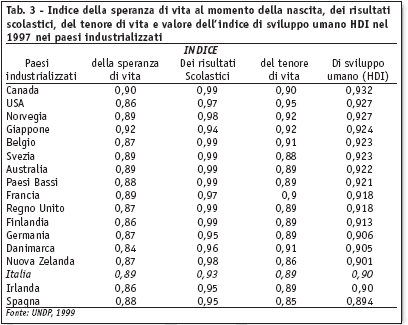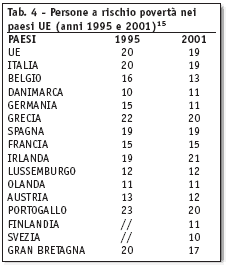![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta: lavoro che cambia, lavoro che non c’è
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
Povero atipico... tipicamente povero. Confronto tra vecchie e nuove povertà in Europa
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
1. Povertà vecchie e nuoveIn teoria ci sono quattro definizioni della povertà generalmente accettate, ognuna delle quali specifica una classe diversa di “poveri”:
Va poi analizzato un altro aspetto: Povero non è solo chi non ha una opportuna quota di reddito per la sussistenza, ma anche chi non può consumare una quantità necessaria di prodotti essenziali perché è una figura marginale del mercato del lavoro. Vi è infatti una parte della popolazione che, pur lavorando e ricevendo quindi un regolare stipendio, risulta inclusa tra i poveri perché il salario risulta l’unica fonte di sostentamento per la famiglia ed è totalmente inadeguato per vivere una vita dignitosa. Comunque povertà è soffrire la fame, è vivere senza un tetto, è essere ammalati e non poter essere visitati da un medico; povertà significa non andare a scuola e non sapere leggere, è non avere un lavoro o avere un lavoro precario, intermittente, è vivere arrangiandosi, è paura del futuro.... Si potrebbe continuare all’infinito nell’elenco dei significati di povertà, ma oggi si parla sempre più di povertà relativa oltre alla povertà assoluta, di nuove povertà, di lavori poveri, di impoverimento dei ceti medi. In passato la povertà è stata quasi del tutto associata ai paesi meno industrializzati, meno sviluppati, più “emarginati” dal moderno sistema economico di sviluppo e si tendeva, quindi, ad allontanare il problema dai paesi a capitalismo maturo che sembravano essere ricchi. Ma ormai negli ultimi anni questa non è assolutamente la situazione reale. In realtà molte analisi e ricerche anche da parte di istituti e centri studi legati ad organismi internazionali, quali l’ONU, la Banca Mondiale, ecc, hanno accertato che la disoccupazione, le disuguaglianze distributive anche legate alla crescita smisurata dei prezzi alla produzione e al consumo e la sempre maggiore precarizzazione di un gran numero di persone nel mercato del lavoro hanno fatto sì che il “problema nuova povertà” sia diventato sempre più grave e in continua crescita. La globalizzazione neoliberista, l’internazionalizzazione dei processi produttivi si accompagnano alla realtà di centinaia e centinaia di milioni di lavoratori disoccupati e precari in tutto il mondo. Il sistema fordista ci aveva abituato al lavoro a tempo pieno e di durata indeterminata, ora invece un grande numero di lavoratori ha un contratto di breve durata o con orario breve, i nuovi lavoratori possono essere impegnati per poche ore al giorno per cinque giorni a settimana, oppure per molte ore al giorno ma solo per due o tre giorni a settimana. Contratti di formazione lavoro, borse di dottorato, apprendistato, piani di inserimento professionale, borse di lavoro, contratti temporanei di anziani in possesso dei requisiti per il pensionamento, lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità, contratti atipici nella pubblica amministrazione, sono solo alcune delle decine di forme e combinazioni dei lavori atipici. Se guardiamo la situazione dal punto di vista dei lavoratori si hanno insicurezza economica, totale mancanza di prospettive, difficoltà di conciliazione dei tempi, precarietà in ogni fase della propria esistenza, ecc. È necessario ricordare che l’aumento della precarizzazione del lavoro porta con sè una crescita dell’instabilità del reddito da lavoro; a ciò si aggiunge il graduale abbattimento del welfare soprattutto in campo previdenziale e sanitario. Tutto questo fa si che la situazione peggiori incessantemente e determini uno stato di precarietà permanente nel e del vivere sociale. “La precarizzazione è un processo generale, un processo che condiziona l’esistenza di tutta la forza lavoro postfordista. Il processo di precarizzazione del lavoro, quest’esperienza d’incertezza comune al lavoro vivo postfordista si è affermata seguendo tappe, svolte, passaggi cruciali. Prime fra tutte le tappe degli interventi legislativi che hanno abbattuto, piano piano, l’intero edificio di garanzie acquisite dal lavoratore fordista e hanno, di fatto introdotto la possibilità di utilizzare la forza lavoro in un regime flessibile” [2] Ed è proprio con la flessibilità imposta dalle regole di efficienza di impresa che si arriva alle condizioni di lavoro precarie, non continuative e temporanee nelle quali il lavoratore è lasciato a se stesso e si trova solo davanti all’imprenditore con il quale deve trattare le condizioni economiche e di tempo del proprio lavoro. La nuova condizione del lavoro diventa sempre più privata dei diritti, degli ammortizzatori sociali, della democrazia stessa; il tutto diventa precario, senza alcuna sicurezza di continuità. “Il precario si trova, oltre che in un confine incerto tra occupazione e inoccupazione, anche in un non meno incerto riconoscimento giuridico dinanzi alle garanzie sociali. Flessibilità, deregolamentazione del rapporto di lavoro, assenza di diritti. Qui la flessibilità non è ricchezza. La flessibilità, per la parte contraente più debole, la forza lavoro, è un fattore di rischio, e l’assenza di garanzie accresce questa debolezza. In questa guerra di logoramento la forza lavoro è lasciata completamente scoperta, sia rispetto al proprio lavoro presente, per il quale non possiede certezze spesso neanche di pagamento, sia rispetto al futuro, come sicurezza di reddito, dato che nessuno lo assicura dai momenti di in occupazione” [3] Tutto ciò si aggiunge e non si va a sostituire alle cosiddette vecchie forme di povertà. I dati ufficiali continuano a segnalare che nei vari Sud del mondo sono più di 100 milioni i bambini che vivono sulla strada, sono 250 milioni i bambini che lavorano, più di 300 milioni di bambini sono soldati e più di un milione di donne giovani sono obbligate a prostituirsi. E tali dati non considerano il “profondo Sud” dove qualsiasi stima è impossibile. Basta ricordare solo che l’80% della popolazione del mondo vive nei paesi del Terzo mondo ed ha a sua disposizione meno del 20% della ricchezza mondiale ed ogni anno oltre 14 milioni di bambini muoiono prima di arrivare a 5 anni. A ciò si aggiunge il fatto che “Un terzo della popolazione che vive nei paesi più poveri - che sono soprattutto paesi africani - ha una speranza di vita alla nascita che non supera i 40 anni...., oltre 1 miliardo di persone non ha accesso all’acqua potabile, 850 milioni di adulti sono analfabeti, 325 milioni di bambini abbandonano le scuole elementari, 700 milioni di persone lavorano con remunerazioni inferiori al livello di sussistenza “ [4]. Questa è la situazione.
Per dare un idea del problema della povertà basta pensare che nel 2001 oltre 1 miliardo e 200 milioni di persone non aveva neanche un dollaro al giorno per soddisfare tutte le proprie necessità di vita (nell’Africa sub-sahariana il 48% della popolazione e nel sud dell’Asia, il 40% hanno meno di un dollaro al giorno mentre in America Latina il 16% della popolazione vive ancora con meno di un dollaro al giorno). Mentre sempre va ricordato che un settimo della popolazione mondiale possiede i quattro quindi della ricchezza, consuma il 70% dell’energia globale e l’85% del legno del pianeta. 2. La disinformazione statistica e la povertà... da lavoroMa come misurare la povertà? Chi viene ritenuto povero e perché, in base a quali criteri? Come convezione all’interno della Unione Europea si è adottato come limite - soglia della povertà un valore pari al 50% del reddito medio europeo pro capite, e quindi “viene considerato povero colui che percepisce annualmente una quota di denaro pari o inferiore al 50% del reddito annuale medio pro capite europeo”.
Nel Primo “Rapporto sulla povertà in Europa” dell’anno 2002 emerge che, dato come indicatore della soglia della povertà la metà del reddito medio, tra gli Stati membri dell’Unione la percentuale più elevata della popolazione povera tra il 1987 e il 1997 si registra in Italia (14,2%) e nel Regno Unito (13,4%). In realtà però questo metodo analizza solo in modo aritmetico il problema in quanto, stabilendo la percentuale di coloro che sono al di sotto del 50% del reddito medio pro capite, si ha una estesa generalizzazione della situazione e non si comprende quale siano le differenze esistenti all’interno della classe dei soggetti al di sotto del “50% di reddito medio pro capite”. Inoltre non va sottovalutato un altro elemento: la crescita del reddito pro capite medio in Europa, ad esempio, è sinonimo di una maggiore ricchezza o piuttosto è dovuto ad una diminuzione delle nascite e quindi della popolazione totale? Ed ancora: per misurare la povertà il conteggio deve essere fatto su base individuale o familiare? Ad oggi comunque non vi è un indicatore generale valido in assoluto per la misurazione della povertà; non sussiste un limite fisso e valido entro cui collocare una persona tra i poveri o meno; non vi è neppure una unità di base sicura sulla quale lavorare (che sia reddito o che sia consumo) [5]. Tra le ipotesi studiate per misurare la povertà vi è l’indicatore dello sviluppo umano HDI (Human Development Index), che si basa sulla “speranza (o aspettativa) di vita”; sul livello di alfabetizzazione raggiunto dal paese considerato, sul tasso di iscrizione alla formazione scolastica; ed infine dal reddito pro capite. Con questo indicatore si calcola (in percentuale o in valori relativi da 0 a 1) il valore di ogni singola voce, poi si fa una media aritmetica per ogni paese considerato, per avere l’indice di sviluppo umano richiesto. È interessante notare nella tabella n. 3 l’applicazione di questo indicatore HDI nei paesi industrializzati per l’anno 1997. L’Italia e la Gran Bretagna raggiungono una percentuale più alta di poveri rispetto anche a paesi come Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. I motivi della povertà in Europa - secondo il rapporto - sono da attribuirsi alle ripercussioni geopolitiche del crollo dell’Unione Sovietica e del blocco dell’Est, che ha causato la nascita di oltre 150 milioni di “nuovi poveri”. A ciò si aggiunge la “recrudescenza dei conflitti nel mondo - compresa l’Europa orientale” che ha causato un aumento del numero di rifugiati, richiedenti asilo e immigrati. Da ultimo ma non ultimo come importanza si aggiunge l’accelerazione del processo di globalizzazione neoliberista, “occasione per una più grande ingiustizia”, denuncia il Rapporto. Infatti si sono globalizzati anche “la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e il terrorismo internazionale” [6]. Si evidenzia ancora la sproporzionata distribuzione delle risorse; ad esempio nel Regno Unito il 20% dei ricchi gode del 43% delle risorse disponibili mentre il 20% dei poveri utilizza soltanto il 6,6%. Tra i nuovi poveri ci sono poi i disoccupati, i lavoratori poveri, gli anziani, le famiglie numerose.
“Disoccupati e “working poor”. La disoccupazione, soprattutto quella di lungo periodo (oltre 6 mesi), rappresenta una delle principali cause della povertà, collegata all’analfabetismo o a una scarsa formazione e acquisizione di competenze, ritenute “insufficienti per rispondere alle esigenze del mondo tecnologico attuale, in continuo cambiamento”. I disoccupati - soprattutto giovani, persone di mezza età e disabili, fisici o psichici - si trovano in tutta Europa: in Austria, ad esempio, il 32% dei disoccupati di lungo periodo vive sotto la minaccia della povertà. Nel 2000 il tasso di disoccupazione in Finlandia è aumentato del 9,8%: un dato che comprende il 21,4% dei giovani fra i 15 e i 24 anni. La Polonia, nel 2001, contava circa 3 milioni di disoccupati. Poi ci sono i lavoratori poveri (“working poor”) a motivo dei salari esigui; fra loro anche medici e insegnanti. Nella Federazione russa e in Ucraina i bassi stipendi (circa 30 euro al mese), oltre ai ritardi nei pagamenti, provocano esodi di massa; per la scarsa retribuzione solo a Istanbul, in Turchia, oltre un milione di persone soffrivano di denutrizione lo scorso anno. Questa situazione incentiva, come “effetti collaterali”, conseguenze sociali negative: dalla tossicodipendenza in crescita fra i giovani norvegesi e slovacchi, all’alcolismo, che in Polonia coinvolge circa un milione di persone. Gli anziani. In 17 Paesi europei - compresa l’Italia, in particolare il centro-nord - gli anziani sono fra i più poveri della società, per le pensioni troppo esigue. In Belgio, ad esempio, le pensioni rappresentano il 37% di un salario medio; in Bulgaria la pensione sociale media si aggira intorno ai 40 euro e quella minima ammonta a 23 euro. In un’Europa in cui la crescita demografica registra dati negativi e l’aspettativa di vita si allunga, gli anziani rappresentano “una delle fasce più importanti della società”, commenta Caritas Europa. “Dopo aver pagato per decenni contributi economici, le persone anziane dovrebbero avere la possibilità di vivere una vecchiaia serena”. All’alba del terzo millennio il numero dei bambini che vivono in stato di povertà è causa di allarme. Un fenomeno che sembra riguardare 17 milioni di bambini in Europea. In alcuni stati 3 bambini su 10 vivono in famiglie con un reddito che è al di sotto del 60% rispetto alla media nazionale, ovvero la soglia per calcolare lo stato di povertà ormai ampiamente accettata in tutta Europa. All’interno dei Paesi dell’Unione Europea la situazione è molto diversa: si va da un minimo del 5,5% di bambini che vivono questa condizione in Svezia alla situazione della Gran Bretagna dove i minori in difficoltà risultano pari al 30,1%. Il secondo paese dopo la Gran Bretagna è proprio l’Italia con il 28,8% di minori in stato di povertà.” [7] Non ci sono indicatori statistici che riescono a misurare con un livello certo l’insieme di queste condizioni di povertà, che evidenziano in tutta Europa un appiattimento verso il modello USA, con la “vecchia povertà” che si accompagna alle “nuove” forme di povertà da lavoro.
3. La via europea al capitalismo selvaggio: convivere con la povertà da lavoroÈ molto importante evidenziare quanto riferito mercoledì 17 dicembre 2003 nella sede dell’UE a Bruxelles:
- BRUXELLES, 17 DIC - In tutta l’Unione europea è a rischio povertà il 15% della popolazione con grandi differenze tra paese e paese: dal 10% della Svezia al 21% dell’Irlanda. Per l’Italia invece il rischio, secondo i dati del 2001, riguarda una percentuale del 19%, così come per la Spagna. Ma il dato sale al 25% per la fascia di età dai 18 ai 24 anni: un giovane su quattro in Italia, così come in Spagna e in Portogallo, è a rischio povertà. È quanto rileva un rapporto della Commissione europea, in base al quale seppure la percentuale di poveri negli ultimi anni sia progressivamente diminuita, più di 55 milioni di persone e un bambino su cinque sono minacciati dalla povertà.. L’esecutivo europeo indica che la strada da seguire per raggiungere l’obiettivo di Lisbona, di sradicare totalmente la povertà entro il 2010, è un impegno coordinato tra gli Stati, la società civile e le autorità locali e regionali [8]. In sostanza negli anni che vanno dal 1995 al 2001 pur essendo diminuita la percentuale di persone a rischio completa povertà (si è passati dal 17% al 15%) restano comunque oltre 55 milioni le persone minacciate. Tra queste i giovani e i minori sono tra le categorie più a rischio anche perché pesa molto l’abbandono scolastico (l’Italia ha una percentuale del 29% a fronte di una media europea del 18,5%). Uno studio della Commissione europea evidenzia che i paesi che investono maggiormente nella protezione sociale (come quelli del Nord Europa) registrano i più bassi livelli di povertà (ad esempio la Svezia ha solo il 10%). “Sei le priorità indicate oggi dall’esecutivo guidato da Romano Prodi per poter raggiungere l’obiettivo di Lisbona, ossia quello di eliminare la povertà entro il 2010: investire in politiche attive del mercato del lavoro, favorire appropriati sistemi di protezione sociale, promuovere l’accesso all’abitazione di coloro che sono più a rischio povertà, concentrare gli sforzi per prevenire l’abbandono prematuro della scuola e facilitare un passaggio dolce dalla scuola al lavoro, contrastare la povertà infantile e quella degli immigrati e delle minoranze etniche. La strada da seguire, per Bruxelles, è quella di un sempre maggiore coordinamento tra gli stati, di un maggior coinvolgimento delle realtà territoriali e locali e della società civile.” [9] Il Patto di Stabilità e Crescita approvato nel 1997 ha cominciato la sua verifica nel 1998, anno in cui i criteri del trattato di Maastricht sono stati attuati nei paesi dell’UE. I dati dell’Euro Panel (ECHP), dell’anno 1997 (ultimo anno disponibile) evidenziano che “il reddito netto mediano familiare equivalente rilevato nei 14 Paesi dell’Unione Europea era di circa 11.623 unità standard di potere d’acquisto; rispetto a questo valore si possono distinguere due gruppi di Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda e Regno Unito caratterizzati da livelli di reddito superiori alla media europea; Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna e Svezia, con livelli di prosperità al di sotto della media” [10]. Negli anni che vanno dal 1994 al 1997 in Italia si è avuto un aumento del divario tra i livelli di reddito familiari nazionali da quelli medi europei, diversamente dalla Grecia, Portogallo e Spagna, paesi nei quali questa differenza è diminuita. Di solito nei paesi UE con bassi livelli di reddito vi sono disuguaglianze distributive maggiori e viceversa; gli unici due paesi che non rispondono a questi criteri sono il Regno Unito e il Belgio che hanno alti livelli del reddito familiare nonostante gli alti valori dell’ “indice di Gini”, che descrive il livello delle disuguaglianze distributive. Tra i paesi con una migliore distribuzione del reddito vi sono la Finlandia, la Danimarca, la Svezia e l’Irlanda mentre Grecia, Italia, Portogallo e Spagna sono quelli con la peggiore redistribuzione. “Relativamente al problema della povertà, nel 1997 il 17,7% dei cittadini dell’Unione europea viveva in una famiglia con reddito inferiore alla linea nazionale di povertà. Le percentuali più elevate si registravano in Portogallo (23,5%) nel Regno Unito (22,4%) e in Grecia (22,3%) mentre quelle più basse in Danimarca (8%) e in Finlandia (8,5%). L’Italia era caratterizzata da un valore superiore alla media europea (19,2%). Tra il 1994 ed il 1997 si è comunque assistito ad una diminuzione del livello medio europeo dell’incidenza della povertà: se nel 1994 la percentuale di individui poveri nell’Unione europea era pari a 18,6%, nel 1997 questa percentuale si era ridotta a quota 17,7%. Ad eccezione della Svezia, sono le donne ad essere maggiormente interessate dal fenomeno rispetto agli uomini; anche le fasce d’età più giovani (0-16 anni) sono caratterizzate in tutti i Paesi ad esclusione della Svezia, Grecia, Finlandia e Danimarca da un tasso di povertà superiore alla media nazionale” [11]. Nei paesi dell’Unione la percentuale di popolazione che risulta essere povera per più di due anni consecutivi raggiunge una percentuale dell’11%. Questo valore arriva all’8% per persone povere da più di 3 anni e al 7% per persone povere per oltre 4 anni. Il Portogallo risulta essere il paese con la più alta percentuale di povertà persistente, in quanto l’11,8% della popolazione resta in condizione di povertà mediamente per 4 anni consecutivi. Il paese invece con la minore diffusione di povertà risulta essere la Danimarca. Per quanto riguarda le retribuzioni nei paesi dell’Unione Europea lo sviluppo dei principi di flessibilità occupazionale e l’adesione al Trattato di Maastricht hanno portato ad un progressivo impoverimento dei salari con una conseguente diminuzione del peso dei redditi da lavoro sul PIL. Anche per la struttura e l’andamento del salario indiretto le condizioni europee tendono ad avvicinarsi sempre più alle determinanti del capitalismo selvaggio anglosassone. Infatti se si analizzano i sistemi di protezione sociale è evidente che negli ultimi 20 anni si è avuto un progressivo deterioramento di ogni sicurezza e di welfare. Infatti in tutti i paesi dell’UE sono stati avviati processi di riforma anche radicale dei precedenti sistemi di protezione sociale e nei mercati del lavoro, fino a giungere ad intensi processi di privatizzazione della sanità, della previdenza, dell’assistenza. A risentirne sono ovviamente le fasce più deboli della società, quelle prive di lavoro e quelle sempre più numerose dei lavoratori intermittenti, precari e atipici in genere. C’è anche un dato importante da evidenziare che riguarda la popolazione rientrante nella fascia cosiddetta della “terza età”. “Sono più di 60 milioni le persone che nei 15 Paesi dell’Unione europea hanno oltre 65 anni di età. Un esercito che rappresenta il 15% della popolazione totale, destinato a superare la soglia del 20% entro il 2020....... La logica dell’invecchiamento della popolazione richiede di essere reinterpretata, utilizzando gli anziani forti e vitali che sono alla ricerca di una ‘piena cittadinanza’ sotto ogni profilo”. Secondo il Rapporto ‘Essere anziano oggi’, il 90% delle persone ‘mature’ si trovano in condizioni discrete pur convivendo con qualche disagio. Per l’Italia il 12,6% degli anziani, si legge nel rapporto, dichiara di avere ‘qualche problema’ pur rimanendo autosufficiente. Questa categoria rappresenta solo il 5,6% in Francia, il 6% in Germania, il 10,2% in Gran Bretagna e il 10,7% in Spagna. Differenze sostanziali anche per quanto riguarda la condizione economica. Le famiglie anziane con un reddito superiore ai 1.000 euro passano dal 24,3% in Spagna fino al 90,6% in Francia. In Italia, la percentuale si attesta al 42,8%, in Gran Bretagna al 49,2% e in Germania al 78,5%... E allora, parte l’appello alle istituzioni europee perché vengano incontro alle esigenze della popolazione over 65... Secondo la ricerca - sottolinea Delai - le risorse economiche che gli anziani sono in grado di trasferire alla famiglia arrivano a 82 miliardi di euro l’anno, pari al 15% del totale delle spese delle famiglie italiane”. [12] La tabella n. 4 evidenzia la percentuale delle persone a rischio povertà in ogni paese dell’Unione Europea per gli anni 1995 e 2001. Ma il precedente dato va supportato e analizzato in funzione della potenzialità di povertà derivante anche dalla disoccupazione e dal lavoro precario in genere. La tabella n. 5 riporta i dati disponibili a livello europeo ed evidenzia sia gli occupati che le persone in cerca di occupazione e in età lavorativa nell’UE a 15 paesi tra il 1993 e il 2000. I dati dell’Eurostat riferiti a dicembre 2003 evidenziano che la disoccupazione nella zona dell’euro è dell’8,8% e dell’8% nell’UE a 15 (si consideri che nel dicembre dell’anno 2002 la disoccupazione era dell’8,6% nella zona dell’euro e del 7,9% nei paesi dell’UE a 15). Se si considera la disoccupazione su base annuale l’Eurostat segnala che il Lussemburgo (3,9%), l’Olanda (4,1%), l’Irlanda (4,5%) e l’Austria (4,6) sono i paesi con tassi minori mentre la Spagna registra la percentuale più alta (11,2%). Sempre a dicembre 2003 il tasso di disoccupazione per i giovani con meno di 25 anni è stato del 16,6% nella zona euro e del 15,4% nell’Ue a 15. [13]
Per quanto riguarda il lavoro temporaneo i dati del 1995, registrano un valore di ore di lavoro temporanei pari 1.671.000 posti di lavoro a tempo pieno annuo nella sola Unione Europea. Il Regno Unito e l’Olanda sono i paesi che hanno utilizzato maggiormente il lavoro temporaneo: la percentuale di richiesta di questa forma di flessibilità è del 3,31% in Gran Bretagna e del 2,68 in Olanda; nel 1997 poi si parla di 880mila lavoratori temporanei occupati giornalmente nel Regno Unito e 225mila in Olanda. [1] Le definizioni sono state date da: L. Frey, R. Livraghi in “Sviluppo umano, povertà umana ed esclusione sociale”, Franco Angeli, 1999 [2] A.Tiddi, Precari, percorsi di vita tra lavoro e non lavoro”, Derive Approdi, Roma, aprile 2002, pag. 25 [3] A.Tiddi, Precari, percorsi di vita tra lavoro...”, op. cit. pag.75 [4] Cfr. M.Zupi, Si può sconfiggere la povertà, Laterza edit., Roma, maggio 2003, pag.XXI [5] In Italia ci sono 2 fonti principali dei dati a riguardo: l’indagine campionaria sulle famiglie della Banca d’Italia e l’indagine ISTAT annuale sui bilanci delle famiglie. [6] Cfr. www.Caritas.it ; Caritas Europa , studio statistico e descrittivo della condizione sociale nel continente grazie ai contributi di 43 Caritas nazionali. [7] Cfr. http://www.edscuola.it/archivio/handicap/poverta2.html [8] http://www.ueitalia2003.it/ITA/Notizie/Notizia_12171735236.htm [9] http://www.didaweb.net/fuoriregistro/leggi.php?a=4040 [10] Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro CNEL Commissione per l’Informazione Commissione Politica economica SESTO RAPPORTO CNEL SULLA DISTRIBUZIONE E REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO IN EUROPA 2000 - 2001, Luglio 2002, pag. 9. [11] Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro CNEL Commissione per l’Informazione Commissione Politica economica SESTO RAPPORTO CNEL SULLA DISTRIBUZIONE E REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO IN EUROPA 2000 - 2001, Luglio 2002, pag. 10. [12] Sabrina Rosci http://www.labitalia.com/articles/Approfondimenti/4361.html [13] www.ansa.it
|