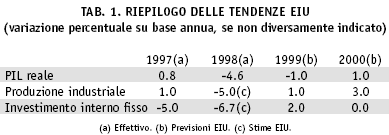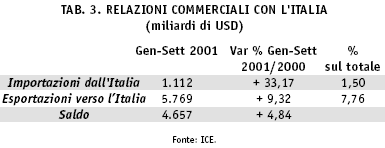![]()
Rubrica
Tendenze della competizione globale
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
Sul capitalismo tedesco Risorse energetiche e controllo geopolitico.Il Grande Gioco nell’Asia centrale Perché la guerra fa bene all’economia (I) Lo scontro geoeconomico per il controllo dell’”ombelico del mondo”
Tutti gli articoli della rubrica "Tendenze della competizione globale"(in tutti i numeri di Proteo)
|
1. Risorse energetiche ed IDE per il rilancio dell’accumulazione capitalistaLa guerra economica di controllo globale, e anche di scontro USA e UE, inizia da anni, ormai, sul terreno delle modalità quantitative, qualitative e delle dinamiche geografiche dell’accaparramento delle risorse energetiche strategiche e degli investimenti, su un terreno geoeconomico di scontro frontale che ha il suo cuore nell’area allargata dell’Eurasia. Partendo da questo punto di vista la mondializzazione dell’economia deve essere studiata con strumenti di indagine geopolitica e geoeconomica che consentano di fare studi su più livelli, che risultino interconnessi, ma analiticamente distinti. Il primo livello si riferisce alla categoria del capitale nel senso delle risorse strategiche della crescita capitalistica, come quelle energetiche e direttamente dell’accumulazione, e quindi degli investimenti, poiché determinati e determinanti la crescita capitalistica come processo-entità volto all’autovalorizzazione del capitale, configurando così le modalità dei rapporti sociali che si basano sulla proprietà privata dei mezzi di produzione. I processi cosiddetti di globalizzazione dell’economia incentrati sulla finanziarizzazione, sulle nuove forme di accumulazione flessibile e la turbolenza dei mercati, diventano, così, fattori di estrema importanza e capaci di influenzare fortemente i processi decisori in materia di creazione di valore degli investimenti e appropriazione di risorse energetiche per favorire l’accumulazione complessiva. Ed è, quindi, ovvio che la competizione tra dollaro ed euro si giochi su questo piano strategico come terreno di guerra economica all’interno delle strategie di spartizione e conquista del mondo. Questo processo ha determinato un ritorno all’investimento produttivo in maniera decisa seppur nel contesto di globalizzazione finanziaria che oggi viviamo. La configurazione del contesto di competizione globale dell’economia è stato voluto ed agevolato dalle grandi strutture del capitalismo internazionale, dai poli geoeconomici per superare la crisi di accumulazione di fine era fordista ed è stato realizzato a partire dai i rilevanti cambiamenti strutturali imposti all’interno dei mercati finanziari; ciò attraverso una liberalizzazione crescente favorita dall’abolizione dei controlli sul mercato dei cambi e sulla deregolamentazione delle operazioni finanziarie e con tassi di investimenti fissi sempre più ridotti a favore degli investimenti finanziari, spesso a carattere speculativo. I capitali di cui godono gli operatori finanziari assicurano la valorizzazione attraverso le loro collocazioni finanziarie, per ritornare in parte al reinvestimento attraverso gli IDE che si effettuano tra diversi paesi indirizzati inizialmente nel settore produttivo, ma fortemente caratterizzati come massa di capitale speculativo pronto ai processi di finanziarizzazione a facili profitti e utilizzato per il controllo geopolitico e geoeconomico. Pertanto, si realizza un controllo del mondo attraverso operazioni di destabilizzazione dei paesi ad interesse strategico (vedi ad esempio tra gli altri l’attacco finanziario sferrato qualche anno fa contro la Russia). Così si va imponendo la "stabilità politico-economica" del grande capitale internazionale. Ad esempio le dinamiche negli IDE statunitensi non sono casuali ma dipendono dalle scelte geopolitiche e geoeconomiche del polo americano, che comunque non vorrebbe cedere tanto facilmente il controllo dell’Europa orientale né alla Russia né all’Europa occidentale, ma nel contempo ha continuo bisogno di attirare capitali e investimenti diretti dall’estero per rafforzare l’economia interna e il ruolo del dollaro come valuta di riserva a valenza internazionale. Anche la nascita del mercato unico dei capitali e dei servizi finanziari in Europa ha agevolato la caccia UE ad un autonomo spazio di sopravvivenza, individuando nell’Eurasia un confinante e allettante "pozzo" da cui attingere risorse energetiche strategiche e dove poter effettuare un rilevante incremento degli investimenti esteri attraverso numerosi processi di ristrutturazione d’impresa con caratteri di internazionalizzazione delocalizzativa. Si realizza così la ricerca di costi più bassi, in particolare per quanto attiene le risorse energetiche, le materie prime e il fattore lavoro, e attraverso fusioni e processi di concentrazione l’UE raggiunge un’alta competitività concorrenziale rispetto ai poli capitalistici giapponese e statunitense. Si può notare che per tutti gli anni ‘90 per l’UE il fenomeno dei movimenti degli IDE risulta molto più dinamico in uscita, quindi in termini di attività, piuttosto che in entrata (passività) poiché le scelte geoeconomiche dei diversi paesi europei non sono basate sull’ “attrazione” dell’Unione Europea dei trasferimenti internazionali dei capitali, quanto sulla ricerca di mercati adatti per la delocalizzazione produttiva e per la conquista di risorse energetiche primarie e umane di buon valore e di basso costo. Ciò è fondamentale per affermare il ruolo di polo geoeconomico forte da parte dell’UE, capace di imporre una propria egemonia in alcune aree nei confronti degli USA, in particolare nei PECO (paesi dell’Europa centro-orientale) e in genere in Eurasia. Non è un caso che con la fine ddell’URSS le scelte geoeconomiche hanno modificato la ripartizione territoriale degli IDE. Precedentemente quasi tre quarti di quelli effettuati dall’Unione Europea avevano come destinatario gli Stati Uniti; ora l’ammontare complessivo degli IDE è destinato principalmente ai paesi del Terzo Mondo, ma in forte crescita sono anche quelli verso i paesi a medio livello di sviluppo, tra i quali assumono sempre più importanza i paesi dell’Europa dell’Est. Ciò conferma i processi delocalizzativi in aree a basso costo del lavoro e delle risorse energetiche e primarie in genere. In entrata dei maggiori paesi dell’UE si registra una più significativa presenza dei flussi di investimento provenienti dagli USA che puntano fortemente al condizionamento dell’economia europea, temendo il ruolo che potrà assumere l’euro come valuta anche di riserva in ambito internazionale. Per quanto riguarda gli investimenti intra europei, questi sono in una fase di crescita notevolmente più rapida rispetto a quelli effettuati dall’Europa verso l’estero; fenomeno dovuto principalmente ai processi di ristrutturazione con fusioni e processi di concentrazione messi in atto dalle imprese europee, anche in questo caso seguendo itinerari verso paesi europei che con basso costo del lavoro che, però, presenta al contempo un buon livello di specializzazione. Questi fenomeni si sono sviluppati di pari passo con la significativa accentuazione della competizione globale attraverso quella dottrina di “stabilità politico-economica internazionale” che viene adattata di volta in volta dai grandi poli geoeconomici per ricondurre a proprio vantaggio le crisi locali o meglio per mantenere uno status quo funzionale agli interessi del grande capitale. Ma la diversità quantitativa, qualitativa e le scelte geoeconomiche accompagnate alle determinanti geopoliche, hanno acutizzato la guerra economica fra il polo imperialista USA e quello europeo per imporre, in particolare dagli anni ’90, l’egemonia internazionale e la priorità di scelta nella determinazione delle aree di influenza e di dominio, in particolare dell’Eurasia. Lo svolgersi, anche diplomatico, e gli esiti della "guerra permanente" impongono un modello neoliberista con un capitalismo sempre più accanito, selvaggio e guerrafondaio, sia nelle relazioni politiche, economiche verso i paesi più poveri, sia verso quelli a medio livello di sviluppo, sia nelle politiche economiche interne ai vari paesi a capitalismo avanzato. Si verifica nel contempo l’acutizzarsi dello scontro egemonico fra i due grandi poli geoeconomici che hanno come obiettivo quello di controllare e rendere a ruolo di suddito la Russia per la conquista dell’Eurasia. 2. Russia: da impero a suddito?Il crollo dell’Unione Sovietica ha cambiato radicalmente il volto dell’Eurasia, in quanto ha aperto la strada agli USA e all’UE per un loro inserimento più determinato nel continente asiatico. Oltre alla grande perdita del prestigio internazionale subito dalla Russia, che è passata dall’essere una potenza internazionale contrapposta per decenni agli USA ad una situazione in cui si ritrova a rappresentare una potenza di modesto livello, la fine dell’Unione Sovietica ha causato un notevole ridimensionamento dei confini, e di conseguenza delle risorse energetiche del sottosuolo di valenza strategica. Dopo il 1991 la Russia si è trovata a fare i conti con una realtà molto diversa dalla precedente; il controllo sul territorio asiatico è stato circoscritto al 20% del precedente e la popolazione asiatica controllata è passata da più di 75 milioni a meno di 30 milioni, mentre molti milioni di russi abitanti nel Caucaso sono rimasti distaccati. Va inoltre ricordato che la grande migrazione di uomini, le differenze etniche esistenti (che venivano in qualche modo controllate dal governo centrale dell’Unione Sovietica) hanno provocato (si veda il Caucaso, la Cecenia, ecc.) e continueranno a causare conflitti che diventeranno sempre più aspri e tragici, non tanto per ragioni etnico-religiose ma proprio per il controllo dell’area che può ritenersi la più grande "miniera energetica" del mondo. La Federazione Russa rappresenta circa 150 milioni di abitanti (in maggioranza russi), ma vi sono milioni di russi che vivono ancora al di fuori del proprio Stato e l’idea di una "restaurazione dell’impero" con l’intento di riunire e difendere coloro che vivono lontano dalla Russia si scontra con la nascita e il consolidamento di nazionalismi ormai radicati e sempre più presenti. "La Russia, insomma, fino a ieri artefice di un grande impero territoriale e alla testa di un blocco ideologico di Stati satelliti che si estendeva fin nel cuore dell’Europa e al Mar Cinese meridionale, è diventata un Paese irrequieto, senza facile accesso geografico al mondo esterno e potenzialmente esposto a conflitti devastanti con i suoi vicini lungo i confini occidentali, meridionali e orientali. E solo gli spazi inabitati e inaccessibili del Nord, quasi sempre stretti nella morsa del gelo, sembravano geopoliticamente sicuri." [1] Il territorio asiatico appartenente all’ex impero sovietico è oggi suddiviso fra Tagikistan, Kirghizistan, Kazakistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Queste aree stanno attraversando un difficile momento economico di instabilità oltre ad essere teatro di ostilità continue interne. Ed anche per quanto riguarda la situazione della regione del Mar Caspio, il crollo dell’URSS ha provocato uno sconvolgimento geopolitico che alletta le mire espansionistiche USA e UE. Infatti mentre fino al 1991 questo territorio poteva essere considerato sovietico ed iraniano, dopo la fine dell’URSS oltre alla federazione russa e alla Repubblica Islamica dell’Iran si sono aggiunti altri tre paesi che si affacciano su questo mare e precisamente il Turkmenistan, l’Azerbaijgian e il Kazakhstan; questo ha fatto sì che gli interessi sul petrolio e sul gas siano diventati mira di tutti e cinque i governi degli Stati costieri. A ciò va aggiunto il fatto che questa zona è sottoposta a un degrado ambientale sempre più forte, in quanto la mancanza di qualsiasi forma di controllo ha fatto sì che anche settori tradizionalmente sviluppati in quest’area, come la pesca, abbiano subito, notevoli perdite economiche; lo stesso si può dire per l’attività turistica che in questa situazione non può avere un ruolo centrale per lo sviluppo economico complessivo. Non essendovi stata alcuna ratifica ufficiale di accordo tra questi cinque paesi per quanto riguarda lo sfruttamento di questa area e delle risorse energetiche, il problema è ancora aperto ed irrisolto. È chiaro quindi che un’area come quella del Mar Caspio, estremamente ricca di risorse energetiche e che per questo "fa gola a tutti" per i giochi geopolitici mondiali, sarà regolata attraverso un accordo tra i cinque Stati costieri che la circondano anche se a tutt’oggi, viste i difficili rapporti esistenti tra questi paesi, non vi è stato alcun tentativo di porre rimedio alla situazione esistente, soprattutto perché non si è giunti ad un "accordo spartitorio" conveniente tra USA, UE e Russia. Dal punto di vista economico la Russia ha subito in questi ultimi anni un crollo molto intenso. Il PIL è diminuito dal 1992 al 1998 di circa il 40% ed attualmente è il 20% del livello dei paesi dell’UE; anche gli investimenti hanno subito una brusca frenata, infatti rappresentano una quota inferiore al 13% del PIL con un calo di oltre il 60%. Negli anni che vanno dal 1992 al 1994, subito dopo le prime riforme economiche, si è avuto un calo della produzione nel settore manifatturiero di oltre il 50%. Tutto questo è stato causato soprattutto dalle difficoltà di inserimento nel mercato a seguito della liberalizzazione dei prezzi avvenuta nel 1992 e del conseguente ritiro delle sovvenzioni dello Stato. Negli anni che vanno dal 1995 al 1999 questa situazione è migliorata, anche se non è possibile paragonare lo sviluppo della Russia a quello delle cosiddette altre economie in transizione come la Polonia e l’Ungheria. Nel 1997 gli investimenti commerciali sono stati inferiori al 13% del PIL e la parte di IDE (Investimenti Diretti esteri) è molto esigua, arrivando a neppure l’1% del PIL (lo 0,8%). Nel 1998 vi è stata una svalutazione del rublo che ha favorito una crescita della produzione industriale nel 1999 (+3,1%).
La svalutazione del rublo, avvenuta in seguito alla crisi finanziaria nell’agosto 1998 ha avuto conseguenze evidenti già nell’anno 1999; il Comitato Statistico statale (Goskomstat) ha rilevato che nel primo semestre del 1999 la Russia ha avuto un calo delle esportazioni dell’11,7% rispetto al 1998 e le importazioni sono diminuite di oltre il 45% su base annua nei primi sei mesi del 1999. È importante anche ricordare che dal 1992 al 1998 le operazioni di importazione ed esportazione della Russia con l’UE è diminuita. Infatti mentre nel 1992 l’UE era destinataria del 48% delle esportazioni della Russia e assicurava il 43% delle importazioni, nel 1998 si è scesi rispettivamente ai valori del 31% e del 36%. I paesi dell’UE che maggiormente mantengono rapporti commerciali con la Russia sono la Germania (con il 35% delle esportazioni dell’UE nel 1998 e il 31% delle importazioni dell’UE), l’Italia (con il 13% delle esportazioni e il 14% delle importazioni), la Francia) con l’8% delle esportazioni e il 10% delle importazioni) e il Regno Unito (con il 6% delle esportazioni e il 10% delle importazioni). La situazione è migliorata nel corso del 2001, in quanto nei primi 9 mesi si è avuta una crescita del PIL del 5,7%, il tasso di inflazione è stato pari al 13,9%, gli investimenti sono cresciuti del 7,8%, la produzione agricola del 7,4%, il commercio al dettaglio del 10,1% e la produzione industriale del 5,2%. Anche la disoccupazione è diminuita passando da circa 7 milioni nel 2000 a 5,7 milioni nei primi nove mesi del 2001, i salari sono cresciuti di circa il 20% e anche il reddito reale della popolazione è aumentato del 6%. Nonostante la diminuzione del fattore estero dello sviluppo economico russo, causato sia dalla riduzione dei prezzi delle materie prime, soprattutto energetiche che rappresentano la parte fondamentale delle esportazioni russe, sia alla rivalutazione del rublo rispetto al dollaro, l’andamento economico è sostenuto soprattutto dalla domanda interna sia di beni di consumo sia di macchinari. "Il debito estero della F.R. a fine Settembre 2001 risulta pari a 143,3 miliardi di USD di cui 93,3 dovuti all’epoca sovietica. Del totale, l’ammontare dovuto al FMI ed alla Banca Mondiale è di 17,6 miliardi di USD e quello dovuto al Club di Parigi è pari a 39 miliardi di USD" [2]. Gli investimenti esteri sono aumentati nei primi nove mesi del 2001 rispetto al 2000 di oltre il 23%; i principali paesi investitori sono la Germania, gli USA, Cipro, la Francia, il Regno Unito i Paesi bassi e l’Italia (Cfr.Tab.2.). Anche per il 2002 le prospettive sono abbastanza positive in quanto si prevede un aumento del PIL pari al 4,5% e una crescita anche degli investimenti esteri. Inoltre "In ogni caso nel corso del prossimo anno dovrebbe aumentare la capacita’ di esportazione di gas e petrolio con l’avvio o l’entrata a regime di alcune importanti opere infrastrutturali tra le quali il gasdotto “blue stream” tra Russia e Turchia (costruito da SAIPEM) e l’oleodotto CPC che porta il petrolio del Caspio a Novorossiisk" [3]. Se si analizzano gli scambi con l’estero si nota che l’Italia nei primi 9 mesi del 2001 risulta essere al secondo posto dopo la Germania come paese di destinazione delle esportazioni e al 6° posto come paese fornitore. (cfr. Tab.3.)
I dati dimostrano che la Russia rappresenta per il nostro Paese un mercato molto importante, soprattutto considerando che la quota delle importazioni dalla Russia è per l’80% rappresentata da gas e petrolio. È importante sottolineare che per tornare ad essere una potenza economica in grado di competere con i "grandi occidentali" la Russia ha necessità di controllare l’Ucraina, un paese di importanza vitale in quanto, otre ad essere popolato da più di 50 milioni di persone, è uno snodo strategico, per la quantità e la qualità delle risorse nel sottosuolo e sorveglia il passaggio al Mar Nero. È chiaro quindi che il controllo di questo paese garantirebbe alla Russia la presenza sia in Europa sia in Asia. Se all’Ucraina si aggiungesse il controllo dell’Azerbaigian (paese anche questo dotato di enormi risorse energetiche e minerarie) la Russia potrebbe aver accesso anche all’Asia Centrale e al Mar Caspio. [4] È importante ricordare che alcuni studi geologici sulla zona hanno stimato che in quest’area potrebbero essere presenti risorse di petrolio per circa 235 miliardi di barili che andrebbero quindi a costituire un nuovo Golfo Persico; ad esempio in Kazakistan è presente un giacimento (a Kashagan) enorme, sfruttato tra l’altro da una compagnia italiana l’Agip che risulta essere la capofila di nove compagnie internazionali tra le quali la Shell, la British Gas la BP-Amoco ecc. L’Azerbaijan poi ha delle riserve per oltre 20 miliardi di barili di petrolio; il Turkmenistan ha più del 25% dell’intera riserva di gas dell’area del Mar Caspio (ossia circa l’8% delle riserve mondiali) senza contare le possibili riserve ancora da accertare. Ed è per questo che la Russia sta cercando di mantenere un certo controllo militare in questi paesi sfruttando anche gli scontri interni. Ciò ovviamente contrasta con le mire espansionistiche occidentali che a tal fine favoriscono i nuovi Stati, facendoli forti della loro "giovane indipendenza" per non permettere a Mosca di installare basi militari nei loro territori. Al momento però, è giusto sottolineare quanto sostenuto da Brzezinski: "Il collasso dell’Unione Sovietica non solo crea aperture per una potenziale proiezione dell’influenza americana sul vuoto euroasiatico, specie attraverso lo sforzo di aiutare il consolidamento degli Stati non russi, ma ha anche grandi conseguenze geopolitiche nelle propaggini sudoccidentali dell’Eurasia: il Medio oriente e il Golfo Persico sono stati trasformati in una zona di palese ed esclusiva influenza statunitense... (anche se n.d.r.)... Con la religione e il nazionalismo che cospirano contro un’egemonia estranea sulla regione, l’attuale supremazia americana nel Medio Oriente si fonda, letteralmente, sulla sabbia" [5]. L’America, infatti, pur essendo lontana da questi territori ha la necessità di controllarli, se non militarmente, almeno economicamente: "La scelta di fondo sarà piuttosto tra un delicato equilibrio regionale... e il conflitto etnico, con la conseguente frammentazione politica, senza escludere neppure lo scoppio di aperte ostilità lungo le frontiere meridionali della Russia. Il raggiungimento di questo equilibrio regionale, e il suo consolidamento, resta l’obiettivo prioritario di qualsiasi geostrategia generale americana per l’Eurasia" [6]. È in gioco il nuovo assetto internazionale post-globalizzazione, un assetto che potrà essere molto diverso da quello dell’ultimo decennio, con gli USA che fanno del tragico attentato dell’11 settembre il motivo ufficiale per rilanciare una strategia di proprio dominio imperiale sul mondo, riaffermando le linee militari e politiche-economiche che ridisegnano la nuova mappa sulla scacchiera del potere globale. E allora gli USA non solo fanno fuori l’ONU, ma fanno della NATO un loro specifico strumento per un primo tentativo di guerra americana contro il terrorismo, ma in effetti per il dominio globale senza possibilità di "spartizione della torta" con nessuno; così vanno letti gli accordi finalizzati solo per accettare un qualche aiuto europeo nella guerra all’Afganistan, il via libera chiesto, o meglio imposto, ai paesi arabi moderati, alla Cina, alla Russia, facendo fuori completamente l’Europa. L’Europa sembra impreparata, in difficoltà, senza una dimensione politica e che subisce lo strapotere militare americano. Una UE ancora non in grado di esprimere una voce alternativa e di reale contropotere agli USA, che ora con la “guerra giusta contro il terrorismo” sono maggiormente in grado di tentare di unificare e influenzare il mondo, per cercare di tornare alla fase unipolare a guida americana di “superimperialismo”. Ma ciò non significa certo rottura della politica di conflitto per poli geoeconomici che sarà sempre più realizzata con atti continui di guerra economica che assumono e assumeranno sempre più la forma di guerra guerreggiata per l’affermazione delle gerarchie. Infatti la soluzione dell’economia di guerra sarà quella accettata e portata avanti anche dall’UE, e quindi dal nostro Paese, perché la situazione di forte crisi economica statunitense ha avuto e avrà ripercussioni recessive in Europa. Ciò però significa, almeno momentaneamente, tenere in secondo piano gli europei con la volontà da parte americana di ritardare la crescita e l’affermazione dell’euro e, quindi, in tutti i modi cercare di ridurre le mire egemoniche ed espansionistiche da parte dell’UE per tentare di rilanciare le strategie di globalizzazione di un unico grande impero a guida USA. Se un ruolo di ritorno prioritario degli USA in un primo tempo è ben visto, o sopportato, da alcuni paesi dell’UE, dalla Russia, dalla Cina, e da altri perché ne potrebbero avere un ritorno economico e politico-strategico immediato (ad esempio vedi il nuovo ruolo a cui aspira Putin per la Russia e la Cina che entra nel WTO), nel medio periodo, invece, ciò significherà l’acutizzarsi delle contraddizioni tra poli geoeconomici. Ciò perché l’UE non può vedere soffocate le proprie mire espansionistiche e non può accettare un ruolo predominante degli USA nell’Eurasia, area di interesse strategico per l’Europa. D’altra parte la Cina, la Russia, ma anche l’India e l’Iran, non possono accettare una presenza di lungo periodo con insediamenti militari a finalità di conquista economica da parte degli USA, poiché l’Asia costituisce l’area di sopravvivenza e di espansione economica da parte di tali nuovi paesi emergenti.
Ma in che modo la Russia può trarre vantaggio da un suo coinvolgimento nella "guerra internazionale contro il terrorismo"? Fintanto che il mondo sarà coinvolto a combattere nel territorio afghano e dintorni la Russia può far funzionare gli oleodotti presenti sulle rive settentrionali del Mar Caspio che va dal Kazakistan alle coste russe del Mar Nero. In questo modo l’oleodotto di Novorossijk può consentire alla Russia di divenire il principale paese in grado di fa arrivare il petrolio dal Mar Caspio all’Europa. In questa fase quindi la Russia percepisce positivamente la presenza degli USA nei territori asiatici, ma se si guarda al lungo periodo viene da chiedersi se questo paese è disposto a cedere gran parte del territorio euroasiatico alle potenze occidentali anche in vista del fatto che, sul fronte della politica interna, sono presenti in Russia molti potenti personaggi economici, e non semplici faccendieri, che, memori della grande potenza anche geoeconomica russa, non vedono di buon occhio la presenza americana nei territori appartenenti in passato all’ex URSS. 3. I PECO: il grande "cantiere" per l’espansione UESi è ben capito da quanto scritto in precedenza che, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, l’Europa centro-orientale è diventata un’area strategica di fondamentale interesse per gli interessi geopolitici e geoeconomici che si vanno imponendo nella competizione globale USA-UE. Infatti questi territori, anche se sono caratterizzati da una situazione diversificata frammentaria e depressiva sul piano socio-economico complessivo, registrano rilevanti potenzialità per le risorse energetiche presenti e per la collocazione spaziale di raccordo tra Asia ed Europa, al punto di attirare i vari paesi a sviluppo avanzato che hanno l’intento di usufruire delle opportunità di investimento e di scambio che tale area offre, insediandosi in zone con un alto significato strategico di controllo. Si è, quindi, in presenza di uno scenario geoeconomico e politico nuovo, impostato su rapporti biunivoci, e non più unilaterale di tipo assistenziale, tra questi paesi e l’Unione Europea e l’ONU. Dal crollo dell’Unione Sovietica e del Muro di Berlino del 1989, l’est europeo è diventato un enorme "cantiere" impegnato in una gigantesca modernizzazione in senso capitalista e di transizione all’economia di mercato. Ciò è divenuto parte rilevante del programma di intervento e di espansione principalmente per molte delle economie dei paesi dell’Unione Europea. Infatti, l’intervento economico nei paesi dell’Europa centro-orientale (PECO) significa la salvaguardia dei notevoli investimenti che le maggiori multinazionali del mondo, e in particolare dell’UE, hanno fatto in questi territori ed anche la partecipazione alla spartizione dei giacimenti di petrolio e di gas dell’Eurasia, alle concessioni ed ai relativi diritti di sfruttamento, nonché al controllo delle rotte degli oleodotti. È allora evidente che l’Europa centro-orientale rappresenta un’area di fondamentale importanza strategica sulla quale si concentrano crescenti fattori di competizione dei due poli imperialisti USA ed UE. La presenza europea e statunitense in tali paesi si è già da tempo concretizzata oltre che in termini di competizione economico-commerciale anche attraverso le varie "guerre umanitarie" susseguitesi in questi anni, che hanno avuto come obiettivo prioritario quello di imporre ad ogni costo la stabilità per salvaguardare i notevoli investimenti e i relativi profitti che le multinazionali hanno, in maniera crescente, realizzato. A tal fine è dal 1993, con il Congresso di Copenaghen, che l’Unione Europea ha sottoscritto con dieci paesi dell’Europa centro-orientale accordi di associazione: Ungheria (marzo 1994), Polonia (Aprile 1994), Romania (Giugno 1995), Slovacchia (Giugno 1995), Lettonia (Ottobre 1995), Estonia (Novembre 1995), Lituania (Dicembre 1995), Bulgaria (Dicembre 1995), Repubblica Ceca (Gennaio 1996), Slovenia (Giugno 1996).) Il fine è l’allargamento a est dell’Europa per inserire definitivamente nella sfera di influenza UE i PECO, facendo fuori da questa area gli USA, e parandosi al contempo, da intromissioni asiatiche, in primis della Cina. Gli strumenti finanziari attraverso cui i dieci candidati dell’Europa centro-orientale possono accedere all’UE sono i programmi Phare, Ispa e Sapard. Phare è un programma di assistenza tecnico-finanziaria e ha come obiettivo di consentire ai dieci PECO di adeguarsi ai criteri di Copenaghen; in termini operativi significa, da un lato, fornire assistenza per permettere alle amministrazioni e alle organizzazioni di rappresentanza di recepire, applicare e far rispettare norme e standard comunitari, dall’altro significa assicurare investimenti per l’adeguamento delle infrastrutture, sviluppare un’economia di mercato, il settore privato e per completare le riforme strutturali necessarie per operare in conformità con gli obiettivi economici e monetari dell’Unione Europea, ovviamente quella basata sui tristemente noti per i lavoratori, parametri di Maastricht e di Amsterdam. Ispa, strumento per le politiche strutturali di preadesione all’UE, ha come scopo il finanziamento dei progetti del valore superiore a 5 miliardi di euro, per lo sviluppo delle infrastrutture ambientali e di trasporto. Sapard, programma speciale di adesione per lo sviluppo dell’agricoltura e delle realtà rurali, gestito a livello decentrato, mira ad aiutare i "dieci" a risolvere problemi strutturali nel settore agricolo ed ad attuare la politica comune agricola (Pac). Per il 20002006 i tre strumenti avranno a disposizione un budget annuale di 3120 miliardi di euro: 1040 per Ispa, 520 per Sapard e 1560 per Phare, di cui 1085 miliardi di euro per i programmi nazionali e di operazioni transfrontaliera, il resto per gli interventi plurinazionali, come la sicurezza nucleare, oppure orizzontali come quello per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI). L’allargamento ai paesi dell’Europa centro-orientale significa chiaramente attuare un processo di integrazione commerciale anche perché le enormi opportunità di localizzazione offerte da questi paesi in transizione, serviranno da incentivo per i movimenti internazionali di capitale, non tanto a carattere finanziario, ma proprio del capitale europeo industriale -produttivo, intensificando al contempo gli scambi commerciali. È interessante notare in quali settori l’UE nel suo complesso, e per ciascun paese membro, presenta dei vantaggi comparati [7] nei confronti sia dei Peco e sia nei confronti del resto del mondo (commercio extra UE). I cinque gruppi di settori nei quali si determinano i vantaggi comparati sono [8]: Gruppo 1. Industrie ad alta tecnologia e alta intensità di capitale umano (per esempio chimica, macchine per ufficio, elettronica areospazio); Gruppo 2. Industrie ad alta intensità di capitale umano e moderata intensità di capitale fisico (per esempio meccanica, beni strumentali); Gruppo 3. Industrie ad alta intensità di lavoro (per esempio cuoio, costruzioni, abbigliamento, legno); Gruppo 4. Industrie ad alta intensità di lavoro e capitale fisico (per esempio siderurgia, vetro, autoveicoli); Gruppo 5. Industrie ad alta intensità di capitale umano e fisico (per esempio minerali non metalliferi, alimentari). Nei confronti del resto del mondo, e in particolare dell’area del dollaro, l’UE presenta vantaggi in tutti i settori tranne in quello ad alta intensità di lavoro ed in quello ad alta tecnologia accompagnata da alta intensità di capitale umano. L’UE presenta notevoli svantaggi nei confronti dei PECO oltre che nel gruppo 3 anche nel gruppo 5 (sono pertanto dei vantaggi dei PECO nei confronti dell’UE); ciò a conferma dell’ "appetibilità" per l’UE di quest’area oltre che per la ricchezza del sottosuolo anche per il basso costo del lavoro nonostante il suo livello medio-alto di specializzazione. Infatti i bassi costi del lavoro che offrono questi paesi consentono un sempre maggiore processo di penetrazione nell’Europa centro orientale. La maggiore occupazione aggiuntiva si è avuta nei settori degli autoveicoli, del tessile. Per i singoli paesi membri dell’Unione Europea si ha una struttura dei vantaggi simile a quella dell’insieme della stessa Unione Europea. Ad esempio per l’Italia si hanno punti di forza nei settori dei prodotti della meccanica e dei beni strumentali, e nei settori con alta intensità di lavoro ossia in quelli tradizionali. Nei confronti dei paesi dell’Europa centro-orientale i vantaggi comparati sono notevoli nel gruppo 2, aumentano quelli relativi al gruppo 4, mentre peggiorano quelli inerenti al gruppo 1 e soprattutto del gruppo 3 a causa dei processi di internazionalizzazione. Considerando singolarmente i tre gruppi di paesi che dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica si sono andati a costituire, e cioè i paesi dell’Europa centrorientale (CC), paesi della Confederazione degli Stati indipendenti (CIS) e quelli dell’ex Jugoslavia (Ju) [9], possiamo meglio cogliere le caratteristiche della struttura geografica e settoriale del commercio italiano. Per quanto riguarda la specializzazione geografica si ha che le regioni del nord Italia sono le uniche ad avere una specializzazione verso i paesi ad elevata crescita della domanda (CC); le regioni del Sud hanno invece un’alta specializzazione geografica verso i paesi a commercio privilegiato [10], cioè verso i paesi dell’ex Jugoslavia ed Albania, e verso quelli caratterizzati da una bassa crescita della domanda (CIS). Per quanto riguarda la specializzazione settoriale le regioni del Nord Italia manifestano in modo assoluto le caratteristiche principali del nostro commercio estero strettamente legato ai gruppi 2, 3 e 4; le regioni del Sud invece hanno una specializzazione settoriale legata ai settori tradizionali e a quelli alimentari (gruppi 3 e 5). Va ricordato che l’industria italiana ha sempre avuto una scarsa tendenza all’internazionalizzazione attiva ossia nell’effettuare investimenti all’estero. Questo in buona parte può dipendere dal fatto che la nostra industria è caratterizzata da piccole e medie imprese, ma tale tendenza oggi sta cambiando, dirigendosi l’internazionalizzazione produttiva italiana significativamente verso i PECO. Guardando alla distribuzione geografica si nota che all’inizio del ’98 nei paesi dell’Europa orientale si concentrava il 16,7% delle imprese a partecipazione italiana ed il 16,4% del numero di addetti coinvolti (all’Europa occidentale spetta il 41,9%, all’America latina il 17,1%). (cfr per la struttura delocalizzativa italiana Tabb. 4,5,6,7) [1] Cfr. Z. Brzezinski, La grande scacchiera", Longanesi, 1998, pag.132. [2] Cfr. www.ICE.it [3] Cfr. www.ICE.it [4] Cfr. Z. Brzezinski, La grande...", op. cit. [5] Cfr. Z. Brzezinski, Il mondo fuori controllo", Longanesi, 1993, pag. 164-165. [6] Cfr. Z. Brzezinski, La grande...", op. cit., pag. 202. [7] Come indicatore di vantaggio comparato viene utilizzato il seguente indicatore: x/X - m/M dove x= esportazioni del settore considerato; X= esportazioni totali; m= importazioni del settore; M= importazioni totali. Si ha un vantaggio (svantaggio) comparato nel settore se l’indicatore assume valore maggiore (minore) di zero. [8] AA.VV., Guida ai paesi dell’Europa centrale, orientale e balcanica, annuario politico-economico 1998: Pier Carlo Padoan, La dimensione economica e commerciale: costi e benefici per l’Italia, pag. 75. [9] I paesi CC sono: Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria; i paesi JU sono: Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro, Croazia, Macedonia, insieme ad Albania; infine i paesi Cis sono: Ucraina, Uzbekistan, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbajgian,Turkmenistan,Tgikistan, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan. [10] Con questo termine si vuole intendere che con tali paesi l’Italia presenta una struttura commerciale caratterizzata da ragioni extra-economiche e cioè da rapporti privilegiati attraverso cui la nostra penetrazione economica non riflette le regole della competitività di mercato.
|