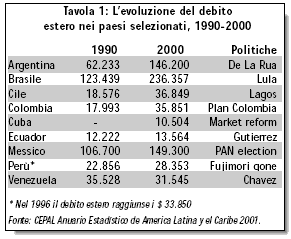![]()
Rubrica
Continente rebelde
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Francisco Domínguez Head of Latin American Studies; Professore alla Middlesex University, London
Argentina: 18 mesi di lotte popolari - un bilancio L’elezione di Lula in Brasile: un’eccezione o una tendenza atinoamericana? La sinistra, il nuovo governo e i movimenti sociali: la speranza brasiliana Continua la crescita dell’economia cubana Los Vientos de Cuba
Tutti gli articoli della rubrica "Continente rebelde"(in tutti i numeri di Proteo)
|
1. IntroduzioneNel 1994 l’esperto messicano di politica Jorge Castañeda scrisse in un libro che ebbe una larga diffusione l’epitaffio delle sinistre latinoamericane:
“La Guerra Fredda è finita, il Comunismo e il blocco socialista sono collassati. Gli Stati Uniti e il capitalismo hanno vinto e in poche aree del pianeta, come in America Latina, questa vittoria è così ben delineata e spettacolare. La democrazia, l’economia di libero mercato, le manifestazioni di sentimenti e di politiche in favore degli americani segnano il panorama di una regione dove fino a poco fa il confronto destra-sinistra, i potenziali di una rivoluzione socialista e la riforma progressista erano assai diffuse. Oggi tecnocrati conservatori, a favore degli affari e degli Stati Uniti, spesso democraticamente eletti, detengono cariche su tutto l’emisfero. Gli Stati Uniti spesero circa trenta anni combattendo i rivoluzionari Marxisti nazionalisti dove la destra era attiva, influente, e a volte al potere e dove ora è in fuga o al cappio” (Unarmed Utopia, Vintage Books, 1994).
Castañeda aveva ragione. Dal Messico fino alla Terra del Fuoco, c’erano governi dediti in un modo o nell’altro al neoliberalismo. L’unica eccezione era Cuba che a causa del collasso del blocco socialista nel 1989-1991 stava attraversando un terrificante supplizio economico. Infatti il 1994, anno in cui Unarmed Utopia fu pubblicato, fu per Cuba l’anno peggiore. La situazione generale era assai peggiore del semplice impegno in politiche neoliberali. La maggior parte dei governi erano entusiasti di essere assorbiti economicamente dagli Stati Uniti in un’area di libero scambio facendovi sprofondare l’intero continente. Il presidente messicano Salinas fu il primo ad esserlo costituendo, nel gennaio del 1994, un’area di libero scambio con il Canada e gli Stati Uniti detta North American Free Trade Agreement (NAFTA o Area Nordamericana di Libero Scambio). La Rivoluzione Sandinista era stata pienamente soffocata a febbraio del 1990 e i processi di pace guidati ed incitati dagli Stati Uniti stavano avendo luogo sia ad El Salvador sia in Guatemala, paesi che sin dal 1989 furono l’epicentro della guerriglia sovversiva marxista. Colombia ed Ecuador stavano seguendo le istruzioni del FMI e parlare della dollarizzazione delle loro economie stava diventando, tra le elites di politici, non solo di moda ma un evento irresistibile. Il Brasile si stava dirigendo verso i due mandati neoliberali di Cardoso, seguito a Collor de Melo, e verso un periodo di confusione a seguito dell’impeachment per corruzione di quest’ultimo. In Perù, dove Alberto Fujimori si stava sempre più rafforzando, la guerriglia dello Shining Path si trovava su posizioni difensive a seguito della generale ritirata della Sinistra. In Argentina, Menem stava facilmente privatizzando tutti i beni nazionali come le linee aeree, le compagnie telefoniche ed ogni azienda di Stato costituita durante i precedenti 50 anni di sviluppo economico. Ditto in Cile, dove il governo Concertacion, una coalizione tra Socialisti Blairite e Democratici Cristiani, mantenne l’edificio neoliberale di Pinochet intatto, fece il massimo per proteggere coloro che erano stati accusati di violazione dei diritti umani, e pose freno alla democratizzazione del paese sotto il vigile occhio dei militari. Paraguay ed Uruguay non erano molto differenti poiché, nonostante la fine delle leggi marziali, avevano governi fedelmente a favore del neoliberalismo. Il Venezuela, un paese che aveva goduto per circa 40 anni di una condizione eccezionale dovuta ai suoi proventi legati all’estrazione del petrolio, aveva resistito ai sanguinosi tumulti del 1989 e a un fallito golpe militare, dopo aver adottato un austero pacchetto di risoluzioni del FMI. Inoltre, con la Sinistra nel caos, il suo rafforzamento elettorale era in rapido declino quasi ovunque, e una maggioranza d’intellettuali e politici legati a questa stavano affrontando un processo di metamorfosi ideologica senza precedenti. Con sorprendente entusiasmo stavano accogliendo il mercato, il neoliberalismo e le politiche della destra. Fernando Henrique Cardoso, presidente del Brasile prima di Lula, incarnava questa tendenza. Dall’essere un ampiamente rispettato intellettuale marxista che aveva influenzato un’intera generazione d’intellettuali latinoamericani, in particolare circa le radici del sottosviluppo, che egli stesso aveva esaminato con competenza nel suo acclamato libro, Il Capitalismo e il Sottosviluppo in America Latina, pubblicato nel 1979, diventò un devoto avvocato delle politiche neoliberali. Molti dei ministri dei paesi recentemente democratizzati che stavano implementando con entusiasmo le politiche economiche della destra erano un tempo intellettuali marxisti. La fino ad ora formidabile guerriglia marxista dell’America Centrale, come la FMLN e la URNG, rispettivamente del Salvador e del Guatemala, abbandonarono la lotta armata e si trasformarono in partiti politici abbracciando politiche liberali. I comandanti Sandinisti di un tempo, come Victor Tirado, arrivarono alla conclusione che non importava quanto duramente si provasse, ma sconfiggere l’imperialismo statunitense era impossibile. Gli Stati Uniti, concludeva Tirado, sono troppo potenti. Questo, quindi insistette su una strategia politica di riforme all’interno dei confini del capitalismo neoliberale. Quindi Tirado arrivò alle stesse conclusioni di Castañeda: il socialismo uscì dall’agenda per sempre. A queste sventure va aggiunto che la Sinistra tradizionale, anche nella forma del partito comunista, andava soffrendo su tutto l’emisfero un declino terminale, una certa confusione, una massiccia riduzione di risorse e una irrilevanza elettorale. Il Partito Comunista Cileno, ad esempio, fino a quel momento uno dei più grandi del continente si ridusse al 3% delle preferenze elettorali. La Sinistra sembrò morta o morente. Ma andando verso il 2000, comunque, la situazione in America Latina sembrò cambiare. Tanto per cominciare, l’integrazione del Messico nel NAFTA cominciò a deteriorarsi portando la svalutazione del peso tra dicembre 1994 e gennaio 1995 a circa il 35%, vicino al collasso economico e ad un massiccio aumento del debito estero ($ 53 miliardi - un aumento di circa il 50%). In effetti, i postumi della sbornia di tequila, colpirono paese dopo paese tutto il continente, in un crescente gorgoglio di malessere economico al quale nessuna nazione sembrò essere immune. È qui che si scoprono i primi barlumi della ricomposizione politica della Sinistra latinoamericana. L’enigmatica immagine mascherata del Subcomandante Marcos, con una fumante pipa sporgente dalla sua faccia ... coperta, stava facendo il giro del mondo, suscitando la simpatia spontanea di milioni di persone per la causa che egli stesso guidava, ossia, per i diritti politici, sociali, economici e culturali delle popolazioni indigene del Chiapas, lo Stato più povero del Messico. La rivolta armata Zapatista cominciò il 1 gennaio 1994, data in cui l’inchiostro sul libro di Castañeda, che annunciava la fine della Sinistra e d’ogni attività rivoluzionaria nel continente, non era ancora asciutto. Questo pubblicò velocemente una versione ampliata del Unarmed Utopia con una aggiunta successiva nella quale affermava che il suo punto di vista era completamente giustificato dal fatto che i Zapatisti erano “riformisti armati”. Dal quel momento nella Sinistra latinoamericana cominciò un penoso e lento processo di ricomposizione che fino ad adesso ha prodotto il più sorprendente risultato, l’elezione di Luiz Ignacio da Silva, Lula, un tornitore e sindacalista, che non andò mai all’università e che è diventato il presidente del Brasile. 2. Tendenze economiche nell’America LatinaSecondo le proiezioni dell’ECLAC nel suo Panorama social de America Latina, 2001-2002 (7 novembre, 2001), 214 milioni di persone, quasi il 43% della popolazione dell’America Latina, era povera e tra queste 92,8 milioni (18,6%) vivevano in assoluta povertà. Le proiezioni per l’anno 2002 indicano una crescita dei poveri di circa 7 milioni di persone con 6 milioni in situazione di estrema povertà. La maggior parte dei poveri avranno origine dalla crisi Argentina. Nello stesso modo, c’e stato un declino quasi catastrofico del FDI da $ 84.013 nel 2001 ad appena $ 56.687 nel 2002 (un declino del 33%), con il più grande declino (40%) nella regione de bacino Messicano-Caraibico e il secondo (35%) nella regione Mercosur-Cile (CEPAL, La inversíon en América Latina Y el Caribe. Informe, 2001, p. 21). Inoltre, il debito estero era un fattore significativo per il deterioramento economico della regione, mostrando una forte correlazione tra la crescita in dimensione del debito e degli sviluppi politici.
I risultati dell’Import-export della regione hanno continuato a deteriorarsi nel 2002 come era accaduto negli ultimi anni ed il tasso di disoccupazione era aumentato piuttosto drammaticamente nella maggior parte dei paesi. In Uruguay il 18% (dal 15% nel 2001), in Venezuela dal 11 al 15%, in Argentina è rimasto intorno al 18%, in Brasile è rimasto al 5/6%, in Cile è rimasto a circa 8%, in Colombia dal 16 al 18%, in Messico al 3%, in Perù è aumentato di un punto percentuale a 10% (Latin Focus, www.latin-focus.com). Ciò significa, un aumento generale della disoccupazione in molte delle regioni e si deve tenere a mente che le fonti ufficiali tendono in alcuni casi a sottostimare il tasso di disoccupazione. Secondo l’ECLA (Panorama social de America Latina, 2000-2002, Santiago, Cile 2002) mentre la partecipazione dell’Asia (Giappone escluso) all’economia globale è aumentata dal 15% al 30% nel periodo 1973-2002, quella dell’America Latina è rimasta stagnante al 8%. Al momento il 40% delle famiglie ricevono il 15% del reddito nel continente facendo della regione quella più iniqua del mondo. In Argentina il più ricco 20% (5 milioni di persone) riceve il 53% del reddito totale mentre l’80% della popolazione (31 milioni) riceve il rimanente 47% (Le Monde Diplomatique, novembre 2002). In Bolivia, Brasile e Nicaragua il 20% della popolazioneha un reddito che è 30 volte più grande del del più povero 20% della popolazione. Nel resto del continente questa disparità è solo 20 volte più grande. Per ogni indicatore statistico, il Brasile è il paese più iniquo del continente (Le Monde Diplomatique, novembre 2002). I paesi meno ineguali dell’area sono il Costa Rica e l’Uruguay, con la più equa ridistribuzione del reddito nel continente (e molto verosimilmente per il mondo intero è Cuba). Nell’intero continente circa 150 milioni di persone sopravvivono con un reddito di meno di $ 2 al giorno. Ci sono circa 300.000 persone che hanno beni per oltre $ 1 milione. Al momento ci sono 24 multimilionari in America Latina con un reddito combinato di $ 25 miliardi (il Messico ha 12 multimilionari, l’Argentina ne aveva alcuni ed ora uno solo). Una significativa proporzione di poveri in America Latina proviene dall’esclusione sociale di persone con origine africana ed indiana che, in totale, rappresentano il 40% della popolazione del continente. Le politiche economiche neoliberali non sono l’unica causa principale di questa distribuzione altamente retrograda del reddito. Queste politiche minano, in alcuni casi in maniera catastrofica, la capacità dell’economia nazionale di assorbire gli shock causati dai bruschi movimenti di capitale in risposta alla volatilità dell’economia globale. La crisi brasiliana del 1999, come conseguenza della crisi economica del sudest asiatico del 1997, portò al collasso delle parità del real, la moneta brasiliana, al dollaro e ad un aumento dell’indebitamento di $ 43 miliardi. Quindi il Brasile ha attualmente un debito con l’estero di $ 260 miliardi (dieci volte il PIL di Cuba e circa un terzo del PIL del paese). La crisi del real del 1999 segnò il destino politico di Fernando Henrique Cardoso e spianò la strada alla vittoria di Lula. Si deve ricordare che non esisteva un partito di massa organizzato a livello nazionale come il PT e non esisteva, quindi, alcuna garanzia che i guai economici di Cardoso si sarebbero trasformati automaticamente nel successo elettorale di Lula. Sotto la presidenza di Carlos Menem, anche l’Argentina legò la sua moneta, il peso, al dollaro in una parità letale che stava per portare l’economia allo sfacelo e alla caduta dell’amministrazione di De La Rua, la quale aveva ereditato una serie di difficoltà strutturali associate alle politiche economiche di Menem, il valore del peso crollò e le banche chiusero senza pagare i depositi dei propri clienti. Le province emisero loro monete che circolavano soltanto all’interno dei loro confini e che, per permettere il commercio, dovevano essere cambiate con quelle delle province limitrofe. Furono emesse più di una dozzina di queste monete. Nessun governo potrebbe sopravvivere politicamente se dovesse attuare i rimedi del FMI in una nazione in queste condizioni. Si deve ricordare che fu un’ondata di massa nella protesta popolare a determinare la caduta di De La Rua, il quale, per essere salvato dalla folla inferocita che aveva sfondato i cancelli del palazzo presidenziale di Buenos Aires, fu prelevato dal terrazzo da un elicottero. Uno dopo l’altro, i paesi dell’America Latina sono stati massicciamente indeboliti dall’applicazione delle politiche neoliberali. L’Ecuador per esempio, risentì del doppio impatto della crisi economica messicana e del sudest asiatico, rispettivamente del 1995 e del 1997. La posizione relativamente competitiva del paese e la fuga di capitali trasformarono il paese da un esportatore di prodotti agricoli ad un importatore di eccedenze agricole come il grano, l’avena, le lenticchie, la soia, il granturco, e il latte in polvere dagli Stati Uniti. Quindi nel 1999 il governo di Yamil Mahuad congelò l’equivalente di $ 3,8 miliardi in depositi che rappresentavano i risparmi di una vita di circa 2 milioni di Ecuadoriani i (molti dei quali non li hanno ancora completamente recuperati). Ciò portò ad un inasprimento delle tensioni sociali e alla mobilitazione contro gli austeri rimedi in cui i movimenti indigeni ebbero un ruolo centrale. Fu il vescovo di Riobanda, Leonidas Praño, che con una prospettiva di Teologia di Liberazione, portò avanti, per alcune decadi, un processo di politicizzazione e d’organizzazione delle comunità indigene che condusse alla prima rivolta indigena del 1990. Il movimento è organizzato con una struttura ad ombrello chiamata CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas dell’Ecuador. All’interno di quest’ampio movimento ci sono diverse correnti politiche ed ideologiche ma il suo braccio politico è il Movimento Plurinacional Pachakútik. Ci sono altre strutture con presenza nazionale come il FENOCIN, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, d’orientamento socialista, e il FEINE, Federacíon Ecuadoriana de Indios Evangélicos. Per il 2000 c’erano tutte le condizioni per un’enorme esplosione sociale. Sorprendentemente il 21 marzo 2000, l’esercito e il movimento degli indigeni in una sollevazione che ebbe il supporto dell’80% della popolazione rovesciò il governo e mantenne il potere per circa 18 ore. La questione principale era la dollazizzazione dell’economia Ecuadoriana. Ovunque si guardi in America Latina, esistono condizioni sociali e politiche simili che creano un contesto in cui è fortemente sentito il bisogno di dare espressione politica ad un ampio e vario movimento sociale. Questo è stato il caso del Messico, dell’Ecuador, dell’Argentina e recentemente della Bolivia e del Perù. .
|