![]()
Rubrica
Il punto, la pratica, il progetto
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo.
Reddito Sociale Minimo e disumanizzazione del lavoro Profit State e processi sociali Profit State e Reddito di Cittadinanza Profit State e crisi delle democrazie contemporanee Contro il Welfare dei miserabili Dalla guerra economica USA - UE alla guerra guerreggiata
Tutti gli articoli della rubrica "Il punto, la pratica, progetto"(in tutti i numeri di Proteo)
|
1. La società dell’accumulazione flessibile: un modello di sviluppo a bassa occupazione ed alta flessibilità
Lono circa venti anni che si assiste ad un intenso processo di finanziarizzazione che sta mutando lo stesso modo di presentarsi del modello di sviluppo capitalistico e che spiega cosa sia realmente la globalizzazione. Il contenuto effettivo della globalizzazione è dato non dalla mondializzazione degli scambi ma da quella delle operazioni riguardanti i movimenti del capitale, tanto sotto la forma industriale che finanziaria. All’origine della crescita della sfera finanziaria esistono dei flussi verso questo settore di frazioni di ricchezza che sono nate all’interno della sfera di produzione reale e che, prima di essere travasati nelle diverse forme e trasferiti verso la sfera finanziaria avevano assunto la caratterizzazione di ricchezza determinata nella sfera della produzione reale. Questi flussi sono all’origine di meccanismi di accumulazione perversi, che fanno si che le economie nazionali siano finalizzate al dominio del capitale finanziario diventando parte del rapporto di competizione internazionale tra poli imperialisti, mediati da compromessi all’interno delle organizzazioni sovranazionali del capitale finanziario (G8, BM, FMI, OCSE, BEI, BRI, ONU). Questi processi di globalizzazione a connotati finanziari perseguono semplicemente la loro logica interna tendente alla massimizzazione delle rendite finanziarie senza avere effetti propulsivi sull’economia reale; rendite finanziarie che si assommano a profitti industriali sempre più alti dovuti a immensi incrementi di produttività del lavoro. Tali incrementi in quanto non redistribuiti socialmente hanno accresciuto le quote di ricchezza destinate al fattore capitale, assumendo sempre meno la forma di investimenti capaci di creare occupazione a vantaggio sempre più di dividendi, interessi e capital gain da destinare a speculazione finanziaria o ad investimenti esteri in paesi a basso costo di manodopera. Tutti i parametri macroeconomici rispecchiano quanto sostenuto in precedenza confermando l’andamento dei primi anni ‘90, con in generale tassi di disoccupazione maschile e femminile che aumentano fortemente e retribuzioni dirette e indirette (in termini salariali e di prestazioni sociali) che si incrementano in modo assai lento, senza assolutamente rispondere ad una equa redistribuzione ai fattori produttivi capitale e lavoro degli incrementi di valore aggiunto e di produttività, segnando, infatti, una forte carenza redistributiva verso le forme di remunerazione al fattore lavoro. Per avere un quadro di confronto fra USA e altri paesi a capitalismo avanzato dei più importanti indicatori macroeconomici si veda la Tab.1, in cui si possono leggere i diversi ritmi di crescita complessivi dell’economia.
E’ importante notare ovunque il trend a ribasso sia dei consumi e degli investimenti sia dell’occupazione e dei guadagni orari; inoltre agli incrementi di produttività continuano a corrispondere aumenti nei tassi di disoccupazione. Si tratta in pratica dell’esplosione di un nuovo modello economico che ha colpito fortemente l’andamento occupazionale e dei salari, contraendo la domanda complessiva e associando crescita a disoccupazione. Ad esempio, per il 1998 i paesi dell’area dell’euro hanno registrato un incremento del PIL del 2,9% contro l’aumento del 2,5% del 1997; anche se tale performance è stata la più alta degli ultimi dieci anni, all’incremento del prodotto nell’Unione Europea non è però corrisposto un miglioramento dell’andamento del mercato del lavoro che segnala ancora oltre il 10% medio del tasso di disoccupazione, cioè circa 19 milioni di disoccupati, per non parlare degli altri 13/14 milioni di disoccupati invisibili che “sfuggono” alle rilevazioni delle statistiche ufficiali. Anche per il 1999 le prospettive di sviluppo non possono certo definirsi buone, anche perché i vari organismi internazionali stimano un rallentamento del PIL mondiale che dovrebbe segnalare complessivamente una crescita non superiore al 2%, con un risultato inferiore nell’area dell’Euro (area nella quale la Germania e l’Italia potrebbero segnare uno sviluppo ancora più incerto) ed un ulteriore ristagno dell’economia giapponese, insieme ad una situazione fortemente critica per l’America Latina. Pertanto anche per il 1999 la domanda mondiale dovrebbe essere sostenuta soltanto dagli Stati Uniti, che si ipotizza raggiungeranno un incremento del PIL superiore al 3%, ma con le stesse logiche di dominio colonialista ed imperialista che caratterizzano la loro politica economica, la quale anche per il 1998 ha evidenziato in tal modo una fase espansiva, che dura ormai da oltre otto anni, raggiungendo un aumento del prodotto del 3,9% dovuto ad una alta dinamica degli investimenti, in particolare in attrezzature informatiche e in quel macrosettore che può individuarsi come area produttiva dell’economia di guerra, ed anche a continui aumenti della produttività. Allo stesso tempo gli ultimi dati sulla disoccupazione forniti in questi giorni dall’Eurostat e riferiti a Luglio 1999 confermano i tassi di questi ultimi anni: mentre il tasso di disoccupazione dell’UE-15 è del 9,3% rispetto al 9,9% dello stesso mese dello scorso anno, nella zona euro-11 il tasso è rimasto invariato al 10,2% come lo stesso mese dell’anno scorso; e ciò senza considerare i “trucchi statistici” che inglobano ogni forma di sottoccupati e di lavoratori flessibili e intermittenti fra gli occupati. Per quanto riguarda in particolare l’Italia, la Tab. 2
evidenzia una economia sicuramente in difficoltà, in particolare con forme dirette
o indirette di contrazioni del reddito. Ad esempio, a fronte di un sempre alto
tasso di disoccupazione (costantemente superiore al 12% negli ultimi anni) e
a bassi incrementi occupazionali (dovuti esclusivamente a forme di lavoro atipico,
interinale, part-time, LSU, ecc.) si realizzano nel contempo scarsi incrementi
dei consumi privati, a causa di una contrazione dei redditi da lavoro e una
scarsa propensione agli investimenti privati intern
Si realizza invece, nel contempo un enorme incremento in Italia dei profitti. Infatti, va evidenziata la tendenza alla crescita del margine di profitto negli anni successivi al 1992 dovuta soprattutto alla svalutazione della lira, alla diminuzione dei costi di produzione (principalmente il lavoro) e all’aumento dei prezzi dei prodotti destinati all’esportazione. Sempre in questi anni si è realizzato un incremento del 5,5% della remunerazione lorda del capitale in termini di valore aggiunto, ciò è stato dovuto soprattutto ad uno sviluppo della produttività del lavoro (14%) rispetto a quello del costo del lavoro unitario (5%). L’ultimo rapporto di Mediobanca del 1999, che analizza i dati aggregati di 1755 società italiane (un campione altamente significativo che rappresenta oltre il 40% del fatturato complessivo), dati riferiti all’anno 1998, mette in evidenza quanto già si è sostenuto. Infatti le imprese italiane hanno raggiunto nel 1998 un vero e proprio record per i profitti, con un incremento del 53% rispetto all’anno precedente degli utili netti. Ma ciò è avvenuto senza un corrispondente aumento del fatturato, con investimenti che continuano ad essere inferiori a quelli di dieci anni fa e a scapito dell’occupazione, che prosegue il suo trend ormai pluriennale al ribasso. Per evidenziare soltanto alcuni dati si tenga conto che, per lo stesso campione di imprese e rispetto all’anno 1997, gli utili netti nel 1998 si sono incrementati di 8.000 miliardi di lire, passando da 15.000 miliardi di lire a 23.000 miliardi (nel 1996 gli utili netti erano 10.000 miliardi di lire). In particolare tale incremento complessivo del 53% è avvenuto con pesi diversi rispetto alle tipologie d’impresa: ad esempio l’utile netto delle imprese pubbliche è aumentato del 36% mentre quello delle private del 32%, ed il settore terziario ha evidenziato il miglior risultato con un incremento annuo del 70%. Nel 1998 il giro di affari complessivo ha segnato un incremento totale del fatturato soltanto dell’1% sull’anno precedente, con un 6,9% di incremento del giro di affari nel terziario e una diminuzione dello 0,3% per il totale dell’industria. Inoltre si tenga conto che il mercato interno ha segnato un aumento delle vendite soltanto dello 0,4%, contro il 6% del 1997 a conferma di una domanda interna molto debole, mentre le esportazioni sono cresciute del 2,7%, dato inferiore al 1997 anche a causa di una maggiore dinamica e aggressività da parte dei paesi asiatici. Si noti che il forte incremento dei profitti non è stato, quindi, dovuto a particolari incrementi delle vendite, cioè del fatturato, né a particolari risultati positivi nell’andamento del valore aggiunto, nonostante il netto calo dei prezzi dei prodotti di base e delle materie prime, con un abbattimento sostanziale nel prezzo del petrolio. Se a ciò si aggiunge una buona tenuta del Margine Operativo Lordo Globale, ciò sta a significare che l’incremento degli utili netti, e quindi dei profitti, è derivato da una forte compressione del costo del lavoro, diminuzione dovuta anche ai continui incrementi di produttività senza corrispondenti aumenti salariali. Infatti per il 1998 nell’industria si è avuta una diminuzione del costo del lavoro dello 0,2% e dell’1,7% nel terziario, a ciò si aggiunga che si è verificata una diminuzione dell’1,4% medio nel costo del denaro e l’abolizione dei contributi delle imprese al Servizio Sanitario Nazionale, oltre a una diminuzione complessiva delle imposte sul reddito. Si segnala, infatti, una riduzione dell’aliquota fiscale media di circa tre punti percentuali per il settore dell’industria (che passa dal 53 % al 50%) e di circa l’11% nel terziario (un’aliquota media che passa dal 54% al 43%) e ciò grazie all’introduzione dell’IRAP e della riforma tributaria che ha favorito fortemente le grandi imprese. Tale quadro sta anche a dimostrare una continua tendenza verso i processi di finanziarizzazione dell’economia, in quanto se è vero che i profitti si sono realizzati anche a causa dei minori oneri finanziari e della minore incidenza tributaria, è anche vero che l’elevato importo dei profitti è stato solo in parte correlato a incrementi di valore aggiunto. Pertanto è desumibile che una parte degli utili netti sia da attribuire ad operazioni di rendita finanziaria e ciò è anche confermato dalla mancanza di seri programmi di investimenti, nonostante la riduzione del costo del denaro. Il vantaggio derivato dal calo dei tassi di interesse non ha comportato, quindi, consistenti programmi di investimento interni; infatti gli investimenti tecnici e finanziari delle imprese private italiane continuano ad andare più all’estero che al mercato interno, ciò a conferma del processo intenso di internazionalizzazione che da qualche anno sta interessando le imprese italiane. Tant’è che nel 1998 gli investimenti tecnici delle società del campione sono aumentati globalmente del 5,4%, rimanendo ancora più bassi del 18% di quelli di inizio decennio. Va anche segnalato che per ogni 100 lire di investimenti realizzati nel 1998 ci sono state quasi 39 lire di disinvestimenti; ciò a dimostrare il continuo processo di esternalizzazione produttiva e di delocalizzazione internazionale che fanno sì che le imprese italiane si concentrino soltanto sulla parte del ciclo produttivo ad alti margini e sulle lavorazioni ad alto valore aggiunto, dismettendo le funzioni aziendali e le fasi del ciclo non strategiche a scarso contenuto di know how e quindi realizzabili in quei paesi dove più basso è il costo del lavoro e scarsi sono i diritti del lavoro. Con il quadro rappresentato si evince chiaramente che i vantaggi di cui hanno potuto usufruire le imprese italiane sono rimasti esclusivamente nelle tasche degli imprenditori, dei manager, degli azionisti i quali non hanno “socializzato” in alcun modo le condizioni ottimali di crescita di questi ultimi anni ,e in particolare del 1998, anno in cui si sono registrati i migliori risultati dell’ultimo decennio. Alla crescita dei profitti e della produttività, infatti, non è corrisposto nè incremento salariale, nè miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro, nè diminuzione di orario di lavoro, nè aumenti della spesa sociale (sia in termini quantitativi sia qualitativi), nè infine vi è stato incremento occupazionale. Infatti, sempre in riferimento al campione di Mediobanca, si ha che negli ultimi tre anni sono stati espulsi dal processo produttivo 58.518, lavoratori di cui 19.867 nel 1998, 16.573 nel 1997 e circa 22.000 nel 1996; evidenziando così un intenso processo di deindustrializzazione nel nostro Paese, poiché dei 58.518 posti di lavoro persi ben 54.928 sono in imprese industriali mentre i restanti 3.590 sono lavoratori espulsi dai processi produttivi delle imprese terziarie. Solo nel 1998, sempre in riferimento al campione di Mediobanca di 1755 imprese, si rileva che mentre le imprese terziarie registrano un aumento di 1.400 unità di lavoro essenzialmente nel comparto delle telecomuncazioni per lo sviluppo della telefonia mobile (anche se si tratta spesso di contratti part time e di formazione), le imprese industriali invece evidenziano una perdita di 21.667 posti di lavoro. Si consideri, inoltre, che il lieve incremento registrato nelle retribuzioni dirette è stato ampiamente bilanciato, sempre nel 1998, dall’abolizione degli oneri a carico delle imprese per i contributi al Servizio Sanitario Nazionale e all’incidenza dell’imposizione fiscale che, come si è detto precedentemente, è fortemente variata in senso favorevole alle imprese, soprattutto per quelle di grande dimensione (si parla infatti che con l’introduzione dell’IRAP e della DIT, la Dual Income Tax, le grandi imprese e le banche abbiano risparmiato oltre 10.000 miliardi); va infine considerata anche la diminuzione degli oneri finanziari grazie al calo dei tassi di interesse. In pratica il capitalismo italiano continua ad intascare profitti senza creare opportunità di occupazione, ristrutturando per seguire esclusivamente un’ottica di competitività internazionale basata su processi di delocalizzazione produttiva all’estero, decrementi occupazionali all’interno del Paese, supersfruttamento del lavoro con incrementi degli straordinari e dei ritmi, uso di lavoro nero e precario e con scarsi diritti riconosciuti ai lavoratori, in particolare le nuove figure del lavoro atipico, con flessibilità del salario e del lavoro, con tagli continui alla spesa sociale, quindi con salari reali, diretti e indiretti, sempre a minore capacità di acquisto. Il tutto finalizzato a determinare utili che, nonostante le condizioni favorevoli di cui si è detto, non vengono utilizzati in investimenti produttivi nel Paese ma inseguono la speculazione finanziaria e l’investimento produttivo estero, percorrendo traiettorie verso i paesi dove si può avere un lavoro specializzato a basso costo e a basso contenuto normativo. Per realizzare siffatte trasformazioni diviene necessario agire secondo il cosiddetto principio sociale della flessibilità, utilizzando a tal fine strutture istituzionali che impongono nel sociale il principio del minimo costo e massimo beneficio e realizzando, in chiave sempre più strategica, la logica del massimo grado di adattabilità alle esigenze di un mercato, che è anche mercato del vivere sociale. La flessibilità come principio del vivere sociale significa precarietà e ciò è possibile a partire dalla estensione della flessibilità tecnologica che consente contemporaneamente sia di incrementare la produttività sia di creare flessibilità nella produzione, producendo così una notevole contrazione del volume della forza lavoro e una diminuzione del tempo di lavoro necessario alla produzione. Il lavoro non è disponibile per tutti, e la flessibilità dei rapporti lavorativi rende lo stesso vivere precario e instabile anche per coloro che ancora godono del posto di lavoro più o meno stabile. Quindi ogni forma di garanzia dell’epoca fordista viene completamente eliminata dalla trasformazione produttiva del nuovo modello capitalistico post-fordista dell’accumulazione flessibile. La crisi del sistema lavoro ha modificato sensibilmente la società attuale in quanto si è verificata una disoccupazione strutturale, la fine della fabbrica come centro della produzione, la trasformazione immateriale del lavoro e l’aumento di forme di lavoro subordinato e non normato, sviluppatesi soprattutto tra le fila del nuovo esercito postindustriale di riserva, producendo un travaso dal mondo dei garantiti a quello dei non garantiti. In un tempo in cui le macchine vanno a sostituire la forza lavoro, si intensificano gli interventi tesi a restaurare ambiti di supersfruttamento ancora in una società salariale che intensifica quelle forme contrattuali atipiche (part-time, formazione-lavoro, a termine, ecc.). Il nuovo modello capitalistico sta portando alla scomparsa del lavoro regolamentato e a tempo indeterminato. ma non del lavoro salariato e subordinato. Questo è dovuto principalmente al nuovo sistema economico, che produce quote sempre più elevate di ricchezza con quote sempre più basse di lavoro; ai processi di informatizzazione che producono un grande risparmio di forza lavoro, permettendo così la diminuzione dell’organico dei lavoratori permanenti a tutto vantaggio di coloro che lavorano in modo precario e a tempo parziale e creando un esercito di lavoratori di riserva in pianta stabile. La disoccupazione, la flessibilità e la precarizzazione di salari e delle forme di lavoro diventano così fenomeni strutturali. Il superamento dell’era fordista pone il nostro Paese in una fase di ridefinizione del capitalismo con caratteri post-industriali superando nei fatti le logiche interpretative di tipo industrialista ed “operaista”, per passare ad una gerarchizzazione dei modelli dello sviluppo basata principalmente sulle modalità di trasformazione sociale ed economica che vedono emergere sempre più nuove soggettualità non garantite. Si tratta di una popolazione direttamente o indirettamente legata alla nuova impresa a diffusione sociale nel territorio, la fabbrica sociale generalizzata, determinando una specifica forzata capacità autocontenitiva in relazione a domanda e offerta di lavoro realizzata tramite marginalizzazione, precarizzazione, deregolamentazione ed espulsione dei soggetti economici e produttivi non compatibili. E’ questo ormai di un popolo di disoccupati nuovi ed ex lavoratori dipendenti di fatto precarizzati, non più garantiti nella continuità del lavoro, espulsi dall’impresa madre e assoggettati a una nuova forma di lavoro a cottimo, a supersfruttamento; si tratta spesso di nuove forme di lavoro subordinato, di lavori atipici, fuori dalle garanzie normative e retribuite sociali e assicurative del lavoro dipendente. Si veda come esempio eclatante l’istituzionalizzazione del precariato all’interno della Pubblica Amministrazione con l’impiego a salario e garanzie fortemente ridotti dei Lavoratori Socialmente Utili. Anche l’enorme aumento delle aperture di partita IVA, cioè i nuovi lavoratori autonomi, i nuovi piccoli imprenditori, altro non sono che il risultato della scelta del capitale di espellere manodopera, di creare un indotto a carattere prevalentemente terziario mal retribuito, senza il carico contributivo, di sollecitare un generalizzato ricorso a forme più o meno nascoste di cottimo corporativo da contrapporre ad ogni forma di rigidità del lavoro e retributiva, rendendo tutto flessibile e compatibile al sistema della centralità dell’impresa e del profitto, adattando l’intero corpo sociale, attraverso le funzioni del Profit State, all’organizzazione della fabbrica sociale generalizzata.
2. Dal Welfare State al Profit State
Negli ultimi venticinque anni il modello capitalistico a base keynesiana, in tutti i suoi diversi modi di presentarsi, si è dissolto cancellando lo stesso concetto proprio di civiltà; lo sbriciolamento della intera struttura produttiva preesistente distrugge le stesse forme di convivenza civile determinate dal modello di mediazione sociale di forma keynesiana. In ogni caso qualsiasi sia il modello di capitalismo di riferimento, è chiaro che ormai vi è un’univocità d’intenti attraverso processi di finanziarizzazione e nuove modalità di sfruttamento del lavoro e di ristrutturazione del mercato che determinano esclusivamente processi espansivi dei profitti aziendali. Questo è possibile grazie ad una puntuale funzione manageriale imprenditoriale che sfrutta e si avvale del modello concertativo con un intervento diretto del Profit State, cioè uno Stato come portatore di cultura e di interessi di impresa finalizzati ad un successo misurato non tanto e non solo nella capacità di utilizzo di tecniche, strumenti e comportamenti innovativi, quanto nell’imposizione di modelli comportamentali che sappiano esprimere il più alto livello di coerenza con la programmazione strategica di fondo della cultura d’impresa da trasmettere nel sociale. Il mutamento più profondo si è verificato nel sistema lavoro e nel sistema di protezione sociale. Oggi prevale sempre più e comunque l’economia finanziaria speculativa a danno del fattore produttivo lavoro, sia in termini di attacco al salario diretto e alle condizioni di vita dei lavoratori con aumento dei ritmi, sempre più scarse garanzie e tutele, flessibilità e precarizzazione, sia comprimendo il salario indiretto attaccando sempre più la sfera dei diritti universali attraverso un forte ridimensionamento dello Stato sociale. La trasformazione è sia di tipo quantitativo con una disoccupazione elevatissima, sia di tipo qualitativo, infatti non si può più considerare la fabbrica il luogo della concentrazione del lavoro e della produzione, né lo Stato è la forma di mediazione e regolamento del conflitto di classe. L’intero ciclo produttivo ha scavalcato le mura della fabbrica generalizzandosi alla società intera, lo Stato diventa Profit State in quanto si fa portatore nel sociale nelle sue diverse forme della cultura del mercato e degli interessi dell’impresa. Lo Stato sociale si trasforma in Stato-impresa, in Profit State che assume come centrale la logica di mercato, la salvaguardia e l’incremento del profitto, trasforma i diritti sociali in elargizioni di beneficenza, effettua comunicazione sociale che fa assumere il profitto, la flessibilità, la produttività come nuove forme di “divinità sociale”, come la filosofia ispiratrice dell’unico modello di sviluppo possibile. Il Profit State continua a omaggiare di condizioni favorevolissime gli imprenditori e a operare sconti eccezionali al profitto e ciò non si traduce neppure in miglioramenti di spesa sociale (anche perché diminuisce il peso contributivo delle imprese), né in incrementi di investimenti sul mercato italiano, né in riduzione di orario di lavoro, né in incrementi di salario e in operazioni redistributive a favore del lavoro, né, aumenta l’occupazione. Da quanto esplicitato precedentemente sul ruolo attivo svolto dal Profit State nei nuovi processi di accumulazione flessibile, nella ristrutturazione capitalistica dell’era post-fordista, si capisce immediatamente il perché lo Stato sociale, garante dell’equilibrio tra capitale e lavoro fino agli anni ‘70 (sistema che nella propria struttura integrava le istituzioni del lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla produzione, le organizzazioni di massa) sia stato travolto dalla trasformazione produttiva. La politica dello Stato sociale, fondata sulla struttura stabile della produzione, è venuta meno e la sua organizzazione, con tutte le varie forme di protezione sociale ad essa collegate, da vent’anni stanno subendo un progressivo processo di insabbiamento. Tale politica si è accompagnata alle ipotesi che la disoccupazione non dovesse avere cause strutturali e che quindi i processi di sviluppo sostenuti dovessero essere non assecondati in quanto causa di forte inflazione. L’inizio degli anni ‘90 infatti si caratterizza per un una vera e propria rinuncia alle politiche di sviluppo da parte dei governi e del nuovo pensiero economico liberista. Pertanto l’obiettivo del sistema capitalista così configurato non è più quello della piena occupazione e contemporaneamente inizia un vero e proprio percorso di abbattimento dello Stato sociale visto come un persistere di elementi di “socialismo” derivanti da quel consociativismo che aveva permesso di attenuare il conflitto di classe nei decenni in cui il movimento operaio aveva espresso tutta la sua forza.
|
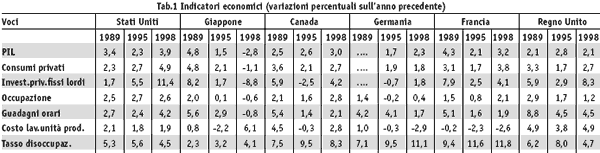
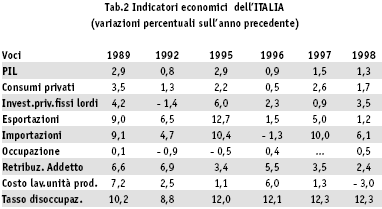 i,
anche perché i capitali fuggono sempre di più all’estero alla ricerca di paradisi
fiscali, di speculazione finanziaria e di costi del lavoro sempre più bassi.
Sempre con riferimento all’ultima rilevazione Eurostat (riferita a Luglio ’99),
l’Italia (con il 12,1%) risulta essere dopo la Spagna (15,7%) il paese in Europa
con il più alto tasso di disoccupazione, e prima in assoluto nel record negativo
della disoccupazione giovanile (32,6% sono i senza lavoro italiani sotto i 25
anni), senza considerare che tale percentuale tocca picchi del 60% in molte
aree del meridione dove il tasso di disoccupazione medio supera il 25%.
i,
anche perché i capitali fuggono sempre di più all’estero alla ricerca di paradisi
fiscali, di speculazione finanziaria e di costi del lavoro sempre più bassi.
Sempre con riferimento all’ultima rilevazione Eurostat (riferita a Luglio ’99),
l’Italia (con il 12,1%) risulta essere dopo la Spagna (15,7%) il paese in Europa
con il più alto tasso di disoccupazione, e prima in assoluto nel record negativo
della disoccupazione giovanile (32,6% sono i senza lavoro italiani sotto i 25
anni), senza considerare che tale percentuale tocca picchi del 60% in molte
aree del meridione dove il tasso di disoccupazione medio supera il 25%.